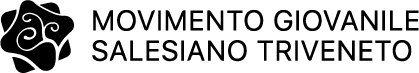Un giorno nel monastero delle suore trappiste italiane in Siria
Reportage da Azeir, dove sorge il monastero di una piccola comunità di religiose italiane. «Più di tutto apprezzano il fatto che noi restiamo qui con loro, in un momento come questo, che sembra non finire mai».

Un giorno nel monastero delle suore trappiste italiane in Siria
AZEIR (confine settentrionale fra la Siria e il Libano). Stanno lì, fra l’arbusto delle rose tutto spinoso e ancora privo di boccioli, e un rosmarino verdeggiante. Modesti fiori color lilla, coi petali lunghi come quelli delle margherite che spuntano fuori da un centro nero e infossato. Si direbbero astri alpini. Dopo un inverno siccitoso, da due giorni la collina è spruzzata di pioggia e pettinata dal vento, e i colori si offrono freddi e introversi. «Forse ti stai chiedendo che senso ha coltivare fiori mentre intorno infuria la guerra. Ma è proprio adesso che c’è bisogno della bellezza. E anche per il futuro. Chi vivrà domani dovrà trovare qui la serenità che viene dalla bellezza».
Marta aggiusta la giacca a vento sull’abito trappista bianco e nero e guarda verso le colline più lontane, quelle dell’interno. L’ultimo profilo in fondo, azzurrino, meno arrotondato e più svettante di quelli intorno, è Krak des Chevaliers, l’antico castello crociato. Per due anni occupato dai jihadisti di Jabhat al Nusra, che vi sgozzavano i prigionieri nella piazza d’armi e poi collocavano le teste decapitate in cima alle torri.
Ventitré milioni di siriani cercano di immaginarsi la loro vita quando la guerra sarà finita. Molti cacciano via il pensiero come un’illusione molesta. Temono che non finirà mai o che loro non riusciranno a vedere i giorni della pace. Ma chi è che mette fra parentesi se stesso e col pensiero corre agli altri, ai siriani che sopravvivranno a questo olocausto che dura da tre anni e a quelli che nasceranno, quelli che saliranno su questa collina, dove oggi echeggiano le artiglierie, e cercheranno il Dio della pace negli spazi silenziosi di un monastero? Quattro monache cistercensi italiane: Marta, Marita, Adriana e Rosangela. Che qui ad Azeir, un piccolo villaggio maronita sul confine col Libano, a metà strada fra Homs e Tartus, hanno cominciato tre anni e mezzo fa a costruire il loro monastero.
In Siria le monache del monastero di Valserena, provincia di Pisa, sono arrivate nel 2005. Hanno vissuto per un certo tempo ad Aleppo, accolte dal vicario latino mons. Nazzaro, e intanto cercavano il luogo adatto per un insediamento.
Nel refettorio di quello che per ora è l’edificio principale del monastero (ma il progetto è di farne la foresteria e di costruire un altro fabbricato per il capitolo, il dormitorio, la biblioteca, la chiesa, ecc.) su un tavolo si scorge un libro: Christian de Chergé: une biographie spirituelle du prieur de Tibhirine. «Questa presenza monastica è il risultato della riflessione iniziata nel nostro ordine, nel ramo femminile come in quello maschile, sulla vicenda del monastero di Tibherine, in Algeria», commenta Marta, la priora.
Nel marzo del 1996 sette monaci trappisti cistercensi dell’abbazia di Nostra Signore dell’Atlante furono prelevati da presunti combattenti islamici e uccisi qualche tempo dopo. Un comunicato attribuito al Gia, il Gruppo islamico armato, quasi due mesi dopo il rapimento annunciò che erano stati sgozzati. I loro corpi non sono mai stati ritrovati: solo le teste decapitate.
Il loro priore era Christian de Chergé, nato in Alsazia quando questa era ancora governata dalla Germania e poi trasferitosi in tenera età in Algeria con la famiglia e col padre militare, comandante di un reggimento di artiglieria in Africa. Un paio di anni prima del rapimento che si sarebbe concluso con la morte, padre Christian aveva scritto una lettera d’addio che doveva rivelarsi profetica. Cominciava così: «Se mi capitasse un giorno (e potrebbe essere anche oggi) di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese». E concludeva: «Ecco che potrò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con lui i suoi figli dell’islam come lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la comunione e il ristabilire la somiglianza, giocando con le differenze. Di questa vita perduta, totalmente mia, e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che sembra averla voluta tutta intera per quella gioia, attraverso e nonostante tutto. In questo grazie, in cui tutto è detto, ormai, della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, amici di qui, accanto a mia madre e a mio padre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e ai loro, centuplo accordato come promesso! E anche te, amico dell’ultimo minuto, che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te voglio questo grazie e questo a-Dio profilatosi con te. E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due. Amen! InshAllah».
«Per noi che eravamo lontane il significato della presenza dei nostri confratelli a Tibherine è diventato chiaro dopo la loro morte», spiega Marta. «Prima di allora, quel monastero era noto più che altro per i problemi che aveva avuto: era stato sul punto di essere chiuso, le autorità avevano limitato il numero dei monaci. Dopo il loro sacrificio, abbiamo sentito la chiamata che veniva dalla loro esperienza: quella di frati oranti che si erano dati in una gratuità totale. Tutto l’ordine si è interrogato. Un primo gruppo di monache di tutto il mondo ha dato la sua disponibilità ad aprire un altro monastero in un paese islamico. Un tentativo in Tunisia due anni dopo è stato ben presto abbandonato. A Valserena io e suor Marita abbiamo sollevato la questione e manifestato la nostra disponibilità. La comunità ha deciso di assumere la fondazione di un monastero in un paese del Vicino Oriente, e insieme alla nostra superiora suor Monica abbiamo cercato. Abbiamo vissuto per alcuni anni in un appartamento ad Aleppo nel quartiere di Maidan, dove adesso c’è la guerra. Poi abbiamo cominciato a costruire qui, dove ci siamo trasferite nel settembre 2010».
Una presenza umile, «oranti fra gli oranti». «L’umiltà ti mette al posto giusto. Altrimenti perdi Cristo». In questa terra la preghiera della maggior parte degli oranti è quella islamica. Come vivere e comunicare la specificità cristiana con questi credenti? Come celebrare l’unità con loro senza scivolare nel relativismo o in un ecumenismo al ribasso? «Sì, quando si parla di dialogo fra persone di religione diversa si rischia sempre di scivolare nell’affermazione che una fede vale l’altra. Ma questo succede quando della fede non si fa esperienza, quando la si riduce a discorsi religiosi», spiega suor Marta.
«O la mia fede prende tutto, cioè è rapporto totale con Dio, oppure stiamo facendo solo discorsi religiosi. Questo è il tempo di manifestare la gioia del mio rapporto con Cristo, voglio fare conoscere a tutti questa gioia, qualunque sia il prezzo da pagare. Perciò non sarò mai d’accordo con chi dice “è tutto uguale, è tutto la stessa cosa”. La mia fede è l’anima della mia vita, e chiedo all’altro di parlarmi della sua. A partire da questo accolgo le parole semplici e sincere dei musulmani che mi dicono: “Abbiamo lo stesso Dio, siamo una cosa sola, preghiamo insieme”. Ma non sarà mai un sincretismo dottrinale: non posso rinunciare a Cristo».
C’è un dettaglio della vita del padre Christian de Chergé che solo i lettori della biografia conoscono: in gioventù aveva avuto la vita salvata da un amico musulmano algerino, Mohamed. Lo aveva difeso da un’aggressione di strada. Il giorno dopo Mohamed era stato trovato ucciso: aveva pagato con la vita il suo intervento in difesa di un infedele. Nel cuore di Christian erano riecheggiate le parole dell’amico, dopo che lui lo aveva ringraziato per il provvidenziale intervento e gli aveva promesso di pregare per lui: «Lo so che tu pregherai per me. Ma sai, i cristiani non sanno pregare!». E Christian era diventato un monaco trappista…
«C’è una bontà di fondo nei cristiani e nei musulmani di questo paese, che è la speranza della Siria», dice suor Marta. Fa effetto sentir dire queste parole dopo una notte percorsa dai tonfi sordi delle artiglierie, confusi coi rumori degli infissi scossi dal vento. I combattimenti attorno alla vicina Zara non hanno conosciuto requie: la pioggia notturna anziché spegnerli sembra averli eccitati. «È proprio quando c’è maltempo che i ribelli muovono le loro forze», aveva avvisato un ufficiale giù al posto di blocco a Talkalakh, sulla strada per venire qui, da poco tornata alla tranquillità. La cittadina al confine col Libano ha conosciuto assalti, battaglie, cambi di padrone sin dal maggio 2011. Da poco è in vigore un’altra tregua. Di notte ribelli arrivano dal Libano, scendono e poi risalgono la stretta vallata di confine, girano attorno alla collina di Azeir e del suo monastero, e si dirigono verso l’interno. Una mattina di due anni fa c’è stata una vera e propria battaglia coi soldati del vicino posto di blocco che è sconfinata nella proprietà del monastero, 300 metri da qui.
«Facciamo la spesa a Talkalakh, ci conoscono tutti e sanno che vogliamo bene a tutti. In corriera le donne, sunnite o alawite, cercano di parlare con noi. Ci confidano i loro problemi: senza conoscerci personalmente, solo sapendo che siamo venute fin qui e restiamo qui per pregare fra loro, si fidano di noi».
I lavori per l’allestimento del monastero sono quasi fermi a causa della situazione generale, ma quando erano in corso coinvolgevano persone di ogni estrazione religiosa. A curare gli alberi e l’orto erano un sunnita e un giovane alawita. «Sembravano proprio padre e figlio», ricorda con struggimento Marta. «È il rapporto personale con Dio che fa cambiare i rapporti fra le persone. È Dio che ci fa essere una cosa sola, ma occorre che ciascuno viva fino in fondo la sua fede. Noi preghiamo e lavoriamo i campi, abbiamo una vita semplice, e questo è un segno che la gente di qui, cristiani e musulmani, percepisce. In cuor loro, avrebbero preferito avere qui delle suore di vita attiva, che aprivano un asilo o un ambulatorio. Ma ammirano la preghiera e ne sentono il bisogno, sentono anche il bisogno di luoghi di preghiera come questo. E più di tutto apprezzano il fatto che noi restiamo qui con loro, in un momento come questo, che sembra non finire mai. La nostra presenza dà a questa gente la forze di restare, e la loro permanenza qui rafforza la nostra decisione di restare. Siamo strette in questo abbraccio».
Rodolfo Casadei
Versione app: 3.46.2 (85a32005)