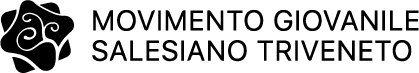«La mia fuga dalla Nordcorea»
Per Shin Dong-hyuk è tempo di valutazioni, anche se non è ancora tempo della pace interiore. Le sue ferite nell'animo sono certamente più profonde di quelle fisiche, frutto delle torture in detenzione durissima.

«La mia fuga dalla Nordcorea»
«Sono passati quasi dieci anni da quando sono scappato dal campo. Durante questo periodo ho avuto momenti difficili, ma sto affrontando un cambiamento straordinario, che allora non avrei potuto nemmeno immaginare. All’epoca non potevo neppure guardare i carcerieri negli occhi, mentre loro passavano dovevo salutarli inchinandomi a novanta gradi. Ora, invece, sento in me la sicurezza che mi permette di guardare i rappresentanti della Corea del Nord senza timore, quando li incontro nelle sedi Onu».
Avvicinandosi il decennale della fuga dal Campo di concentramento numero 14 di Kaechon, il 2 gennaio 2005, per Shin Dong-hyuk è tempo di valutazioni, anche se non è ancora tempo della pace interiore. Le sue ferite nell’animo sono certamente più profonde di quelle fisiche, frutto delle torture in detenzione durissima. In realtà, il trentunenne Shin vive una realtà in bilico. «Non posso dire di condurre una vita normale rispetto a quella del passato. Mi pesa molto il fatto di apparire in Tv e sui giornali – segnala nell’intervista concessa ad
La vita normale, per me, è trascorrere un’esistenza tranquilla. Per esempio, conoscere una donna e sposarla, oppure lavorare come un impiegato, sono le cose ordinarie che voglio provare. Purtroppo non ho potuto godere di questa vita normale fino a ora a causa del mio passato, però sto facendo del mio meglio per trovare una strada adatta alle mie qualità».
Shin aveva quattordici anni quando il fratello e la madre vennero giustiziati, il primo fucilato, la seconda impiccata. In sua presenza, perché proprio lui li aveva denunciati per il tentativo di organizzare una fuga. Nessuno scrupolo, nessun ripensamento per il giovane, perché quelle erano e sono le regole del Campo 14, il più famigerato del Paese. Un decalogo che include indicazioni chiare e senza eccezioni come “Controlla i compagni e denuncia comportamenti inappropriati senza tardare”, “Ognuno deve criticare gli altri per comportamenti inappropriati e anche fare autocritica secondo l’ideologia di classe rivoluzionaria”. Se non avesse denunciato sua madre e suo fratello, Shin sarebbe stato ucciso, come previsto dall’ultima regola, l’unica legge che Shin, concepito nel gulag, conosceva dalla nascita: “La punizione per chi viola le regole del campo è la morte”. «Il crimine che Shin ha commesso è avere uno zio che negli anni Cinquanta è fuggito in Corea del Sud, e nasce quindi nel 1982 dietro il filo spinato, dove la sua famiglia è stata rinchiusa. Non sa cosa sia l’affetto, e affronta le torture e la schiavitù con l’indifferenza di chi deve sopravvivere. Ma dopo cinque anni di fuga – si legge nel libro che ne racconta la storia, tradotto ora in italiano – e la conquista della libertà Shin deve affrontare la prova più difficile: fare i conti con le sue azioni, il dolore, e i ricordi». La sua vicenda esce ora anche in Italia dopo essere già stata tradotta in ventotto lingue. Pubblicato da Codice Edizioni, Fuga dal Campo 14, opera dello Blaine Harden, racconta la storia del carcerato Shin e della sua fuga durata cinque anni fino all’arrivo in Corea del Sud.
«La malnutrizione ha compromesso il suo sviluppo fisico, per cui è esile e piccolo di statura: un metro e sessantasette di altezza per circa cinquantaquattro chili – si legge nel volume –. Le braccia sono piegate ad arco per il duro lavoro a cui era costretto da piccolo, mentre la parte bassa della schiena e le natiche portano le cicatrici delle bruciature provocate dalle torture. Il gancio con cui era stato tenuto sospeso sopra le fiamme (quando cercarono di fargli confessare il tentativo di fuga della madre e del fratello poi giustiziati brutalmente) gli ha lasciato il segno di un foro proprio sopra il pube. Ha le caviglie deformate dai ceppi usati per tenerlo appeso a testa in giù durante il periodo di isolamento. Il dito medio della mano destra è mozzato all’altezza della prima falange, punizione per aver fatto cadere una macchina per cucire nella fabbrica di vestiti del campo. Gli stinchi di entrambe le gambe portano ancora i segni delle bruciature del recinto elettrificato che non è riuscito a trattenerlo dentro il Campo 14». Ironia della sorte, si legge ancora nel libro, «Shin ha grosso modo la stessa età di Kim Jong-un, il paffuto terzogenito di Kim Jong-il divenuto leader il giorno dopo la morte del padre, nel dicembre del 2011» e che ha abbondantemente deluso le attese di apertura e miglioramento dei diritti umani. E la Corea del Nord non resta solo uno Stato atipico, repressivo e minaccioso sul piano militare, ma continua a perseguire un’ideologia e iniziative che sono quanto di peggio la mente umana potrebbe concepire in termini di annullamento della personalità, degrado, sofferenze provocate. In altri termini una completa disumanizzazione, che viene applicata con la pretesa di garantire così un società più evoluta e più giusta secondo le regole del regime più brutale del pianeta.
Il libro che racconta la storia di Shin Dong-hyuk contiene episodi, spunti, che potrebbero apparire solo frutto di fantasia o di estrema sofferenza, se non coincidessero con altre testimonianze dirette e i dati diffusi in rapporti di organizzazioni per i diritti umani. La stesso Alto commissariato Onu per i Diritti umani ha posto sotto accusa per crimini contro l’umanità il regime di Pyongyang, prospettandone il rinvio alla Corte di giustizia internazionale dell’Aia. In realtà, come pure dichiara Shin ad Avvenire, niente potrà sviare il regime dalla sua linea, perché è necessaria per restare al potere. Una questione di vita o di morte per la dinastia comunista dei Kim e per i poteri militari e civili a essi legati. «Anche raccontare la mia esperienza non contribuirà al cambiamento della Corea del Nord. Tuttavia ho la speranza che la mia testimonianza sarà utile quando organizzazioni internazionali e diplomazie chiederanno ai persecutori e al dittatore di assumersi le proprie responsabilità».
Eppure il Campo 14 non è nascosto in qualche recesso montano, ma è un’area estesa quanto la città di Los Angeles, visibile su Google Map, disteso su ondulazioni brulle a poche decine di chilometri da grandi centri abitati, monitorato da satelliti-spia e forse oggetto anche di operazioni ricognitive di servizi segreti esterni. In questo caso, la politica negazionista degli orrori di regime non è applicata, perché il campo è lo spauracchio da mostrare anzitutto ai nordcoreani, lo strumento primo di terrore verso ogni forma di dissidenza, che in Corea del Nord vale anche per il divieto di pratica religiosa o per le proteste spontanee per le dure condizioni di vita di chi abita nelle campagne desolate e non nella capitale vetrina Pyongyang.
«Il dittatore crede che il campo di concentramento sia un’arma molto efficace per mantenere il potere, creando il senso di terrore nel popolo ed eliminando la forza degli oppositori – conferma Shin Dong-hyuk –. È uno strumento che nessun dittatore abbandonerebbe mai, a meno che una forza esterna non lo distrugga».
Stefano Vecchia
Versione app: 3.46.2 (85a32005)