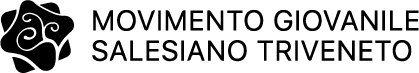Vajont 50 anni dopo. Napolitano: "conseguenza di precise colpe umane". Testimoni...
Nei giorni delle ricorrenze per i cinquant'anni della strage del Vajont, appare sempre più chiaro che il disastro poteva essere evitato.

Vajont 50 anni dopo. Napolitano: "conseguenza di precise colpe umane". Testimonianza di un sopravvissuto
"Quell'evento non fu una tragica, inevitabile fatalità, ma drammatica conseguenza di precise colpe umane, che vanno denunciate". Lo scrive il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato in occasione del 50.mo anniversario del disastro del Vajont, il 9 ottobre 1963. Nel rendere omaggio alla memoria di quanti hanno perso la vita, Napolitano ricorda anche “la tenacia di coloro che ne hanno mantenuto fermo il ricordo” e quanti si sono prodigati nei soccorsi e desidera rinnovare, a nome dell'intera nazione, sentimenti di vicinanza a chi ancora soffre. 1917 furono le vittime di quella notte. ''Questo disastro si sarebbe evitato se una maggiore considerazione della vita umana avesse prevalso su interessi economici e strategici”, ribadisce il presidente del Senato, Piero Grasso, in visita a Longarone, uno dei paesi cancellati dall’enorme massa d’acqua che si abbatté sulla valle a seguito di una frana precipitata dai monti sul sottostante lago e favorita dalla costruzione di una diga sul torrente Vajont. Un libro recente frutto delle ricerche dei due geologi, Alvaro Valducci e di Riccardo Massimiliano Menotti, ricostruisce quanto accaduto sostenendo la sua prevedibilità. Una prevedibilità ormai accertata a tutti i livelli?
Adriana Masotti lo ha chiesto a Gian Vito Graziano, presidente del Consiglio Nazionale geologi:
---
Fu accertata anche in sede giudiziaria, in secondo grado di giudizio però, quello definitivo. A una prevedibilità della frana, e probabilmente a tutto l’aspetto del territorio, non fu dato forse il peso meritato. Noi, con questo libro, con un altro punto di vista – quello di due geologi che vennero qui all’indomani della catastrofe – abbiamo un po’ ricostruito quello che realmente è stato e – attraverso la ricerca delle fonti – siamo arrivati alla conclusione che questa tragedia poteva essere evitata. Il titolo che abbiamo voluto dare “Che Dio ce la mandi buona!”, è un post scriptum del direttore dei lavori: la mattina del 9 ottobre del ’63, quando ricevette una telefonata dalla diga che lo informava che stava crollando tutto, il direttore scrisse immediatamente al suo collaboratore tecnico chiedendo di avviare determinate operazioni di svaso dell’acqua e conclude scrivendo proprio “Che Dio ce la mandi buona”, perché in quel momento percepì che le cose stavano veramente precipitando. Troppi errori: da quando si è iniziata la progettazione, fino all’ultimo giorno quando si poteva far evacuare la gente ed invece non si fece.
In poche parole, ci può sintetizzare le conclusioni dello studio che è stato fatto dai geologi?
Sostanzialmente, lo studio dice: la diga non andava fatta lì, ma – come da prime ipotesi – il corpo diga, quindi lo sbarramento, doveva essere costruito più a monte, in una zona esente da frane. Non ci si è accorti subito, ma solo in corso d’opera, che lì in realtà c’era una frana, anche di notevoli dimensioni. Da una parte ci sono stati geologi che hanno sbagliato perché hanno sottovalutato la situazione, dall’altra geologi che invece videro bene e che allertarono chi però non volle sentire. Soprattutto, ritengo che negli ultimi mesi prima della catastrofe ci siano stati comportamenti contraddittori di chi doveva controllare. Coloro che facevano parte di quegli organismi statali che avrebbero dovuto vigilare e che invece non l’hanno fatto.
In una lapide presso la diga è scritto: “Per negligenza e per sete d’oro”…
Sì, se non si viene qui non si ha realmente la consapevolezza né di quello che è successo, né del fatto che il Vajont è una ferita ancora aperta. Per la gente del luogo quella è stata una strage – un eccidio di Stato, come lo si vuol chiamare – e soprattutto si sentono oltraggiati anche da quello che è stato il comportamento degli apparati burocratici che non hanno mai difeso questa gente, ma in realtà hanno continuato a oltraggiarla. Vivono le sentenze come un ulteriore oltraggio ai sopravvissuti ed alla memoria di chi non c’è più.
Dopo 50 anni, quale insegnamento resta per l’oggi e per il futuro da questo evento?
Rimane moltissimo, perché il Vajont si studia molto, si studia in tutte le università italiane. È un monito da cui è nata la geologia applicata. In qualche modo, la gente rimasta coinvolta ha lasciato ai geologi un’eredità: quella di fare bene, di usare l’etica e non piegarsi spesso ad interessi di tipo finanziario ed economico.
Al di là della vostra buona volontà, quanto in Italia oggi si fa attenzione alla questione della sicurezza legata al territorio prima di dare il via ad opere e costruzioni?
Se guardo alla normativa, perfettibile quanto vogliamo, comunque garantisce che l’opera venga costruita in sicurezza. Se guardo alla reale consapevolezza da parte di chi realizza un’opera, da parte di chi l’approva, devo dire che ancora oggi l’inserimento di un’opera in un contesto territoriale è vista come una parte marginale. Si privilegia molto l’aspetto ingegneristico, tecnicistico, a discapito invece di quello che è appunto l’inserimento nel contesto e quindi la sicurezza. Questo è un fatto più culturale che normativo e ce ne dovremmo render conto tutti. Occorre soprattutto che siano i cittadini a pretendere che questo avvenga.
---
Ma sulla catastrofe del Vajont, sentiamo la testimonianza di Gianni Olivier, di Longarone, uno dei pochi sopravvissuti che ha fatto della memoria di quell’evento l’impegno prioritario della sua vita. L’intervista è di Mara Miceli:
---
All’epoca, avevo 29 anni e facevo il maestro elementare a Feltre, una cittadina a 50 km da Longarone. Quando sono arrivato il mattino successivo a Longarone, quello che ho visto è stata un’apocalisse, un’esperienza allucinante, traumatica, una cosa che resterà nella mia memoria per sempre. Io sono nato ed ho vissuto a Longarone, per cui era il mio paese. Conoscevo praticamente tutti.
In quel periodo, ricordo che una giornalista, Tina Merlin, già nel ’61 perorò persino una campagna di informazione contro la diga. Per tutta la durata dei lavori di costruzione fu addirittura denunciata per questi suoi articoli. Voi come cittadini di quegli abitati credevate a quelle diffuse e pressanti preoccupazioni a opera di esperti, giornalisti, oppure vi affidavate alle perizie rassicuranti del genio civile, dello Stato...
Bisogna fare una precisazione: noi della Valle del Piave, cioè la valle della diga, avevamo una situazione ben diversa dal Comune di Erto che era dirimpettaio alla frana. Gli abitanti del Comune di Erto vedevano la frana e i movimenti che essa aveva, sentivano i boati sotterranei, si accorgevano degli alberi che si inclinavano, ma soprattutto sentivano quelle micro-scosse sismiche, quei crepitii sotterranei che facevano presagire che la montagna si era già messa in movimento. Noi invece a Longarone eravamo all’oscuro di tutto. Infatti, lei sa che in un piccolo paese le maggiori autorità, almeno a quel tempo, erano i carabinieri, il sindaco, i parroci, i medici, i farmacisti… quindi tutta gente che poteva essere a conoscenza di qualche cosa. Il fatto stesso che siano morti tutti con le loro famiglie – il sindaco con la moglie e due bambini, il maresciallo dei carabinieri con la moglie e una ragazzina, i due parroci – fa capire che noi fossimo completamente all’oscuro di quanto stava avvenendo.
All’indomani del disastro, lei come quasi tutta Italia e gran parte del mondo, vi siete precipitati per dare una mano…
Io sono arrivato il mattino successivo verso le sette sulla piana di Longarone e il mio paese non c’era più. Non c’erano più la grande chiesa settecentesca, la stazione ferroviaria, le vie, le piazze, la mia casa… Vedevo solamente le montagne circostanti. Erano loro a farmi da riferimento. La gente che stava arrivando era inebetita e nel frattempo arrivavano i primi soccorritori, in primis gli alpini delle caserme vicine, i vigili del fuoco e poi per giorni e giorni è stato un calvario. Passare tutti i cimiteri della valle, le chiese dove venivano portare le salme, cercare di riconoscere i corpi, perché è un dolore nel dolore anche il non riconoscimento di tutte le salme. Io per fortuna ho trovato i miei genitori e mio fratello. Li ho riconosciuti, so dove sono sepolti. Però, non sono riuscito a trovare altri miei parenti, perché quando i soccorritori trovavano un corpo, nella stessa bara mettevano altri resti umani, per cui noi sappiamo quante bare sono state portate al cimitero delle vittime, ma non sappiamo quanti corpi ci siano in quelle bare. Si calcola che le vittime, i corpi non trovati, potrebbero essere da 250 a 400 e, ancora oggi, sono sotto le ghiaie del Piave o sotto la frana del Vajont.
Dopo 50 anni, il dolore si riaccende ed è forte come in quei giorni oppure il tempo è un formidabile guaritore?
Credo che per il Vajont il tempo non abbia molto lenito il dolore. La nostra è una ferita ancora aperta che rimarrà aperta finché viviamo perché quello che abbiamo visto, quello che abbiamo provato, penso sia un’esperienza che per un essere umano è una cosa allucinante.
Sono trascorsi 50 anni da quello che lei ha definito un “olocausto”. A oggi, avete fiducia nelle istituzioni?
Poca. Abbiamo poca fiducia nelle istituzioni.
Versione app: 3.46.2 (85a32005)