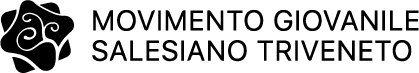Do You Want to Fly With Me?
La recente quanto tragica scomparsa di Kobe Bryant, 5 volte campione NBA con i Los Angeles Lakers, assieme alla figlia Gianna, alla famiglia Altobelli, a Sarah e Payton Chester, a Christina Mauser e al pilota Ara Zobayan sancisce, nel mondo dello sport e non solo, un recupero collettivo dei valori di compartecipazione al dolore e di vicinanza emotiva. Tentiamo di analizzare insieme le possibili ragioni che hanno spinto tutto il mondo, compreso quello social, a una tale manifestazione di affetto a qualche giorno dall’accaduto...

DO YOU WANT TO FLY WITH ME?
Giandomenico Odorisio
La recente quanto tragica scomparsa di Kobe Bryant, 5 volte campione NBA con i Los Angeles Lakers, assieme alla figlia Gianna, alla famiglia Altobelli, a Sarah e Payton Chester, a Christina Mauser e al pilota Ara Zobayan sancisce, nel mondo dello sport e non solo, un recupero collettivo dei valori di compartecipazione al dolore e di vicinanza emotiva. Tentiamo di analizzare insieme le possibili ragioni che hanno spinto tutto il mondo, compreso quello social, a una tale manifestazione di affetto a qualche giorno dall’accaduto…
Domenica sera stavo studiando per un esame, papà stava guardando il big-match Napoli – Juventus, mamma era appena salita in camera per andare a dormire. In lontananza sento il telecronista di Sky che annuncia, durante la partita, una tragica notizia. Nel lasso di tempo che intercorre fra il telecronista che pronuncia letteralmente l’espressione “tragica notizia” e il momento preciso in cui questa viene data dallo stesso cronista, mi passano per la testa numerosi pensieri. Cosa sarà mai successo? Poi, d’un tratto, il fuoco brucia per intero la miccia, la bomba esplode.
Boom!
Viene annunciata la morte di Kobe Bryant, stella 41enne del campionato americano di basket NBA, 5 volte campione con i suoi Los Angeles Lakers. Il tempo si ferma, la matita cade, il cellulare si accende. L’amico Google conferma, è tutto vero.
Qualche minuto dopo, una seconda bomba esplode: con lui c’era Gianna, secondogenita di 13 anni.
Infine esplode l’ultima, disarmante bomba: nell’elicottero altre 7 persone: la famiglia Altobelli, il pilota, Sarah e Payton Chester e Christina Mauser.
Ora, dovete sapere che per la mia generazione, a maggior ragione avendo giocato a basket, Kobe è stato qualcosa di difficilmente esprimibile a parole. Per farvi capire, è stata quel genere di persona in cui ti immedesimavi con il pallone tra le dita, che invocavi ad ogni tuo canestro quando eri bambino e ti allenavi, che vedevi come una delle ultime bandiere rimaste nel mondo sempre più mercenario dello sport: 20 interminabili anni con la stessa casacca, ha vissuto da bambino in Italia, il tuo Paese. Sentirlo parlare italiano faceva quasi impressione. Com’era mai stato possibile che uno dei più influenti giocatori della nostra era potesse effettivamente esprimersi così bene nella tua stessa lingua?
Da piccolo, quando giocavo, avevo un diario di basket che avevano regalato a tutta la squadra in cui giocavo. C’erano le frasi più celebri e i compleanni dei più famosi giocatori NBA: LeBron, Shaq, Wade, Chris Paul, Jordan…e Kobe. Lo conservavo con la sacralità di una Bibbia, portarlo a scuola con i miei compagni era motivo di vanto, i miei campioncini non mi avrebbero mai lasciato, neanche quando i miei amici mi prendevano in giro. Loro erano lì, su quelle pagine di diario, pronti a confortarmi mostrandomi la bellezza di una delle mie più grandi passioni, il basket.
Dicevo, Kobe era esattamente questo, non era come tutti gli altri, per forza di cose volevi essere come lui.
Proprio quella sera, dunque, la matita cade, l’amico Google conferma la notizia. Scende una lacrima e poi un’altra e poi un’altra ancora, fino a quando il pianto prende il posto della commozione. Il mio babbo capisce, ma fino a un certo punto. A partire dalla statura, non è mai stato un fan del basket.
La cosa che mi colpisce è che lui stesso, il giorno dopo, tornando a casa dall’ufficio, passate alcune ore, si rende conto, grazie anche ai discorsi con i suoi colleghi, della portata non solo mediatica dell’accaduto e non solo per la scomparsa di Kobe. Vorrei essere chiaro fin da subito con voi lettori, qui si parla di Bryant per ciò che Bryant ha rappresentato. L’intento non vuole essere di panegirico nè tantomeno cerca di sminuire la portata globale della tragedia escludendo qualcuno per celebrarne a spada tratta un altro.
Così, a distanza di giorni dall’accaduto, tento di ricostruire personalmente le motivazioni che hanno spinto il mondo intero a mobilitarsi per questo avvenimento, a tal punto che mi chiedo come sia possibile che la compartecipazione al dolore si sia estesa anche fra quella parte di pubblico che Kobe non lo conosceva e che non si è mai interessata di basket.
È difficile, anche solo lontanamente, teorizzare una risposta e la mia visione non vuole essere dogma. Credo, tuttavia, che il ruolo lo giochi essenzialmente la vocazione. La vocazione compiuta, intendo, quella matura, la vocazione che ci fa essere lì dove siamo e che ci spinge a dare tutto per ciò che stiamo facendo. Kobe, infatti, non era solamente un grande giocatore: Kobe era prima di tutto un buon padre, un buon marito, un uomo giusto che ha trasmesso la sua rettitudine anche attraverso il gioco e il suo modo di stare in campo, diverso da quello di molti suoi compagni. È un processo che parte dalla persona, forma l’uomo e, infine, consacra il grande giocatore. Bryant, quando era sospeso in aria per una schiacciata, volava. Ma non volava e basta, sembrava ti dicesse: “Ehy man, do you want to fly with me?” e ti rendeva partecipe di quel volo, volavi insieme a lui, eri partecipe della sua vocazione.
Questo aspetto direi quasi “sacrale” ha fatto di Kobe quello che è stato, a tal punto che oggi lo sentiamo intimo, estremamente vicino, e lo ricordiamo con un pizzico di commozione (per quanto mi riguarda, più di un pizzico).
Questo concetto possiamo estenderlo per analogia alle molteplici situazioni della vita in cui siamo chiamati ad operare, non solo nel basket e non solo con Kobe. Un buon padre ti invoglia ad essere padre, il sacrificio di una madre ti sprona a fare altrettanto, l’insegnamento di un buon professore ti stimola ad apprendere per poi restituire.
Questa è la chiave di una porta la cui serratura è difficilissima da aprire, il cui ostacolo è rappresentato spesso dal nostro egocentrismo, dalla nostra sete di realizzazione. Se nella nostra testimonianza qualcuno si sentirà chiamato a fare altrettanto, proprio come Kobe, allora potremmo dire di essere d’esempio, di essere effettivamente chiamati alla realizzazione di un bene che non è nostro e che presuppone una restituzione.
Lo sto scoprendo proprio in questi giorni, con Kobe, con le persone che mi sono vicine, con i miei amici grazie ai quali sto bene, con la mia famiglia.
Per essere lì dove sono.
Do you want to fly with me?
Versione app: 3.46.2 (85a32005)