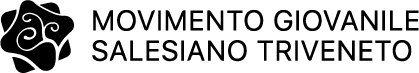Volere e non toccare.
Elogio della moderazione e dell'epoché non tutto deve sempre e per forza diventare carne. Il nostro attuale problema è soprattutto un'assenza totale del limite... Vedo intorno a me genitori che nel weekend ospitano il ragazzo della figlia offrendo loro la camera matrimoniale, mamme che fanno personalmente il letto alla giovane coppia scegliendo le lenzuola migliori...


Volere e non toccare.
da Quaderni Cannibali
del 18 luglio 2006
 
 
 
Concupire significa desiderare molto, fortissimamente, oltremodo. E’ implicito un eccesso, un’idea di troppo. Tutta colpa di quel cum iniziale che rende intensivo il verbo cupio, di per sé innocuo, naturale, lecito: il desiderio è la molla stessa del nostro essere e di tutte le nostre azioni qui sulla terra. Desidero, dunque sono.
Va bene. Ma oggi desideriamo troppo, non abbiamo limiti. Ci hanno abilmente educati a questo, almeno dagli anni Settanta: edonismo, consumismo, quel che Pasolini definiva “laicismo consumistico”. Siamo abituati ad avere tutto e a consumare per puro piacere, senza orizzonti metafisici, tutto piatto, presente, terreno. E senza limiti.
Il nostro attuale problema è soprattutto un’assenza totale del limite. Ci manca un freno. O meglio, possediamo ancora qualche freno, ma ben misero, strettamente oggettivo, tecnico: alcuni piccoli deterrenti senz’anima. Ad esempio, se desideriamo dieci vestiti nuovi, probabilmente riusciremo a comprarne solo due in base a considerazioni di tipo economico: il nostro stipendio non ce lo permette, fine. Allo stesso modo, se desideriamo due piatti di pasta e tre dolci, potremo agevolemente limitarci a un solo primo e un solo dessert in nome della nostra linea e della tanto agognata taglia 42. Ci autoimponiamo un rigore che però non ha nulla di morale o ideale. E’ un finto rigore, in realtà è l’altra faccia del nostro opportunismo: è opportuno, è più conveniente (per le nostre tasche e per il nostro peso) comprare pochi abiti e mangiare poca pasta, tutto qui.
Con il sesso la questione si complica. Se incontriamo una persona che fortemente ci attrae, quale freno mai dovremmo invocare per non cedere al naturale impulso di possederla hic et nunc? Perché potrebbe essere più opportuno e più conveniente farne a meno? Tutte le immagini da cui siamo quotidianamente bombardati, tivù e pubblicità in testa, ci invitano a non porci dei limiti. Forse ci resta, ma non a tutti noi, qualche remora di carattere salutistico, una sottile paura del contagio infettivo… Ma nulla di più alto, credo.
Ha vinto un’ottica laica non religiosa che riconosce nella felicità personale l’unico diritto per cui valga la pena battersi. Il solo principio riconosciuto è che il nostro piacere non leda la libertà altrui. Il famoso principio del danno a terzi.
Così, ci capita di vedere persone gentili e compìte chiedere se possono fumare una sigaretta e se la cosa disturba o no. E contemporaneamente quelle stesse persone non farsi il minimo problema, pur essendo sposate o stabilmente conviventi, a intrallazzarsi amenamente con altri partner. Chiediamo il permesso di fumare, ma non di avere un amante. Evidentemente riteniamo che il fumo passivo sia un grave danno per il nostro prossimo, mentre non lo sia per niente l’infedeltà coniugale. Bizzarro. Riusciamo a limitare il nostro piacere del fumo, ma non il nostro piacere sessuale.
Pensiamo inoltre all’educazione che stiamo impartendo in questo campo ai nostri figli. Noi genitori oggi non siamo più in grado di contenere le loro esperienze sessuali almeno al di sotto di una certa età; di fronte alla figlia quindicenne che si fa il coetaneo di turno, non sappiamo come reagire. Oscuramente sentiamo che non è bene, che dovrebbe astenersi, ma fino a dove, fino a quando, e in base a quali principi noi possiamo onestamente dirle di soprassedere? Fino alla maggiore età? Fino a che abbia concluso il ciclo di studi liceale o universitario? E perché? Non è forse naturale che abbia un ragazzo? Vogliamo forse reprimerla, inibirla, traumatizzarla, fino a mandarla un giorno in analisi?
Ci blocchiamo difronte alla definizione di ciò che è bene e ciò che è male, o meglio, abbiamo la certezza che nulla sia veramente male. E allora? E allora vedo intorno a me genitori che nel weekend ospitano il ragazzo della figlia offrendo loro la camera matrimoniale, mamme che fanno personalmente il letto alla giovane coppia scegliendo le lenzuola migliori. Se ne parliamo un po’ inquieti tra di noi, subito ci troviamo splendidi alibi: meglio che lo facciano qui in casa che per strada o chissà dove, almeno sono al sicuro. Ineccepibile. Mi viene da pensare al nostro attuale atteggiamento verso l’uso delle droghe: le stanze del buco non appartengono forse alla stessa filosofia del limitare il danno?
 
* * *
 
Abbiamo oggi un semplice problemino di freni. Non sappiamo frenare. Siamo impotenti e incapaci di trovare le ragioni di un qualsiasi freno. L’antico motto “est modus in rebus” è lontano mille miglia. Noi, il modus, non sappiamo nemmeno più cosa sia.
In realtà il concetto di moderazione è un concetto difficile e, se vogliamo, assurdo. Non si tratta di non soddisfare un desiderio, ma di soddisfarlo poco, non del tutto, non… smodatamente. E’ una sorta di sordina, la moderazione, un sentire la radio ma a basso volume e non a tutte le ore. Con dei limiti.
Non è la rinuncia. La rinuncia è ascetica, metafisica, assoluta. Non ammette compromessi o mediazioni. Rinunciare vuol dire scegliere di non avere, farne a meno del tutto e per sempre. Mettersi su un altro piano, in un altro mondo, dove i valori, le qualità e i premi sono altri. Un altro pianeta. Il pianeta dei mistici, degli artisti, dei santi, dei poeti…
La moderazione invece è più umana, fa parte di quella medietas – o aurea mediocritas, di cui parlava Orazio – che sarebbe un felice stare in mezzo. Essere medi. Né alti né bassi, né poveri né ricchi, né belli né brutti. Il regno dell’un po’, dell’in parte, del moderatamente.
Può ancora essere proponibile tale medietà? Risulta ancora un valore o l’epoca oraziana è finita per sempre? Perché limitarci nei desideri, premere sul freno, moderarci dovrebbe essere un bene? Perché avere poco invece che tanto, comprare due invece che dieci, avere un uomo e non tre?
 
* * *
 
Perché tutto ciò sia considerato un valore, noi dovremmo dare valore ad alcune altre cosucce che mi par di vedere piuttosto latitanti nel nostro mondo. Ad esempio Dio.
Quand’ero piccola, mangiavo poco cioccolato non solo perché, mi diceva mia madre, il cioccolato fa male alla pancia, ma anche perché inconsciamente dentro di me mi nasceva il pensiero che avrei fatto un po’ dispiacere a Dio. Perché la cioccolata era un puro piacere, e del puro piacere, fine a se stesso, gratuito, in fondo immeritato, io dovevo render conto a Dio. Cosa gli davo in cambio? Ecco, c’era l’idea di uno scambio. Se mangiavo tanta cioccolata, dovevo in qualche modo riparare facendo qualcosa di meno piacevole, di doveroso e necessario, possibilmente utile agli altri. Potevo pulire casa, lavare i piatti, andare a letto alle nove senza guardare Carosello, aiutare la compagna a fare i compiti, fare la spesa all’anziana vicina di casa. Doveri autoimposti, se non vere e proprie autopunizioni. Sì, ci si autopuniva. Ci si autoregolava, ovvero ci davamo personalmente regole: in noi abitava un’autorità sconosciuta ma imperiosa, era dentro di noi, eravamo forse noi stessi, miracolosamente la stessa persona colei che comandava e colei che obbediva. Un capolavoro di disciplina morale!
Restando sul cioccolato, va detto che noi lo mangiavamo insieme al pane. Particolare non di poco conto. Il pane rallentava l’eros. Annacquava, diminuendo il piacere, il fuoco della passione. In una parola riequilibrava, immetteva un segnale di equilibrio. Se, da una parte, eccedevi nel piacere con il cioccolato, dall’altra frenavi con il pane. Quando da piccola andavo in colonia, ci davano di merenda pane e cioccolata solo la domenica e lì ho potuto agevolmente studiare il ventaglio di possibili comportamenti psicologici che si apriva tra di noi: c’era chi, ingordo, mangiava prima il cioccolato e poi si purificava con il pane; chi mangiava prima il pane e poi il cioccolato secondo l’antico detto “prima il dovere poi il piacere”; chi tutt’e due insieme, dando prova di formidabile fermezza emotiva; chi, futuro politicante, mangiava solo il pane e si conservava la barretta di cioccolato per futuri e più vantaggiosi scambi con amici; chi infine faceva il cosiddetto “fioretto”: faccio il fioretto di non mangiare cioccolato per tre mesi, così Dio mi aiuta a passare un esame, così Dio mi fa guarire, così mia nonna non muore. Avevamo una grande fiducia in Dio, ma ancor di più nel nostro “pagamento” a Dio. C’era l’idea che dovessimo qualcosa per avere qualcos’altro. Forse i sacrifici dei popoli antichi non ci erano così lontani: in fondo loro sacrificavano sull’altare pecore e buoi per le stesse ragioni… Sacrificium: rendere sacro qualcosa. Oggi ci è difficile riconoscere una sacralità a qualche nostra azione…
Oggi, che non immoliamo più capretti agli dei e non andiamo più in colonia, cercherei comunque di frenare un po’. Per noi stessi e per i nostri figli. E’ solo più difficile, ma ci proverei a mettere dei limiti. In fondo, a ben guardare, Dio aveva vietato solo una mela a Adamo ed Eva, per il resto potevano mangiare una infinità di altri frutti; probabilmente, anche per Lui, era solo il tentativo di porre un limite: quella mela no.
Certo, il problema oggi è trovare una ragione che spieghi il perché di un limite. Facile con i limiti di velocità: non andare oltre i 100 se no ti schianti contro un muro. Più difficile dire al figlio: non cambiare ragazza tutte le settimane; e alla coppia di giovani sposi: cercate di non farvi troppi amanti. Se ci chiedono perché, siamo sicuri di saper rispondere? Complicato aver tolto Dio dalla nostra vita. Arduo vivere in un mondo disertato dalla divinità.
Vorrei comunque tentare di trovare una ragione ai limiti e dunque fare un elogio della moderazione, anche senza tirare in ballo Dio.
Proporrei la sospensione, l’epoché. Almeno di tanto in tanto.
Faccio un esempio. Stare davanti a un uomo, metti in un bar, al ristorante, in un salotto, e lasciarsi prendere dal piacere della sua presenza, arrivare anche a gustarsi mentalmente un’aria di reciproca seduzione, e stop, fermarsi lì. Non agire, non richiamare il giorno dopo, non accettare l’invito a cena. Lasciar cadere, sorridere. Il sorriso è un gesto sospeso per eccellenza.
Non per rinuncia o per paura o per viltà. Ma perché il mondo mentale raggiunga la sua massima potenza. Per esaltare un incontro senza sprecarlo in vili commerci, in immediati consumi. Lasciare che agisca nella mente, anche inconsapevolmente, e che assuma le fattezze di un pensiero e basta. Non tutto deve sempre e per forza diventare carne. Abbiamo anche la mente: esercitiamo anche quella, perché no? Può essere una valida alternativa, fa parte della rosa delle infinite possibilità che l’essere umano ha a disposizione. Perché appiattirci su un’unica modalità di rapporto con il reale…? Si tratta solo di ridare valore al pensiero, alla nostra potenza immaginifica, che sa creare altri mondi. Non accontentarci di questo mondo. Troppo ristretto, solo materiale.
E’ per ignoranza, per povertà intellettuale che consumiamo gli amori. Davvero non sappiamo far altro che toccarci, vederci in camere d’albergo, prenotare i nostri poveri incontri per telefono (col rischio d’essere intercettati…)? La concupiscenza, come unico approccio al reale, diventa la nostra condanna.
Prendiamo, acquistiamo, possediamo. Come prendiamo dallo scaffale del supermercato il vasetto di tonno, il pacco di biscotti, l’ennesima confezione di noccioline sottovuoto. Prendiamo tutto quel che ci attrae e anche quello di cui non abbiamo veramente desiderio, così, per il puro gusto di prendere.
Afferrare, consumare, avere. Tutto questo è la negazione della mente, di un mondo superiore e astratto dove vale esattamente la regola contraria: dove nulla si può prendere e dove le cose, anzi, perché continuino a esistere, non devono essere mai né toccate né prese.
Avere la forza di non toccare e non prendere. Astenersi, avere un modus, una medietas: stare in mezzo, che non vuol dire non stare, non essere, non esistere; vuol dire mettere uno spazio, sospendere l’azione. Questione di equilibrio, anche... A poker diciamo: passo, quando non giochiamo quella mano. Passare, astenersi. (Che strano, astensione e astinenza hanno la stessa radice in un verbo che significa “tenersi lontano”, mettere distanza. Astinenza sessuale come astensione elettorale…? mah!).
Lasciar passare, lasciar cadere, lasciar perdere.
Lasciare che non accada: sospendere, tenere in sospeso un incontro, una storia, un amore. “Le rose che non colsi” di gozzaniana memoria, “quel che poteva essere e non è stato”. Ebbene sì, possiamo anche non coglierle le rose. Non stiamo parlando di frustranti e patetici ascetismi, bensì di sublimazione. Sospendere è sublimare. Tornare al mondo delle idee; riappropriarsi della funzione immaginativa.
Michelangelo diceva: “Amore è una bellezza immaginata o vista dentro al cuore”. Prima di lui secoli di platonismo e secoli di poesia lirica, dall’amor de lohn dei poeti provenzali, ai siciliani che parlavano dell’immagine di lei dipinta nel cuore, fino alla Laura- lauro-l’aura di Petrarca. Tutto a partire da quel mitico Orfeo che canterà ancor meglio la sua Euridice proprio quando l’avrà persa per sempre nel mondo di Ade. L’altezza della nostra letteratura nasce lì: da una mancanza, da un’assenza. Da una concupiscenza frenata e dirottata. Credo che tutto questo oggi andrebbe rivalutato, contro l’attuale abnorme e volgare potere della presenza, della concretezza, del corporeo e della totale e costante (e spossante!) realizzabilità del desiderio.
Sarei per lasciare, qualche volta, irrealizzato il desiderio: perché si espanda e tragga più forza dal suo rimanere sospeso. Un desiderio che diventa aria invade l’universo: è più potente.
Non è dunque la società di massa, la televisione o la civiltà dei consumi il nostro vero nemico. E’ la nostra povertà culturale, l’insipienza intellettuale, la nostra ormai irreversibile incapacità di immaginazione. Non abbiamo più una vita mentale – laica o religiosa che sia, non importa –, non sappiamo più immaginare la vita e non ci resta quindi che toccare, palpare, mordere, comprare, possedere. Qualche ora con la fanciulla compiacente di turno e via: abbiamo mangiato ancora una volta la mela (ovvero la barretta di cioccolato). Così ogni volta ci autocacciamo dall’Eden.
 
* * *
 
Mi è capitato, giorni fa, di andare in barca a vela. Zigzagare tra un bordo e l’altro senza meta, assecondando il vento. Andare a vela è un assoluto mentale: se metti su le vele, di colpo smetti di avere una meta, non importa più, ti lasci portare e basta; se rimetti il motore, torni ad avere una meta precisa, che vuol dire volerla raggiungere: desiderarla, possederla.
Andare a vela è decidere di non possedere, volere altro, senza un fine perché il fine è già tutto lì, nell’andare a vela.
Accanto mi è passato un gommone, uno di quegli enormi e velocissimi gommoni neri pieni di sub semivestiti delle loro tute nere e bombole. Sfrecciavano a supervelocità (inferendo un’evidente ferita al mare, che noi chiamiamo serenamente scia…). Perché vanno così veloci? mi sono chiesta. Semplice, perché hanno una meta da raggiungere: il punto di immersione.
Vorrei che andassimo di più a vela. E leggessimo di più i poeti provenzali (piccolo consiglio di lettura che mi permetto di dare a tutti, ma soprattutto ai Vittorioemanuele e ai Salvosottile di questo mondo). Non per riconquistare l’Eden (quello è perduto per sempre, ahimè), ma per riposarci dalla terribile fatica di questa nostra perenne e forzata concupiscenza, da questo continuo dover essere che il nostro piacere individuale ci impone. Siamo circondati da una marea di cioccolato (senza pane!) e da una giungla di rose, non ne possiamo più; vorremmo non dovere mangiare di continuo né dover cogliere infinite rose; vorremmo la libertà di poter dire no grazie, non ne ho voglia, ho altro da fare.
Sospesi, stare in mezzo. In mezzo al mare, per esempio. Un mare sgombro di mete, senza terre, boe… o sirene di plastica, da raggiungere a ogni costo. 
 
 
Fonte: www.ilfoglio.it
[ <-- Particolare della scultura “Apollo e Daphne” di Gianlorenzo Bernini  ]
Paola Mastrocola
Versione app: 3.46.4 (19a31e64)