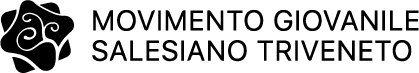Testimonianze: la pietra di Gregoire
La storia di un uomo che sa cosa significhi perdere tutto e grazie a ciò ha capito che, se non si ha attenzione per i poveri non si ha nulla veramente. Forse cercava la felicità nel possedere, ma fu una ricerca che lo condusse sull'orlo dell'abisso...


Testimonianze: la pietra di Gregoire
da Quaderni Cannibali
del 07 maggio 2012 (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 
          Gregoire è un gommista originario del Benin, partito nel 1971 per la Costa d’Avorio in cerca di fortuna. Lì ha appreso il mestiere, conquistando in poco tempo la fortuna economica e guadagnando molti soldi, grazie anche alla sua intraprendenza. A 24 anni divenne uno dei pochi ragazzi che poteva vantare la proprietà di un’automobile. Ma il denaro non rimase a lungo nelle sue tasche.
          «Non saprò mai spiegare come mi è accaduto di perdere tutto. Ho persino pensato di uccidermi; ero sposato e avevo due bimbi; ho conosciuto la miseria. Ma in queste difficoltà ho trovato il cammino della chiesa». Un cammino che Gregoire aveva dimenticato negli anni della fortuna. «Ero stato un bambino cristiano, – racconta - amavo molto Dio, ma una volta fatti i soldi avevo girato le spalle alla fede. L’incontro con un missionario mi ha aperto gli occhi: per la prima volta ho sentito che i miei problemi erano diventati i suoi, mi sentivo compreso e accompagnato. In quello stesso periodo quel missionario stava organizzando un pellegrinaggio a Gerusalemme e mi ci ha portato. Durante una delle sue omelie, disse che ogni cristiano deve partecipare alla costruzione della Chiesa portando la propria pietra. Così mi domandai quale pietra potevo portare io. Tornato in Costa D’Avorio ho condiviso le mie riflessioni con mia moglie; ho cominciato a pregare e mi è venuta l’idea di creare un gruppo di preghiera. Una delle otto persone che ne facevano parte, un giorno ci parlò di un bimbo musulmano in fin di vita e decidemmo così, in accordo con la sua famiglia, di andare a trovarlo per pregare per lui. Non poteva più stare in ospedale perché il ricovero costava troppo. Pregammo accanto al bambino, poi rientrammo a casa. Il giorno dopo sapemmo che il ragazzo si era ripreso e aveva chiesto di mangiare; alla fine guarì.
          Abbiamo cominciato con l’ospedale generale di Bouakè: i ricoverati erano contenti di vederci, di pregare insieme. Avevano incontrato solo protestanti; erano stupiti di vedere dei cattolici far visita agli ammalati. Incontrammo presto anche persone che non potevano pagare le cure: erano abbandonate in alcune sale, senza assistenza. In Africa si paga tutto, così i poveri non sono curati. Dovevamo fare qualcosa per dimostrare il nostro amore: così iniziammo a lavarli, a pagare, quando ci riuscivamo, le spese mediche e il cibo.
          Ero in cerca di Gesù nei poveri, le persone di cui Lui aveva particolare cura; così ho deciso di andare anche nelle carceri. Il gruppo di preghiera nel frattempo si era ingrandito, ma non tutti volevano avvicinare i carcerati. Ma il Vangelo non si sceglie a pezzi: Gesù si è identificato con i prigionieri. L’incontro con questa realtà ha sollevato in noi un senso di rivolta: carceri per 150 persone ne contenevano 500, senza bagni, senza infermeria.
          Il direttore del carcere ci ha permesso di aprire un’infermeria, poi abbiamo cominciato a preparare i pasti perché c’era un’alta mortalità a causa del cibo. Da 1000 decessi l’anno siamo passati a 6-7 morti. E’ dal 1986 che la nostra associazione cura i malati in prigione.
          Poi è venuto l’incontro con i malati di mente: sono i dimenticati tra i dimenticati in Africa, li trovi nudi per strada, che frugano nell’immondizia e tutti hanno paura di loro, perché si ritiene che siano posseduti dal demonio. Ne avevo paura anch’io, ma un giorno ho visto un uomo, nudo, che stava cercando da mangiare nei rifiuti, e un pensiero mi ha attraversato la mente: cerco Gesù Cristo nelle chiese, nei sacramenti, nei gruppi di preghiera, ma costui è Gesù stesso che soffre. Come se qualcuno mi stesse parlando, ho sentito interiormente: “Ma se sono Gesù Cristo, perché hai paura di me?”. Ho cominciato allora a cercare questi malati nelle strade, di notte, per capire come vivevano, dove si rifugiavano. Pian piano ne ho conquistato la fiducia: incontrandoli ho scoperto che sono uomini e donne che, come tutti, vogliono essere amati. Ne ho parlato con mia moglie che mi ha aiutato a preparare cibo e acqua da portare loro. E dopo un po’ ho capito che si doveva fare di più. Nell’ospedale di Bouakè c’era un vecchio bar, che è diventato, su nostra richiesta, la cappella dell’ospedale e dove abbiamo cominciato a riunire i malati mentali, a trattarli con dignità e curarli. Poi un ministro della Sanità in visita all’ospedale ci ha concesso altri 2400 metri quadri dove abbiamo costruito il centro di accoglienza. Presto si è diffusa la voce sul nostro impegno e i religiosi dei villaggi hanno cominciato ad invitarci a vedere cosa accadeva nelle loro comunità.
          Abbiamo scoperto una realtà inenarrabile: vere e proprie torture a danno dei poveri malati, incatenati a un muro o a un albero anche per 20 anni e più, perché epilettici o schizofrenici. Una delle immagini che mi porto dentro è un uomo bloccato ai piedi con le catene fissate al pavimento, le braccia legate con fil di ferro, da anni costretto in quella situazione. Con una suora infermiera abbiamo provato in tutti i modi a staccarlo, ma i ferri erano ormai dentro la carne e il corpo si stava imputridendo. Solo con delle tenaglie siamo riusciti a liberarlo, lo abbiamo allora lavato e medicato. Ricordo che disse: “Non so che colpa ho per meritare questo trattamento dai miei stessi genitori, eppure non sono cattivi. Per quello che avete fatto ora non so come dire grazie a Dio”. A incatenarlo era stata la sua famiglia, per ignoranza verso l’epilessia di cui il ragazzo soffriva. Poco dopo morì a causa dell’infezione.
          Nei nostri centri (oggi sono 16 distribuiti in Costa d’Avorio, Benin, Burkina Faso, per un totale di 1200 malati) diamo assistenza e cura fino alla reintroduzione dei pazienti nelle loro famiglie. Abbiamo già reintegrato 16mila malati e li seguiamo grazie alla rete delle parrocchie e dei religiosi».
Versione app: 3.46.4 (19a31e64)