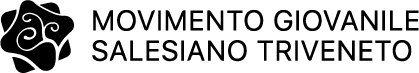Proposta Pastorale: Accompagnati dallo Spirito
Orientamenti della Proposta Pastorale
Nella seconda parte della Proposta Pastorale di quest'anno, vi sono i grandi orientamenti in vista dell’azione educativo-pastorale nelle nostre realtà salesiane.

Impariamo a camminare insieme
«Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?» (At 11,17)
Un terzo orientamento che s’impone alla nostra attenzione ci invita a riscoprire a tutto tondo l’idea e la pratica dell’accompagnamento. Anche questa, del fare strada insieme e del condividere il pane (cum pane è la radice del termine “accompagnamento”, che ci invita quindi a condividere il meglio di noi stessi), è una struttura carismatica originaria. Don Bosco ha camminato insieme ai suoi giovani, accompagnandoli sulla via della santità. Perché è chiaro che «l’essere in comunione con Gesù Cristo ci coinvolge nel suo essere “per tutti”, ne fa il nostro modo di essere. Egli ci impegna per gli altri, ma solo nella comunione con lui diventa possibile esserci veramente per gli altri, per l’insieme» (Spe salvi, n. 28).
Riscoprire tutte le rifrazioni dell’accompagnamento è oggi più importante che mai. C’è un accompagnamento di ambiente, che fa leva su uno stile educativo condiviso che dà il tono e la temperatura ad una realtà pastorale; c’è un accompagnamento di gruppo, che ha cura dei legami di un numero minore di persone che condividono interessi, passioni e intenzioni apostoliche; c’è infine anche un accompagnamento spirituale personale, che aiuta a scoprire la propria missione nel mondo a livello individuale.
Cornelio, Pietro e il Signore di tutti
Negli Atti degli Apostoli è narrato un lungo e articolato episodio che ha come protagonisti Cornelio, un centurione romano di stanza a Cesarea marittima, e Pietro, il primo degli Apostoli. Il testo occupa tutto il decimo capitolo degli Atti e parte dell’undicesimo. Se lo leggiamo con attenzione, ci accorgiamo che è un racconto di due conversioni: quella di Cornelio, che da uomo religioso e timorato di Dio diviene cristiano, e quella di Pietro, che deve allargare il proprio sguardo raggiungendo le ampiezze e le profondità di una rivelazione che sempre lo stupisce e gli chiede di ampliare i suoi orizzonti, spingendolo ad abbracciare il mondo intero.
Ciò che qui è importante per noi è leggere i testi da una prospettiva specifica: quella dell’accompagnamento. Essa ci dice che da un punto di vista individuale e autonomo non è possibile arrivare a cogliere le prospettive che Dio ha in mente per noi. C’è una catena di legami che è necessario valorizzare per arrivare a rispondere pienamente alla chiamata di Dio. Proviamo a sentire la prima parte del testo per intuire quanto sia importante comprendere il senso dell’accompagnamento:
1Vi era a Cesarèa un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte detta Italica. 2Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia; faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. 3Un giorno, verso le tre del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo: “Cornelio!”. 4Egli lo guardò e preso da timore disse: “Che c’è, Signore?”. Gli rispose: “Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di te. 5Ora manda degli uomini a Giaffa e fa’ venire un certo Simone, detto Pietro. 6Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare”. 7Quando l’angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini; 8spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa (At 10,1-8).
Di fronte alla buona disposizione del cuore di Cornelio, la prima forma di accompagnamento arriva dall’alto. Un angelo gli viene incontro e lo chiama per nome. Essere chiamato per nome – per la Bibbia questo dice conoscenza personale e soprattutto quanto siamo unici al cospetto di Dio – è il primo passo per accompagnare: conoscere la storia, entrare in una relazione personale, essere accolti nella propria singolarità.
Ma il testo ci fa fare un passo avanti: l’ascolto della sua disponibilità religiosa è accolto dalla Chiesa e rimandata all’accompagnamento della Chiesa stessa. L’angelo lo invita a mandare alcuni suoi servitori a Giaffa per convocare Pietro. Dio si serve degli uomini, indica dei mediatori, rivolge il suo sguardo alla propria Chiesa. Non è sufficiente la chiamata di Dio, essa va confermata dall’istituzione ecclesiale, che ha il compito di ascoltarla, discernerla e confermarla.
Se andiamo avanti nel racconto vediamo che Pietro, mentre quegli uomini lo stanno raggiungendo, ha una visione che si ripete per ben tre volte e che gli allarga gli orizzonti: è invitato a mangiare carni proibite dalla legge ebraica e rimane perplesso (At 10,9-18). Qui lo Spirito interviene e lo avvisa che stanno arrivando gli uomini mandati da Cornelio. Ed egli obbedisce e va con loro.
Lo Spirito Santo, il maestro interiore, si fa accompagnatore. È colui che, in quanto Dio, aiuta Pietro ad allargare i suoi orizzonti: la legge di Mosè è superata – si possono mangiare le carni proibite perché la creazione è tutta buona – e si possono invitare i pagani ad accogliere la buona novella – perché essa è buona notizia per tutti, nessuno escluso. Così Pietro, nonostante le sue ristrettezze, deve cedere alla forza della verità: «Pietro allora prese la parola e disse: “In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti”» (At 10,34-36). Quel Gesù che «passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo» (At 10,38) desidera che tutti lo conoscano e lo accolgano, entrando in felice relazione con il Padre suo. Pietro è così accompagnato a cogliere tutte le conseguenze della rivelazione di Gesù: Dio non fa preferenza di persone, egli è venuto per tutti, perché tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza.
Adesso, una volta che egli è pienamente entrato in questa nuova dimensione, deve farsi accompagnatore dei suoi fratelli nella Chiesa, aiutandoli ad allargare anche i loro orizzonti. Di fronte alla sorpresa per ciò che accade – «si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo» (At 10,45) – Pietro deve arrendersi all’evidenza e prendere posizione: «Ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo» (At 10,48). Tornando a Gerusalemme, di fronte al rimprovero dei fedeli di origine ebraica, racconta con ordine tutto ciò che è accaduto per filo e per segno (cfr. At 11,4-16). La conclusione della vicenda ci dice che questo mirabile intreccio di accompagnamenti ha portato molto frutto:
“Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?”. All’udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: “Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita!” (At 11,17-18).
E ci dice anche che il fine ultimo dell’accompagnamento sta nel permettere a Dio di far arrivare a noi la pienezza della sua volontà, eliminando ogni resistenza e impedimento.
Risorse ecclesiali e carismatiche
Se guardiamo ai cammini della Chiesa in questi ultimi anni possiamo notare con soddisfazione che il tema dell’accompagnamento ha ricevuto grandi impulsi. Soprattutto il Sinodo sui giovani ha ripreso questo tema in molti modi, approfondendolo in forma poliedrica e in intima connessione con il discernimento.
L’accompagnamento e il discernimento vanno insieme: bisogna essere ben accompagnati per poter discernere con verità. Durante il cammino sinodale è stata riscoperta la bellezza delle diverse modalità di accompagnamento, che sono state riordinate in tre livelli: prima di tutto l’accompagnamento di ambiente o comunitario, poi quello di gruppo e infine quello personale. Vi è una tensione feconda e un equilibrio dinamico da raggiungere e garantire tra questi diversi livelli di accompagnamento. Essi si richiamano e si completano, come dice molto bene anche il nostro Quadro di riferimento della pastorale giovanile salesiana:
La comunità educativo-pastorale più che una struttura o istituzione già fatta, è un organismo vivente che esiste nella misura in cui cresce e si sviluppa. Per questo non si deve curare soltanto la sua organizzazione ma, soprattutto, sviluppare la sua vita. In ogni comunità educativo-pastorale si devono assicurare la promozione e la cura di molteplici modalità di animare, di accompagnare le persone. […] In primo piano, si accompagna innanzitutto costruendo un ambiente educativo. [...] L’accompagnamento attraverso i gruppi aiuta a crescere nel senso di appartenenza della comunità educativo-pastorale. […] Un terzo e ultimo compito si prospetta, accompagnare ciascuno dei membri della comunità educativo-pastorale nella sua crescita umana e cristiana e nelle sue scelte personali (DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE, Quadro di riferimento della Pastorale Giovanile Salesiana, Roma, 20143, 114-116).
Abbiamo bisogno di ambienti familiari, dove ognuno di noi possa sperimentare un clima confidenziale, amichevole e amorevole; abbiamo necessità di appartenere a gruppi in grado di condividere iniziative apostoliche per maturare sensibilità contemplative; abbiamo infine bisogno di adulti non adultescenti e non adulterati, cioè di persone che «mediante l’esperienza hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene e il male» (Eb 5,14), che siano disponibili a divenire guide autorevoli per le giovani generazioni.
Se è vero che “accompagnare” significa prima di tutto affiancare i giovani nella loro ricerca di senso, è anche importante sottolineare che nella nostra visione salesiana
si parla di accompagnamento non solo per indicare un’azione che affianca il cammino di un singolo o di un gruppo lungo un tratto di crescita, ma si parla anche di accompagnamento pastorale ovvero di quanto si occupa più ampiamente di cura dei processi, degli ambienti educativi e delle persone. In questo senso, crediamo che l’esperienza dell’accompagnamento sia tale solo in una dimensione di reciprocità reale, che non toglie niente alla responsabilità del nostro compito educativo, ma piuttosto le garantisce una maggiore efficacia e credibilità (Per accendere le stelle. Orientamenti pe una Pastorale giovanile vocazionale salesiana, FMA Italia, 2021, 33).
Lasciarsi accompagnare e formarsi per accompagnare: sembrano essere questi i due ambiti di lavoro su cui impegnarsi molto nei nostri percorsi formativi. Per divenire dei buoni accompagnatori bisogna essere disponibili a lasciarci accompagnare: allo stesso modo del piccolo Giovanni Bosco, che nel sogno dei nove anni è invitato a divenire umile, forte e robusto, anche noi siamo chiamati a lavorare su noi stessi per divenire accompagnatori autorevoli. Tutto ciò non s’improvvisa, ma ha bisogno di un impegno serio e profondo.
Dal contesto alle scelte
Se guardiamo al nostro contesto, vediamo che siamo sempre di fretta. In genere desideriamo dei risultati, ma li vogliamo subito e senza sforzo. Facciamo fatica a trovare il tempo per l’ascolto reciproco, il dialogo cordiale e il confronto sereno, che sono i primi ingredienti per avviare percorsi di accompagnamento. Per essere accompagnati ci vuole fiducia negli altri e anche tempo a disposizione. Ci vuole silenzio e anche preghiera. Ci vuole contemplazione e anche adorazione.
In genere ci lasciamo “accompagnare” dal nostro smartphone. È un potere occulto, che ci orienta e molte volte decide per noi. È un accompagnatore sempre presente e sempre operativo. È una protesi che offre sicurezza in un mondo che ha bisogno di risposte immediate e che cerca per ogni problema una app adeguata o un influencer su misura. Sappiamo che oramai i critici dei social media e dei media in generale nominano questi strumenti come “strumenti di distrazione di massa”.
L’affacciarsi dell’intelligenza artificiale viene salutata da molti come una forma nuova e totalizzante di accompagnamento. Nei prossimi anni dovremo riuscire a comprendere dove queste nuove tecnologie ci porteranno e come salvaguardare l’umano in questa nuova situazione che si va configurando.
Rispetto a tutto ciò conviene interrogarsi sulla realtà tanto antica e tanto nuova di un sano, corretto e illuminato dinamismo di accompagnamento a tutti i livelli.
Ci possiamo innanzitutto fare delle domande a partire dalle esigenze della speranza:
- In un’epoca di smarrimento e di distrazione possiamo ancora nutrire la speranza che Dio sia presente e agente, come lo abbiamo visto all’opera nella vicenda di Cornelio e Pietro?
- Possiamo dare ancora ai giovani la speranza di avere adulti significativi per la loro vita?
- Abbiamo speranza di trovare nella Chiesa accompagnatori preparati e disponibili?
- Cerchiamo di ravvivare, attraverso una formazione continua, la nostra capacità di essere accompagnatori nello Spirito?
- Siamo convinti che perdere tempo per accompagnare un ambiente, un gruppo o una persona sia un atto di speranza autentica?
Ci sono poi degli interrogativi che ci vengono dall’ambito della fede in relazione alla speranza:
- Cerchiamo nella parola di Dio i criteri e i fondamenti per accompagnare ed essere accompagnati?
- Abbiamo fiducia in persone che, nel nome e per conto della Chiesa, possono accompagnarci? Infine, siamo anche sfidati a proposito della carità, sempre in relazione alla speranza:
- Siamo convinti che l’accompagnamento, come l’educazione, raggiunga i suoi obiettivi quando si esercita nella forma della carità “relazionale” (ascolto, mansuetudine, dolcezza, tenerezza, confidenza, familiarità, ecc.)?
- La carità educativa si esercita attraverso la presenza costante e l’accompagnamento amorevole:
cerchiamo di esercitare tutto ciò quotidianamente nelle nostre realtà salesiane?
Versione app: 3.46.2 (85a32005)