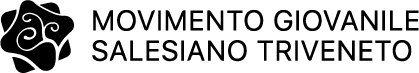Il padre non evapora
È morto per Covid nella stanza di una Rsa. Aveva una sola malattia pregressa, i 96 anni, vissuti intensamente uno per uno

Il padre non evapora
di Davide D'Alessandro, tratto da huffingtonpost.it
È morto per Covid nella stanza di una Rsa. Aveva una sola malattia pregressa, i 96 anni, vissuti intensamente uno per uno
Mio padre è morto il 28 dicembre. È morto per colpa del Covid nella stanza di una Rsa. Aveva una sola malattia pregressa, i 96 anni, vissuti intensamente uno per uno. Lo immagino dimenarsi nel lettino, la tosse secca, la gola arsa, alla ricerca di un altro respiro, dell’ultimo respiro.
Il virus distingue, separa, allontana, impedisce di tenersi per mano. Persino il funerale è un saluto veloce a un corpo immediatamente rinchiuso e sigillato. Una tragedia della solitudine. Non lo si può toccare né vedere, ma un padre che se ne va è un padre che resta. Inevitabilmente. Continua a esserci senza esserci più. In tanti, troppo in fretta, si sono incaricati di metterlo da parte.
L’evaporazione del padre. Sociologi e psicoanalisti, atei impenitenti e deboli credenti, per decenni è stata una lunga corsa a decretarne la fine. Da un po’, dopo averlo archiviato, preoccupati per la piega che ha preso il mondo, hanno invertito la marcia con l’intento di reinstallarlo sul trono.
Ma può finire un padre? Quale padre finisce? L’uomo che ha contribuito a metterti al mondo, il riferimento costante di una vita, la guida per i tuoi passi incerti, il richiamo autoritario del patriarca? O l’uomo che ti porti dentro, l’altro da te che ha saputo castrarti e liberarti, castrarti per liberarti, l’esempio di tante vittorie e tante sconfitte, l’idea incarnata che non bisogna mollare mai, quel soffio, sembra una voce, che ti sospinge da dietro o quella mano che ti sorregge e non vedi?
“Padre, se anche tu non fossi il mio padre, se anche fossi a me un estraneo, per te stesso egualmente t’amerei” ha scritto Camillo Sbarbaro, perché il poeta prevede, anticipa, coglie il sentimento di una presenza eterna. Irrinunciabile. Il padre è un segno, un marchio, un dolore antico e nuovo. Il padre è anche un nome, il Nome del Padre, per dirla con Lacan, non il padre reale (Antonio, Giacomo o Giovanni) ma la funzione paterna, l’agente psichico che ti apre all’esperienza soggettiva.
Il padre è la testata d’angolo quando non sai dove ti trovi, quando hai smarrito la strada, il faro capace di ricondurti nell’alveo del certo, dove si sostanzia la vita. È un’idea, il padre, che si ripresenta in te figlio che diventi padre, è una storia infinita, una catena di sensi e di significati che non può essere spezzata.
È un’illusione uccidere il padre, sacrificarlo, farne a meno. Le gambe con le quali cammini hanno lo stampo e il vigore, o la debolezza, delle sue gambe, gli occhi che puntano dritti in avanti hanno il riverbero dei suoi occhi, i gesti che accompagnano parole ora piene ora vuote hanno la forma dei suoi gesti.
Per Cesare Pavese “un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Sostituite pure la parola paese con padre, tanto al paese prima o poi si torna, come si torna al padre.
“Non saprei indicare un bisogno infantile di intensità pari al bisogno che i bambini hanno di essere protetti dal padre″. È il Freud del 1929, il Freud de “Il disagio della civiltà”, il Freud che aveva da tempo intuito la potenza di una relazione non aggirabile, non eludibile. Certo, il bambino deve diventare adulto, farsi uomo e non è un caso che molti lo diventino dopo l’uscita di scena del padre, ma è un’uscita di scena mai definitiva, mai per sempre. È un allontanamento fisico, una dissolvenza, direbbe Emanuele Severino, ma la pellicola continua a girare, il film ripropone immagini inaspettate, di sorprendente bellezza. C’è ancora legna nella legna che ora è cenere.
Versione app: 3.46.2 (85a32005)