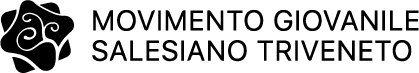Chiamati a custodire una presenza
La vita dei cristiani dopo la vittoria di Hamas. L'importanza del dialogo. La centralità dell'educazione. Le novità nel rapporto con la comunità ebraica. Il ruolo dei francescani. Parla il Custode di Terrasanta, padre Pierbattista Pizzaballa.


Chiamati a custodire una presenza
da Quaderni Cannibali
del 06 luglio 2006
Di ritorno da un pellegrinaggio in Terrasanta, don Giussani disse in un’intervista: «Quello che ci si porta via da quei luoghi è il desiderio, lo struggimento che la gente si accorga di quanto è accaduto: Dio si è fatto presente all’uomo. E invece quello che è accaduto sembra che oggi sia possibile cancellarlo, così come si cancella con un piede una lettera sulla sabbia». Camminare per la Via Dolorosa, infilare le mani nella buca della Croce, inginocchiarsi nella Basilica della Natività di Betlemme significa accorgersi che «la concretezza di quell’avvenimento è così umana che non si può tornare dalla Palestina con il dubbio che il cristianesimo sia una favola». Quei luoghi, che Paolo VI ha definito «il Quinto Vangelo», da secoli sono affidati alle cure dei francescani, chiamati anche a sostenere la comunità cristiana locale - una piccola minoranza ormai, non solo in Israele ma anche nei Territori palestinesi in cui l’islam dilaga - e a condividere i bisogni, le paure, le gioie di chi abita in questo straordinario perno attorno al quale sembra ruotare il mondo: Gerusalemme. Da meno di due anni il compito - davvero immane: solo un francescano può non esserne schiacciato - di Custode di Terrasanta è sulle spalle di padre Pierbattista Pizzaballa, 41 anni, uomo colto e prudente, lucido e diplomatico - lui stesso, scherzando, dice di essere un po’ “gesuita” -, soprattutto estremamente realista. Che sa sempre distinguere, caso per caso, in una selva di situazioni personali, incroci etnici, sovrapposizioni religiose, rivalità secolari che in questo fazzoletto di terra cucinano spesso una miscela esplosiva. Eppure Pizzaballa racconta, sì, che c’è un “eccesso di sacro” in questa terra, che lui stesso vorrebbe un po’ di laicità - non di laicismo - in più, ma dice anche che vivere a Gerusalemme è “affascinante”, anzi è “meraviglioso”, e che lui è più che sicuro che bombe o non bombe i cristiani di lì non se ne andranno mai, e i francescani meno che meno. Perché c’è un disegno in questa storia, evidente. Che segue vie misteriose e a volte terribili, ma grandi. E che oggi lascia intravedere un riavvicinamento sorprendente della Chiesa alle sue origini, e possibilità, sul piano teologico, fino a qualche anno fa neppure immaginate.
Padre Pizzaballa, come vivono i cristiani oggi, stretti tra lo Stato d’Israele e il quasi-Stato ormai governato dai radicali di Hamas?
I cristiani innanzitutto sono pochi: sommando insieme cattolici, ortodossi, protestanti, armeni, copti - in Terrasanta ci sono quasi tutte le confessioni - sono al massimo 180 mila, meno del 2% della popolazione. Il 99% di loro è di origine arabo-palestinese: sono una minoranza dentro una minoranza, dunque. Il 60% di loro vive in Israele, il 40% a Gerusalemme, Betlemme e nei Territori governati dall’Autonomia palestinese. Le dinamiche sono molto diverse nei due casi: in Israele dal punto di vista economico non hanno grossi problemi; fanno parte della fascia sociale medio-alta, di solito. Forse per questi il rischio principale è quello della secolarizzazione, un po’ come in tutte le società avanzate. In Israele la domenica si lavora, uno studente può trovarsi un esame fissato il giorno di Pasqua; vivono in un contesto che non è cristiano. Anche se qui non diminuiscono di numero - c’è anzi un lieve aumento -, i cristiani perdono però incisività, come presenza e come testimonianza.
 
All’interno dell’Autonomia palestinese stanno peggio.
Lì la disoccupazione è altissima, spesso fra il 40 e il 50%, e di conseguenza la situazione sociale è molto più tesa. Con la seconda Intifada uno dei pilastri dell’economia locale, il turismo, è quasi scomparso: per 4 o 5 anni non è venuto nessun turista; molte piccole imprese sono fallite. Poi, di conseguenza, quando l’economia non va bene ci sono anche tensioni sociali e religiose: sono però sempre un po’ una conseguenza di una situazione deteriorata dal punto di vista materiale e politico. Da queste terre negli ultimi anni c’è un esodo di cristiani: molte famiglie, soprattutto del ceto medio, cercano prospettive migliori all’estero. Ma io non sono catastrofista: innanzitutto i cristiani più poveri resteranno, perché per emigrare ci vogliono soldi; e poi c’è anche un piccolo nucleo che è convinto che la sua presenza lì è parte del piano della Provvidenza divina. I cristiani non potranno mai sparire dalla Terrasanta. E non è possibile che il Signore non dia una forza particolare a questi uomini posti alla radice della nostra fede.
L’affermazione di Hamas ha cambiato qualcosa per i cristiani?
Finora almeno, assolutamente nulla. I dirigenti hanno detto che rispetteranno le minoranze, e che vogliono collaborare per il bene di tutta la popolazione palestinese. Non intendono imporre un’islamizzazione della società, ma riorganizzare lo Stato garantendo i diritti civili di tutti. Questo è quello che è stato detto, e non abbiamo motivo per pensare diversamente.
Bisogna dialogare anche con Hamas?
La chiusura dei rapporti non aiuta mai. Il dialogo è fondamentale, non solo per spegnere i fuochi, ma anche per costruire qualcosa per il futuro. Al dialogo non c’è alternativa. Hamas non è soltanto un movimento politico, ha una rete molto forte di assistenza ai poveri, alla quale deve il suo radicamento. E ha anche un braccio militare: questo, naturalmente, crea dei problemi.
Un cristiano non rischia di avallare posizioni troppo radicali?
Dialogo non significa essere d’accordo. Molto spesso si fraintende: dobbiamo incontrarci, parlarci, esprimere anche il nostro dissenso quando è necessario, ma dobbiamo parlare. Se non c’è una chiara coscienza di sé, una chiara identità, il dialogo non serve, è controproducente.
Tagliare i fondi che arrivano dall’estero per non finanziare Hamas è una buona politica?
Io ritengo che l’Europa debba continuare a sostenere l’Autorità palestinese, perché senza questo aiuto essa andrebbe in bancarotta. Certo, l’Europa deve essere presente e vigilante. Quello che è mancato in passato è stato il controllo su come questi soldi vengono spesi. Ma la Santa Sede, anche in altre circostanze, è sempre stata contraria a qualsiasi forma di embargo. L’embargo crea solo problemi alla popolazione. Un cristiano non deve arrendersi, non può accettare il conflitto come un dato di fatto. Giovanni Paolo II diceva: «Non di muri, ma di ponti ha bisogno la Terrasanta». Il ponte deve essere ben fondato su una riva e anche sull’altra, se vuole davvero tenere e unire. Se la Chiesa vuole essere ponte, deve avere fondamenta solide sia in Israele che nell’Autonomia palestinese.
Hamas cresce perché è più attiva sul piano sociale?
Tutte le comunità religiose - musulmani, ebrei e cristiani - da noi hanno una fortissima rete di assistenza sociale. Per tutti qui la fede non è soltanto un credere, è anche un agire. La Chiesa stessa ha tante opere: a volte, anzi, c’è il rischio di apparire un po’ come degli operatori sociali… Da sempre le scuole cristiane sono una presenza importante nei Territori, diamo un supporto alle famiglie povere che hanno il problema della casa, ci sono orfanotrofi, ospedali cattolici: una rete molto fitta di assistenza. Queste cose sono importanti perché sono il modo principale con cui possiamo dare una testimonianza cristiana all’interno di un contesto prevalentemente islamico.
Ha un significato particolare per voi la questione dell’educazione?
Sta diventando fondamentale. In Israele come in Palestina, in un contesto di minoranza, la scuola è l’unico luogo dove possiamo formare in maniera continuativa dei cristiani. Se viene meno l’educazione, i cristiani scompariranno, non come numero, ma perché non sapranno più cosa dire. Senza educazione i cristiani rischiano di diventare una presenza insignificante. Questa è la vera sfida della Chiesa. Perché trovare le case e il lavoro in fondo non è compito nostro: certo, dobbiamo dare una mano a questa gente, ma il nostro primo compito è quello di formare una comunità che sappia cosa vuol dire essere cristiano in un contesto in cui non è normale esserlo.
Fra religioni diverse c’è un confronto, oppure ogni comunità vive un po’ una vita propria?
A dire la verità sul piano della fede le discussioni sono molto poche, e anche molto difficili. Incontri, dialoghi se ne fanno ma riguardano i problemi concreti: discutiamo del lavoro, dei diritti umani, della giustizia.
Cosa vuol dire, come francescani, vivere nei Luoghi santi?
Per noi essere qui è fondamentale. Dopo la fine delle Crociate, gli unici che hanno potuto rimanere in una terra in mano ai musulmani furono proprio i francescani. Per questo il Papa affidò all’Ordine il compito di recuperare i Luoghi santi della redenzione, a nome di tutta la Cristianità, e poi di custodirli. E di ricostituire anche una presenza cattolica intorno ai santuari, per salvare un principio essenziale: fare in modo che queste fossero non solo pietre, ma “pietre vive”. A Nazareth, a Betlemme, a Gerusalemme, Gerico, Cana, Giaffa oggi la Chiesa si incontra, e celebra i sacramenti: questi luoghi sono anche delle parrocchie.
Con che animo ve ne prendete cura?
San Francesco è stato l’uomo dell’Incarnazione. L’uomo innamorato di Cristo che si fa uomo. Pensiamo al presepio di Greccio, alle stimmate che riceve sulla Verna: Francesco vuole identificarsi anche fisicamente con Gesù, desidera diventare tutt’uno con lui, proprio anche nel senso più concreto del termine. E non puoi identificarti con Gesù prescindendo dal luogo dove ha vissuto. Questa terra parla di Lui: quindi per noi è fondamentale essere qui. L’altro aspetto è indicato dal famoso episodio del suo incontro con il Sultano: quando è venuto in Terrasanta, san Francesco ha voluto dialogare con lui. E questo è stato un po’ sempre lo stile che ha caratterizzato la nostra presenza. Non sono mancati momenti difficili, di grande tensione, anche con morti e con martiri; nell’arco di questi 800 anni siamo sempre rimasti fieramente attaccati, con le unghie e con i denti, a queste terre e a questi luoghi, sempre dialogando con tutti però, senza mai alzare delle barricate.
 
Di fronte alle difficoltà politiche di oggi ha un senso che la Chiesa mantenga questo profilo di presenza?
Ha ancora più senso che in passato forse. In una terra dove la lotta politica è così feroce, su ogni aspetto, rimanere lì, attaccati a quei luoghi - naturalmente anche a quelle persone, a quella gente cristiana - senza lasciarsi sopraffare dal linguaggio e dall’atteggiamento politico, è fondamentale. È la testimonianza che noi dobbiamo dare, e di cui la Chiesa ha bisogno. Non vogliamo essere equidistanti, o “equivicini”, come si dice oggi: sono tutte terminologie politiche. Noi siamo dentro la vita della gente, condividiamo i loro problemi, cercando di essere liberi nei confronti di tutti, e amando tutti allo stesso modo. E lasciando ai politici il loro compito, che non è il nostro.
Proprio voi francescani siete un avamposto in una terra che innanzitutto è più originaria dell’Europa in questa storia. Cosa vuol dire sentirsi su questo limite?
È veramente una frontiera. È una terra di incontro e anche di scontro, dove confluiscono le ricchezze dell’Oriente e dell’Occidente, creando una sinfonia molto bella, ma a volte anche un grido, un urlo terribile di dolore. Qui la sofferenza e la Croce sono molto evidenti, e le tensioni culturali fortissime. Noi cerchiamo con molta umiltà, senza presunzione, di rimanere, di restare, molto semplicemente. E di fare quello che è possibile, giorno dopo giorno.
Avete rischiato di persona in certi momenti: penso all’assedio di Tsahal, l’esercito di Israele, alla Basilica di Betlemme nel 2002.
Il compito della Custodia, innanzitutto, è una grande grazia, che la Provvidenza ci ha affidato. Il rischio è che ci si abitui. Ma la tensione è sempre quella di interrogarsi sulla persona di Gesù. Perché questi luoghi ci devono rimandare a Lui. Nazareth, Betlemme, Gerusalemme invitano alla preghiera, ma invitano anche a interrogarci su quel Gesù che qui compì i suoi passi, sulla Chiesa che in questi luoghi celebra e ricorda ogni volta un momento particolare della sua vita. Al di là dei rischi, alla fine il problema è porsi davvero la domanda: «Chi è quest’uomo?». Il nostro compito, sicuramente difficile, ha senso proprio in riferimento alla sua persona.
Altrimenti si potrebbe correre il rischio di un certo “feticismo” dei luoghi...
Sì, il luogo non è importante in sé: è importante per quello che ricorda. Celebra e racchiude, custodisce esso stesso la memoria di un episodio della vita di Gesù, di un momento importante della nostra fede. Per cui, per un pellegrino, andare a percorrere tutte le tappe in Terrasanta è molto importante, ma il luogo ci deve poi rimandare alla persona di Gesù, sempre. Leggere il Vangelo qui non è semplicemente un’operazione culturale: è cercare di capire e approfondire, di entrare meglio dentro la vicenda di Cristo.
 
Con un Papa come Giovani Paolo II c’è stato un riavvicinamento evidente con gli ebrei. Anzi, di più: come ritrovare un comun sentire. È vero che qualcosa di importante sta cambiando? E cosa vuol dire per un cristiano riscoprirsi a vivere non solo nei luoghi di Cristo, ma anche presi dentro la vita di questa stirpe?
Sul piano politico le relazioni con lo Stato d’Israele sono abbastanza cordiali: naturalmente a volte ci sono delle tensioni, è inevitabile quando ci sono tutti questi intrecci di interessi, ma il clima non è teso. Israele non ha bisogno delle nostre strutture caritative, ne ha già, e di molto migliori anche. Per cui, a differenza che nei Territori, la nostra presenza come Chiesa ha senso, e anzi è necessaria, proprio su un piano culturale. In questo campo sicuramente oggi ci sono grandi possibilità: siamo molto vicini, abbiamo lo stesso linguaggio, la letteratura, l’arte, la storia sono temi di confronto estremamente interessanti, sui quali Israele è pronto. Giovanni Paolo II ha cambiato in maniera penso irreversibile l’atteggiamento sia della Chiesa verso Israele, sia viceversa. C’è ancora molto da fare però. Soprattutto a livello della società: bisogna fare in modo che tutte le acquisizioni di questi ultimi anni entrino nella mentalità e nel modo di pensare della gente, e per questo ci vorrà ancora molto tempo. Ma con le autorità religiose c’è già un cambiamento reale - a parte qualche fanatico, che non manca mai -. Si fanno diversi incontri, estremamente ricchi, sugli aspetti della vita di fede, sulla sacralità della vita, la giustizia. E anche convegni su temi biblici, su come interpretare un certo passo delle Scritture. Tutto il contesto neotestamentario è un contesto ebraico, che dobbiamo ancora riscoprire, e in questo campo gli ebrei ci possono molto aiutare. La Rivelazione è una sola, uno solo è il cammino, la via di salvezza passa da Gesù: ma in che rapporto sta Israele con tutto questo? Dal punto di vista teologico - lo ha detto Benedetto XVI -, dobbiamo studiare molto.
Ci sono degli ebrei curiosi del cristianesimo? C’è un interesse per Gesù?
Assolutamente sì. Qualsiasi ebreo quando legge il Nuovo Testamento rimane colpito, e non trova in esso nulla di antiebraico. Anzi, capisce che, tutto sommato, è “roba sua”. L’interesse per la persona di Gesù è molto forte oggi. La cosa difficile è accettare la divinità di Gesù. Quando studiavo all’università mi capitava molto spesso di leggere il Vangelo con alcuni amici ebrei, religiosi, senza nessun doppio fine, così, con il gusto di sfogliare quelle pagine insieme. Molto spesso la domanda che veniva fuori era: «È un messaggio meraviglioso, Gesù è una figura straordinaria, ma perché dobbiamo farlo risorgere?». Per un ebreo quello contenuto nel Vangelo sarebbe un messaggio splendido anche se Gesù fosse semplicemente morto sul Golgota. Ecco, questa è la grande difficoltà.
C’è chi diventa cristiano?
Sono pochi. Esiste una comunità cattolica “di espressione ebraica”, come si dice: 7/800 persone, delle quali la metà sono ebrei che hanno ricevuto il Battesimo, gli altri non erano ebrei, erano israeliani “gentili”. Una cosa che fa un certo effetto è che la loro liturgia oggi è solo ed esclusivamente in ebraico: per la prima volta, dopo migliaia di anni, la Chiesa qui prega in ebraico, come all’inizio. Con la nascita di Israele è rinato un contesto all’interno del quale la Chiesa prega, parla, fa la catechesi in questa lingua, ed è inserita in un contesto giudaico. Credo che questo piccolo gruppo abbia una doppia vocazione: da un lato, quella di far conoscere a Israele un aspetto di Chiesa che non è ostile al mondo ebraico; dall’altro, far conoscere alla Chiesa l’importanza del proprio rapporto, anche teologico, con Israele.
Un gruppo di prigionieri del carcere di massima sicurezza di Meghiddo, scavando in un cortile, di recente ha riportato per caso alla luce dei bellissimi mosaici cristiani, con una scritta che parla di «Dio Gesù Cristo, perché sia fatta memoria di Lui». È un ritrovamento importante?
Sicuramente è un pavimento molto antico. C’è discussione tra gli archeologi, si stanno approfondendo gli studi, ma certo è estremamente interessante: se dovesse emergere che si tratta di un luogo di culto antecedente il III secolo, come qualcuno sostiene, sarebbe una scoperta straordinaria. Assieme a Cafarnao sarebbe il secondo luogo dove si ha una testimonianza di culto cristiano prima di Costantino, che come è noto modificò profondamente tutta l’area. Sarebbe un’esperienza di domus ecclesia molto vicina alle origini.
In ogni caso, di Chiesa intesa come casa, molto vicina alle origini, in Terrasanta ce n’è anche un’altra, viva: è qui davanti che mi parla.
 
 
Padre Pierbattista Pizzaballa, 41 anni, dal maggio 2004 è il custode di Terrasanta. Francescano, è stato scelto dal Definitorio generale dei Frati Minori, e la nomina è stata approvata dalla Santa Sede. Pizzaballa è nato a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, il 21 aprile 1965, ed è sacerdote dal’90. Nello stesso anno ha conseguito il baccellierato in Teologia presso il Pontificio ateneo Antonianum di Roma. Si è specializzato presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, ottenendo la licenza in Teologia biblica nel ‘93, e ha poi conseguito il grado di “master” presso l’Università Ebraica di Gerusalemme. Da 15 anni fa parte della Custodia di Terra Santa. Ha insegnato Ebraico moderno alla Facoltà francescana di Scienze bibliche e di Archeologia a Gerusalemme, ha tradotto vari testi liturgici in ebraico, e ha pubblicato, assieme a padre Massimo Fazzini, l’importante rito della messa e della liturgia in ebraico. Per conto del Patriarcato latino ha seguito la pastorale ai fedeli cattolici di espressione ebraica.
Carlo Dignola
Versione app: 3.46.4 (19a31e64)