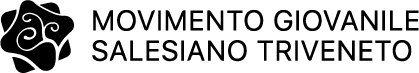Capitolo II
Sì, d'accordo, ma c'è un intoppo. lo penso a lei quasi sempre. Penso alle cose che erano lei: le sue parole, gli sguardi, le risate, le azioni. Ma chi le sceglie e le mette insieme è la mia mente. Non è passato neanche un mese dalla sua morte, e già sento il lento e insidioso inizio di un processo che farà della H. a cui penso una donna sempre più immaginaria.


Capitolo II
da L'autore
del 01 gennaio 2002
Ho riletto queste note per la prima volta e ne sono sbigottito. Da come parlo, chiunque penserebbe che la morte di H. conti soprattutto per l’effetto che ha avuto su di me. Il suo punto di vista sembra del tutto scomparso. Ho dimenticato quel suo: «C’era tanto per cui vivere!», gridato in un momento di angoscia? La felicità non le era stata data presto nella vita. Mille anni di felicità ininterrotta non sarebbero bastati a renderla blasée. Per tutte le gioie dei sensi, dell’intelletto e dello spirito, aveva un gusto fresco e intatto. Nulla sarebbe stato sprecato per lei. Amava più cose e più intensamente di chiunque altro io abbia conosciuto. Una nobile fame, rimasta a lungo insoddisfatta, aveva finalmente trovato il proprio cibo, e un attimo dopo quel cibo le fu strappato via. Il fato (o che altro è) gode a produrre un grande talento e a renderlo poi vano. Beethoven diventò sordo. Uno scherzo meschino, ai nostri occhi; la beffa di un idiota malevolo.
Devo pensare di più a H. e meno a me stesso.
Sì, d’accordo, ma c’è un intoppo. lo penso a lei quasi sempre. Penso alle cose che erano lei: le sue parole, gli sguardi, le risate, le azioni. Ma chi le sceglie e le mette insieme è la mia mente. Non è passato neanche un mese dalla sua morte, e già sento il lento e insidioso inizio di un processo che farà della H. a cui penso una donna sempre più immaginaria. Basata sui fatti, certo: non vi metterò (così spero, almeno) nulla di inventato. Ma la composizione non diventerà inevitabilmente sempre più cosa mia? Non c’è piùla realtà a frenarmi, ad arrestarmi di netto, come faceva tante volte la vera H., e in modi tanto inaspettati, con il suo essere totalmente lei e non me.
Il dono più prezioso che ho avuto dal matrimonio è stato questo continuo impatto con qualcosa di molto vicino e intimo e tuttavia sempre e inconfondibilmente altro, resistente - in una parola, reale. Tutta quest’opera dovrà andare distrutta? Ciò che io continuerò a chiamare H. è destinato a ricadere orribilmente nella fumosità delle mie vecchie fantasticherie di scapolo? Oh mia cara, mia cara, torna per un momento solo a scacciare questo meschino fantasma. Oh Dio, Dio, perché ti sei tanto adoperato a tirar fuori questa creatura dal suo guscio, se ora è condannata a strisciarvi dentro nuovamente, a essere risucchiata in esso?
Oggi ho rivisto un uomo che non vedevo da dieci anni. In tutto questo tempo avevo sempre creduto di ricordarmelo bene: il suo aspetto, il suo modo di parlare, le cose che diceva. I primi cinque minuti dell’uomo reale hanno polverizzato l’uomo del ricordo. Non che fosse cambiato. Tutt’altro. Continuavo a dirmi: «Ma certo, avevo dimenticato che la pensava così, che questo non gli piaceva, che conosceva il tale, che gettava indietro la testa a quel modo». Tutte queste cose un tempo le sapevo e nel rivederle le ho subito riconosciute. Ma erano svanite dal ritratto mentale che avevo di lui, e quando la sua presenza le ha rimesse alloro posto, l’effetto complessivo è stato diversissimo dall’immagine che mi ero portato dietro per tutti questi dieci anni. Come posso sperare che la stessa cosa non accadrà al mio ricordo di H.? Che non stia già accadendo? Lentamente, silenziosamente, come fiocchi di neve – quei fiocchi lievi che preannunciano una nevicata che durerà tutta la notte - sulla sua immagine si stanno depositando piccole scaglie di me, mie impressioni, mie scelte. E alla fine la forma reale ne sarà completamente nascosta. Dieci minuti, dieci secondi, della vera H. basterebbero a correggere tutto ciò. Ma anche se mi venissero concessi, un secondo più tardi i piccoli fiocchi ricomincerebbero a cadere. Il sapore aspro, mordente, purificatore, della sua alterità è scomparso.
Com’è trito e ipocrita dire: «Sarà sempre viva nel mio ricordo!». Viva? Ma è proprio quello che non sarà mai più. Tanto varrebbe credere, come gli antichi egizi, che si possono trattenere i morti imbalsamandoli. Non riusciremo mai a persuaderci che se ne sono andati? Che cosa resta? Un cadavere, un ricordo, e (in alcune versioni) un fantasma. Parodie oppure orrori. Tre modi in più per dire «morto». Era H. che amavo. Come potrei pensare di innamorarmi del mio ricordo di lei, di un’immagine creata dalla mia mente? Sarebbe una specie di incesto.
Ricordo il mio moto di ripugnanza, un mattino d’estate di molti anni fa, quando un omone dalla faccia allegra, entrando nel nostro cimitero con una zappa e un annaffiatoio e tirandosi dietro il cancello, gridò da sopra la spalla a due amici: «Faccio una visitina a Ma’ e vi raggiungo». Voleva dire che andava a riassettare la tomba della madre, a strappare le erbacce e bagnare i fiori. Ne provai ripugnanza perché questo modo di sentire (la tomba, i fiori e tutto il resto) lo trovavo e lo trovo ancora semplicemente odioso, per non dire inconcepibile. Ma alla luce dei miei recenti pensieri, comincio a chiedermi se il punto di vista di quell’uomo, per chi lo può adottare (io non posso), non abbia i suoi vantaggi. Un’aiuola di due metri per uno era diventata «Ma’». Era il simbolo che lui aveva trovato per la madre, il suo aggancio con lei. Prendersi cura di quell’aiuola era farle una visitina. Non potrebbe essere meglio, in un certo senso, che conservare e accarezzare un’immagine nella memoria? La tomba e l’immagine sono entrambe agganci con ciò che è irrecuperabile e simboli di ciò che è inimmaginabile. Ma l’immagine ha in più lo svantaggio di essere pronta a fare tutto quello che vogliamo. Sorriderà o si rabbuierà, sarà tenera, gaia, sboccata o polemica, secondo ciò che chiede il nostro umore. È una marionetta di cui reggiamo i fili. Non ancora, naturalmente. La realtà è troppo fresca: ricordi genuini e del tutto involontari possono ancora, grazie a Dio, irrompere e strapparmi di mano quei fili. Ma la fatale obbedienza dell’immagine, la sua insipida arrendevolezza, inevitabilmente cresceranno. L’aiuola, invece, è una realtà ostinata, resistente, spesso intrattabile, come certo era Ma’ da viva. Come era H.
O come è. Posso in tutta onestà dire di credere che ora H. è qualcosa? La stragrande maggioranza della gente che incontro, per esempio sul lavoro, direbbe senz’altro di no. Anche se naturalmente con me non insisterebbe. Non ora, almeno. E io, che cosa penso davvero? Sono sempre riuscito a pregare per gli altri morti, e lo faccio ancora, con una certa fiducia. Ma quando cerco di pregare per H. mi arresto. Sono sbigottito, sopraffatto dallo smarrimento. Ho un’orribile sensazione di irrealtà, mi sembra di parlare nel vuoto di qualcosa che non esiste.
La ragione di questa differenza è anche troppo ovvia. Non si può mai sapere con quanta convinzione si crede a qualcosa, fino a quando la verità o la falsità di questo qualcosa non diventano una questione di vita o di morte. Prendiamo una corda: è facile dire che la credi sana e robusta finché la usi per legare un baule. Ma immagina di doverci restare appeso sopra un precipizio. Non vorresti prima scoprire fino a che punto te ne fidi? Lo stesso vale con la gente. Per anni sarei stato pronto a dire che avevo completa fiducia in B.R. Poi venne il momento in cui dovetti decidere se confidargli o no un segreto molto grave, e questo dilemma gettò una luce del tutto nuova su quella che io chiamavo la mia «fiducia» in lui. Scoprii che questa fiducia non esisteva. Solo un rischio vero mette alla prova la realtà di una convinzione. A quanto pare, la fede (ciò che io credevo fosse fede) che mi permette di pregare per gli altri morti mi è sembrata forte solo perché non mi è mai importato gran che, non mi è mai importato disperatamente, che quei morti esistessero o no. Eppure ero convinto del contrario.
Ma ci sono altre difficoltà. «Dov’è lei ora?». Ossia, in quale luogo è lei in questo momento? Ma se H. non è un corpo - e il corpo che amavo non è certo più lei - H. non è in nessun luogo. E «questo momento» è una data o un punto della nostra sequenza temporale. È come se lei
fosse in viaggio senza di me e io dicessi, guardando l’orologio: «Chissà se ora è a Euston». Ma se lei non sta procedendo a sessanta secondi al minuto lungo la stessa linea temporale su cui viaggiamo noi viventi, che cosa significa ora? Se i morti non sono nel tempo, o non sono nel tempo che noi conosciamo, esiste una chiara differenza, quando parliamo di loro, tra era, è e sarà?
Persone di buon cuore mi hanno detto: «È con Dio». Almeno in un senso, questo è certissimo. Essa è, come Dio, incomprensibile e inimmaginabile.
Ma mi pare che questa domanda, per quanto importante possa essere in sé, non sia poi molto importante in relazione al dolore. Supponiamo che le vite terrene che lei e io abbiamo condiviso per qualche anno siano in realtà solo la base, o il preludio, o l’aspetto terreno, di due inimmaginabili entità sovracosmiche ed eterne, raffigurabili come sfere o globi. Là dove il piano della Natura le interseca, ossia nella vita terrena, esse appaiono come due cerchi (il cerchio è la sezione di una sfera). Due cerchi che si toccavano. Ma questi due cerchi, e soprattutto il punto in cui si toccavano, sono proprio ciò che io piango, ciò che mi manca, ciò che ho fame di riavere. «Il suo viaggio continua» mi dite. Ma il mio cuore e il mio corpo gridano: ritorna, ritorna. Sii un cerchio che tocca il mio cerchio sul piano della Natura. Ma so che è impossibile. So che quello che voglio è proprio quello che non potrò mai ottenere. La vita di un tempo, gli scherzi, bere insieme, discutere, fare l’amore, le piccole e struggenti banalità. Da qualsiasi punto di vista, dire: «H. è morta» è lo stesso che dire: «Tutte queste cose sono finite». Sono parte del passato. E il passato èil passato e questo è ciò che si intende per tempo, e il tempo è uno dei tanti nomi della morte, e quanto al Cielo, è uno stato dove «le cose di prima sono passate».
Parlatemi della verità della religione e ascolterò con gioia. Parlate mi del dovere della religione e ascolterò con umiltà. Ma non venite a parlarmi delle consolazioni della religione, o sospetterò che non capite.
A meno, naturalmente, di non prendere per buone tutte quelle storie di ricongiungimenti «sull’altra riva», dipinti in termini affatto terreni. Ma sono cose che non hanno nulla a che fare con le Scritture, cose derivate da inni e litografie dozzinali. Nella Bibbia non ce n’è traccia. E poi suonano false. Lo sappiamo che non può essere così. La realtà non si ripete. Ciò che viene tolto e ciò che viene ridato non sono mai la stessa identica cosa. Com’è astuta l’esca degli occultisti! «Qui da noi le cose non sono poi tanto diverse». Sigari in Paradiso. Perché è questo che vorremmo tutti: riavere indietro il passato felice.
E questo, proprio questo, è ciò che imploro, a mezzanotte, con teneri nomi e suppliche follemente rivolti all’aria vuota.
E il povero C. mi cita: «Non siate contristati, come gli altri che non hanno speranza». Mi stupiscono, questi inviti a riferire a noi stessi parole così manifestamente rivolte a chi è migliore di noi. Quel che dice san Paolo può essere di conforto solo a chi ama Dio più dei morti, e i morti più di se stesso. Se una madre piange non ciò che ha perduto lei, ma ciò che il suo bambino morto ha perduto, le è di conforto credere che egli non ha perduto il fine per cui è stato creato. E le è di conforto credere che anche lei, nel perdere la sua prima o la sua sola felicità naturale, non ha perduto una cosa più grande, la continua speranza di «glorificare Iddio e goderlo per l’eternità». Un conforto per lo spirito eterno che è in lei e che è proteso verso Dio. Ma non per il suo spirito materno. La felicità specificamente materna per lei è un capitolo chiuso. Mai, in nessun luogo o tempo, avrà più il suo bambino sulle ginocchia, gli farà il bagno, gli racconterà una storia, farà progetti per il suo futuro, vedrà i propri nipoti.
Mi dicono che H. ora è felice, mi dicono che è in pace. Da dove traggono questa certezza? Non che io tema ciò che vi è di peggio. Una delle ultime cose che disse fu: «Sono in pace con Dio». Non lo era stata sempre. E non ha mai mentito. E neppure si lasciava ingannare facilmente, soprattutto a proprio favore. No, non è questo che voglio dire. Ma perché sono tanto sicuri che la morte metta fine ai tormenti? Più della metà del mondo cristiano e milioni di orientali credono il contrario. Come fanno a sapere che è «in pace»? Perché la separazione (per non dire altro) che tanto strazia chi rimane dovrebbe essere indolore per chi se ne va?
«Perché è nelle mani di Dio». Ma se è per questo, lo era anche prima, nelle mani di Dio, e io ho visto quel che esse le hanno fatto qui. Diventano tutt’a un tratto più delicate, appena siamo usciti dal corpo? E se sì, perché? Se la bontà di Dio è in contraddizione con le sofferenze che ci vengono inflitte, allora o Dio non è buono oppure non esiste: perché nell’unica vita che conosciamo Egli ci fa soffrire al di là delle nostre paure più terribili e di ogni nostra capacità immaginativa. E se non c’è contraddizione, allora anche dopo la morte Egli può infliggerci sofferenze non meno insopportabili di prima.
A volte è difficile non dire: «Che Dio perdoni Dio». A volte è difficile dire anche questo. Ma se la nostra fede è vera, Egli non l’ha fatto. Egli Lo ha crocifisso.Suvvia, a che serve svicolare? Siamo sotto la lama, senza possibilità di fuga. La realtà, guardata fissamente, è insopportabile. E in che modo o perché una realtà come questa ha prodotto qua e là il fiore (o il bubbone) di quel fenomeno tremendo che chiamiamo coscienza? Perché ha prodotto esseri come noi, che possono vederla e che, vedendola, arretrano per il ribrezzo? E che, più strano ancora, vogliono vederla, e si affannano per scoprire com’ è fatta, anche quando nessun bisogno li spinge, anche se la sua vista apre nel loro cuore una piaga incurabile? Persone come H., che voleva la verità ad ogni costo.
Se H. «non è», allora non è mai stata, e io ho scambiato per una persona una nube di atomi. La gente non esiste, non è mai esistita. La morte non fa che rivelare il vuoto che c’era da sempre. I cosiddetti vivi sono semplicemente quelli che non sono stati ancora smascherati. Tutti in bancarotta, anche se per alcuni non ancora dichiarata.
Ma questo deve essere assurdo! Il vuoto rivelato a chi? Bancarotta dichiarata a chi? Ad altre scatole di fuochi d’artificio o nubi di atomi. Non crederò mai - meglio: non mi è possibile credere - che un insieme di eventi fisici possa essere, o commettere, un errore riguardo ad altri insiemi di eventi fisici.
No, la mia paura reale non è il materialismo. Se fosse vero, noi - o ciò che scambiamo per «noi» - potremmo sfuggire alla lama. Un tubetto di sonniferi e sarebbe fatta. Ho molta più paura che siamo in realtà topi in trappola. O peggio: topi di laboratorio. Qualcuno, mi pare, ha detto: «Dio geometrizza sempre». E se la verità fosse: «Dio viviseziona sempre»?
Prima o poi dovrò affrontare la domanda in parole povere. A parte i nostri disperati desideri, che ragione abbiamo per credere che Dio, qualunque metro di giudizio possiamo immaginare, sia «buono»? Tutte le prove manifeste non indicano esattamente il contrario? Che cosa abbiamo da opporre?
Abbiamo Cristo. Ma se si fosse sbagliato? Tra le Sue ultime parole ce ne sono alcune il cui significato potrebbe essere chiarissimo: aveva scoperto che l’Essere da Lui chiamato Padre era orribilmente e infinitamente diverso da quello che Lui aveva creduto. La trappola, preparata da tempo con tanta cura e tanta sottile astuzia, scattò infine, sulla croce. L’infame beffa era riuscita.
Ciò che soffoca in gola ogni preghiera e ogni speranza è il ricordo di tutte le preghiere che H. e io abbiamo offerto e di tutte le nostre false speranze. Speranze nate non solo dalle nostre illusioni, ma incoraggiate, imposte addirittura, da false diagnosi, da radiografie, da strane remissioni, da una guarigione temporanea che aveva quasi del miracoloso. Un passo dietro l’altro, siamo stati «menati per il naso». E Lui ogni volta, mentre faceva mostra di misericordia, in realtà stava preparando il nuovo supplizio.
Queste righe le ho scritte ieri sera. Più che u,n pensiero, è stato un urlo. Riproviamo. E razionale credere in un Dio cattivo? O comunque, in un Dio tanto cattivo? Il Sadico Cosmico, l’idiota malevolo?
Direi che, se non altro, è troppo antropomorfico. Molto più antropomorfico, a ben riflettere, che raffigurarcelo come un maestoso vecchio re con la barba fluente. Questa immagine è un archetipo junghiano. Accomuna Dio ai re buoni e saggi delle fiabe, ai profeti, ai sapienti, ai maghi. Pur essendo (formalmente) il ritratto di un uomo, accenna a qualcosa che trascende l’umanità. Quanto meno, suggerisce l’idea di qualcosa di più vecchio di noi, qualcosa di più sapiente, qualcosa di insondabile. Lascia intatto il mistero. E quindi lascia spazio alla speranza. E quindi spazio a un timore o a una soggezione che non devono necessariamente essere la paura degli arbitrii di un potentato malevolo. Il ritratto che tracciavo ieri sera, invece, è solo quello di un uomo come S.C., che sedeva vicino a me a cena e mi raccontava che cosa aveva fatto ai gatti nel pomeriggio. Ora, un essere come S.C., ingrandito quanto si vuole, non saprebbe inventare o creare o governare alcunché. Preparerebbe le trappole e cercherebbe le esche. Ma non gli sarebbero mai venute in mente esche come l’amore, le risate, i narcisi, un tramonto sulla campagna gelata. Lui, fare un universo? Ma se non saprebbe nemmeno fare una battuta, fare un inchino, fare penitenza, fare amicizia.
O forse si potrebbe introdurre seriamente l’idea di un Dio cattivo per così dire dal retro, attraverso una sorta di calvinismo esasperato? Si potrebbe dire che noi siamo esseri caduti e depravati. Siamo a tal punto depravati che le nostre idee di bontà non contano nulla; anzi, peggio che nulla: il fatto stesso che consideriamo buono qualcosa è indizio presuntivo della sua intrinseca malvagità. Ora, Dio ha in effetti (le nostre peggiori paure sono vere) tutte le caratteristiche che noi giudichiamo cattive: caparbietà, vanità, vendicatività, ingiustizia, crudeltà. Ma tutti questi neri (così,sembrano a noi) in realtà sono bianchi. E solo la nostra. depravazione che ce li fa apparire neri.
E allora? All’atto pratico (e speculativo), questo fa piazza pulita di Dio. La parola buono applicata a Lui perde ogni senso, diventa un mero abracadabra. Non abbiamo alcun mq,tivo per obbedirgli. N emmeno la paura. E vero che abbiamo le Sue minacce e le Sue promesse. Ma perché dovremmo crederci? Se dal Suo punto di vista la crudeltà è «bene», forse anche me ntire è «bene». E anche se fossero vere, noi che ci guadagneremmo? Se le Sue idee di bene sono tanto diverse dalle nostre, quello che Lui chiama «Cielo» potrebbe a rigore essere quello che noi chiameremmo Inferno e viceversa. Infine, se le radici stesse della realtà ci appaiono così prive di senso - oppure, capovolgendo il ragionamento, se noi siamo degli irrimediabili imbecilli -, a che pro speculare su Dio o su qualunque altra cosa? Ecco che, appena si comincia a stringere, questo nodo si disfa.
Perché do spazio nella mia mente a queste disgustose idiozie? Spero forse che, mascherati da riflessione, i sentimenti si facciano sentire meno? Tutte queste note non sono forse gli assurdi contorcimenti di chi non vuole accettare il fatto che nella sofferenza non si può fare altro che soffrire? Di chi è ancora convinto che esista un sistema (se solo riuscisse a trovarlo!) per cambiare il soffrire in non soffrire. Stringi i braccioli della poltrona del dentista o tieni le mani in grembo, la cosa non cambia. Il trapano continua a trapanare.
E il dolore assomiglia sempre alla paura. Forse, più esattamente, alla tensione. O all’attesa: andare su e giù in attesa che succeda qualcosa. Dà alla vita una sensazione di perenne provvisorietà. A che scopo cominciare qualcosa? Non ne vale la pena. Mi è impossibile star fermo. Sbadiglio, cincischio, fumo troppo. Prima avevo sempre troppo poco tempo. Adesso non c’è altro che tempo. Tempo quasi allo stato puro, vuota sequenzialità.
Una carne sola. O, se si preferisce, una nave. Il motore di dritta è andato. lo, il motore di sinistra, devo tirare avanti in qualche modo fino al porto. O meglio, fino alla fine del viaggio. Come posso essere sicuro che esista un porto? E molto più probabile una costa sottovento, una notte nera, una burrasca assordante, frangenti di prua - e se da terra brillano luci, saranno certo lanterne agitate da chi mi vuole fare naufragare sugli scogli. Così è stato l’approdo di H. Così quello d.i mia madre. L’approdo, dico, non l’arrivo.
Clive Staples Lewis
- testo
- articolo
- clive staples lewis
- educatori
- animatori
- giovani
- adulti
Versione app: 3.46.2 (85a32005)