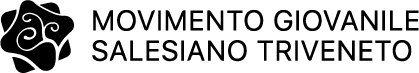Testo della conferenza dei professori Mauro Magatti e Chiara Giaccardi
Riportiamo qui sotto il testo della conferenza dei professori Mauro Magatti e Chiara Giaccardi tenutasi in occasione della Giornata della Scuola e della Formazione Professionale il 2 settembre 2020
GIORNATA DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
“La scommessa generativa dell’educazione”
Riportiamo qui sotto il testo della conferenza dei professori Mauro Magatti e Chiara Giaccardi tenutasi in occasione della Giornata della Scuola e della Formazione Professionale il 2 settembre 2020
Intervento Mauro Magatti
Buongiorno, ringraziamo molto dell’invito e salutiamo anche quelli che sono a distanza.
Intanto onore a chi ha organizzato questo momento, perché voi che siete insegnanti per lo più in questo momento doverosamente, giustamente, ma anche un po' esageratamente, sembra che l’unica cosa che conti quando parliamo di scuola siano la distanza di un metro, la mascherina dentro la classe e tutta una serie di procedure che chiunque conosce i ragazzi sa che dopo pochi giorni non saranno la questione fondamentale.
Perché il grande tema che tutti dobbiamo seriamente affrontare, senza però sorvolare sulla questione della diffusione del virus, che è un problema molto serio, è il fatto che non ci sarà nessuna procedura che ci salva interamente (la parola salvezza è una parola che abbiamo perso nel nostro vocabolario, sostituita dalla parola sicurezza).
Non ci sarà nessuna mascherina che ci salva, anche se è necessario mettere le mascherine.
E poi ho sentito delle cose molto belle di don Bosco, il “Sogno dei nove anni” è una cosa pazzesca, veramente pazzesca. Adesso non so se voi vi rendete conto: la potenza di pensare quello che ancora non c’è e di attraversarlo.
Bene, credo che sia questa la questione, ciò di cui dobbiamo parlare, oggi concretamente, guardando avanti, sapendo che dobbiamo naturalmente stare attenti alle mascherine, le distanze, ma il grande tema è se abbiamo un immaginario del futuro, se riusciamo ad immaginare qualche cosa, in queste stanche, vecchie e leggermente decrepite società.
E la lettera che vi ha scritto papa Francesco è altrettanto impressionante, no? Non so se avete sentito le cose che ha detto: “processi alternativi di formazione”. Parla a voi! Salesiani, salesiane, amici dei salesiani, studenti dei salesiani... quello là 200 anni fa ha avuto un sogno.
Vanno benissimo tutte le procedure perché è tutto necessario, non vorrei essere frainteso, ma in mezzo c’è la questione di che cosa ci sta dicendo questo tempo in generale e poi rispetto alla scuola. Qual è il nuovo sogno che possiamo fare insieme, facendoci educare dai ragazzi.
Il Covid è l’apparizione nel nostro mondo dell’inaspettato: se ci pensate, un anno fa nessuno avrebbe pensato una cosa così! L’imprevedibile nella forma del virus è apparso tra noi, dicendoci “cari amici e care amiche con tutte le vostre super tecnologie, con tutta la vostra potenza economica, basta un piccolo batterio, un piccolo virus e vi si scombina tutto”.
E poi questa percezione collettiva del morire: perché anche prima del Covid si moriva, però erano tutte morti private, ognuno con la propria morte. Quello che è stato invece sconvolgente per tutti, per l’intero mondo, è di aver visto collettivamente che moriamo, che la possibilità di morire è molto concreta.
Guardate che questo è un fatto culturalmente potentissimo perché l’uomo di oggi, che si crede eternamente giovane, il sessantenne (ma questo vale forse anche per il cinquantenne o per il ventenne che pensa al genitore), ha dovuto rivedere le proprie aspettative. Anche prima poteva pensare ‘tra una settimana prendo il treno e mi va male, e posso non esserci più’, ma non è esattamente la stessa cosa. Questo non deve generare angoscia, bensì senso di realtà: forse eravamo fuori di testa prima!
Quindi diciamo che il Covid è una provocazione, tant’è vero che le nostre società sono in difficoltà. Se voi guardate i giornali, vedete la televisione, ci sono delle oscillazioni fortissime, tra il dovere che abbiamo di dare delle risposte, di avere delle contromisure, le reazioni di chi dice che non sta succedendo niente, che nessuno mi può dire quello che devo fare, che la mascherina limita la mia libertà... ma in mezzo c'è questo ospite che non sappiamo trattare, che nessuna società ha mai saputo trattare: la fragilità di questa nostra condizione, è già stato detto, l’illusione di una libertà assoluta, sciolta dai ogni legame - il legame reciproco.
Questi due aspetti si sono imposti: che si muore, cioè che siamo precari e che nessuno è eterno; e che che non siamo onnipotenti - che qualunque procedura, tecnologia, cosa che possiamo fare sarà sempre limitata, perché c'é un imprevedibile dell'esistenza che compare, sempre, sennò non è più vita. E dall'altra parte, abbiamo sperimentato che ciascuno è legato nel bene e nel male all'altro, che l'altro è importante per noi, che è insieme un pericolo e insieme una risorsa. Questi sono due insegnamenti, due contenuti che noi pensiamo abbiano molto a che fare con l'educare e che nella fase post Covid, siano due argomenti di cui si debba parlare.
La vita è un’esposizione, e come tale passa attraverso ciò che non è sicuro: ciò che con un linguaggio contemporaneo chiamiamo rischio.
Nel libro “La Scommessa Cattolica” uno degli argomenti centrali che noi sosteniamo è che, nonostante le tante differenze di temperamento, di carattere, di cultura, ci sia anche una continuità un po' paradossale tra Benedetto e Francesco. Benedetto ci richiama al fatto che nella storia della cultura occidentale la ragione diventa sempre più una ragione tecnica, strumentale, e si distacca anche dalla sua capacità di dialogare con la Fede, e questo è un problema. E poi Arriva Francesco che ci dice, cari amici e amiche, cristiani in tutto il mondo specialmente europei, se volete trattare quella cosa lì rischiate la vita, sognate e vivete nel sogno.
E nel libro scriviamo che solo se le comunità cristiane saranno capaci di parlare il vocabolario dell'eccedenza sapranno dire qualche cosa a un mondo che è preso tra l'eccesso della pulsione di morte, soprattutto tra i giovani, e la pulsione di morte che si esprime invece come chiusura, come tentativo disperato di farsi la bara dove morire, che si esprime in tutte le forme reattive degli ultimi anni, in una società decadente.
Una capacità che viene dal Vangelo, di cui Giovanni Bosco era espressione: perché il sogno ti spinge a vivere nell'aldilà di quello che c'è e nell' eccellenza, cioè nel desiderio di ‘più vita’ che ti porta non in maniera sacrificale ad autodistruggerti per gli altri, ma a vivere così intensamente la vita da essere capace di andare al di là del codice della tua sopravvivenza - che è una cosa ben diversa.
Ecco, noi pensiamo, a maggior ragione oggi dopo l'esperienza del Covid, che questo messaggio che ci viene dal Vangelo, da una storia di tanti secoli che passa anche per San Giovanni Bosco, della capacità di vivere il rischio come spazio della vita e dell’eccedenza, sia proprio al centro della nostra questione contemporanea.
Ci sono stati dei luoghi comuni che sono circolati durante il lockdown, un'espressione collettiva per tenerci un po' su di morale, come succede in quei casi, quali come: “andrà tutto bene”. Il fatto è che non è andato tutto bene, per quelli che sono morti o quelli che hanno perso il lavoro. Con i luoghi comuni ci rincuoravamo un po' a vicenda. E l'altra espressione è: “niente sarà più come prima”. Finito il lockdown avete visto che è tornato tutto come prima. Ecco, io credo che dobbiamo andare aldilà di queste formule. È la tesi del libro nuovo che deve uscire a fine settembre (Nella fine è l’inizio, Il Mulino): noi pensiamo che il Covid colpisca, abbia colpito tutto il mondo, e per quanto ci riguarda l'Europa e l'Italia, dove la società è in forte declino, già con molte difficoltà, che vengono fuori dal mezzo secolo di uno sviluppo, una crescita molto squilibrata. Come avrebbe detto il nostro amico Bernard Stiegler, un grande filosofo francese che è morto improvvisamente i primi di agosto, questo ultimo secolo ha prodotto una crescita entropica favorendo un grande squilibrio: la questione ambientale, le questioni legate alle disuguaglianze, e come direbbe Pietro Barbetta, che è uno psicanalista italiano, una società psicotica, cioè una società che non riesce più a guardare in faccia e ad affrontare le questioni che ha.
Le nostre sono società entropiche: se uno guarda la televisione o naviga in internet e prova a vedere un po' il mondo, vi trova un grande caos. Chi mai potrà trattare questo caos gigantesco?
Questa è una società che ha una grandissima potenza: intendo dire non solo la potenza tecnica, ma tutta l'energia umana che lo sviluppo e la crescita genera. Voi chi siete, cosa volete, quali sono i vostri desideri, per i vostri ragazzi... che fare di tutta quella energia umana?
È una cosa esplosiva, l'energia umana è una forza buona ma anche distruttiva allo stesso tempo. E questo secolo, dalla fine del 900, passando alla globalizzazione ha fatto un salto pazzesco: miliardi di persone che si sono messe sulla nostra stessa strada.
Sono società entropiche e insieme società psicotiche le nostre.
Ma questo non per essere negativi: per essere realisti. Il Covid arriva dicendoci che c'è l'imprevedibile, che non siamo onnipotenti. Il Covid lascerà tracce economiche sociali pesanti: quest'anno il PIL è sceso del 12, il prossimo anno salirà di 6, 7, 8. Ma il problema è che già eravamo fragili prima, la gente che ha perso il lavoro non è che lo ritrova domani mattina, per i ragazzi diventa ancora più difficile.
Quindi il problema non è “andrà tutto bene” e che “tutto cambierà”, ma che siamo da un'altra parte del mondo, della storia.Cancelliamo per piacere la parola “ripartenza”: non si tratta di ripartire, siamo da un'altra parte. Se per ripartire si intende che c'è stato un po' di caos e adesso torniamo come eravamo prima, sappiate che non si può tornare a prima. L'immaginario non è tornare.. “come sarebbe bello se fossimo al primo febbraio 2020”, è un pensiero assurdo. Il problema è come stare nella realtà e nella storia, con senso? La domanda è seria: che fare? Nel senso di San Giovanni Bosco. Anche perché, francamente di scuole paritarie non se ne sente bisogno, per nulla, a meno che siano sale e lievito.
Voi capite che in Italia, tra l'altro, dove c'è una struttura scolastica con 1milione e 300 mila dipendenti, non li può governare nessuno, forse nemmeno Dio, è una cosa impossibile.
Allora se in questo momento un ruolo lo hanno le scuole paritarie, che hanno un margine di autonomia, e che questo margine devono anche strapparlo, devono ritagliarsi questo ruolo, quello di essere delle avanguardie.
Anche perché io vedo una bella scuola, un bel gruppo di Salesiani, siete tutti giovani, chi altro lo dovrebbe fare? Chi se non voi?
Nel post Covid il problema saranno o le misure di sicurezza o una nuova consapevolezza: abbiamo un contesto sociale diverso, abbiamo imparato che c'è l'imprevedibile e che non siamo onnipotenti, che siamo relazione, quindi sul piano educativo ci sono anche dei temi molto rilevanti che non vanno perduti, perché se li perdiamo, se quello che abbiamo visto nel lockdown ce lo dimentichiamo subito siamo fregati. L’insegnamento di quelle settimane non va sprecato, non dobbiamo essere così smemorati. Da una parte c'è un aspetto diciamo di contenuto educativo, ma dall'altra parte c'è anche un aspetto di innovazione della didattica, perché è vero che il digitale da solo non basta, che ci vuole la compresenza... ma è del tutto evidente che il digitale nello stesso tempo apre un territorio sconfinato che bisogna esplorare e che tra l'altro è il linguaggio che i ragazzi in qualche modo parlano di più.
Naturalmente evitando ogni feticismo digitale, ma invece cercando un equilibrio nuovo tra l'elemento della relazione, della presenza e le possibilità offerte dal digitale. Noi in questo nuovo libro cominciamo con un'immagine presa da un antropologo italiano, Ernesto De Martino, il quale parlava di “catastrofe vitale”. “Catastrofe” è un termine che significa appunto un trauma collettivo con l'interruzione del corso ordinario delle cose, un momento di scompaginamento, anche una morte di tante cose; ma le catastrofi hanno sempre dentro un'energia di risposta, una spinta alla trasformazione, la capacità di farci vedere quello che le condizioni ordinarie nella stanchezza della routine non eravamo capaci di vedere. E quindi diciamo il Covid su scala addirittura planetaria è una “catastrofe vitale”.
Una cosa come quella che sta ancora avvenendo, perché non è che il Covid è finito, circola ancora in giro per il mondo, per il vaccino ci vorrà del tempo... insomma abbiamo comunque ancora davanti mesi difficili, le conseguenze economiche si aggraveranno, ci sarà chi andrà avanti e chi tornerà indietro.
Noi pensiamo che siamo come sospesi. La storia si ripete ma non nella stessa maniera, lo diciamo in senso metaforico, siamo come sospesi tra gli anni 20 e gli anni 50. Se noi guardiamo il novecento, detto che le guerre mondiali sono state per la verità più limitate, più circostanziate ad un certo territorio, ma comunque hanno avuto un numero di morti più massiccio del Covid, vediamo che la prima guerra mondiale ha lasciato tutta una serie di strascichi: in particolare, se pensiamo a pezzi interi d'Europa che dopo la guerra mondiale, ci sono stati intere parate della popolazione e soprattutto la Germania, gli anni 20 sono stati terreno di malcontento, frustrazione e risentimento, e dentro quel contesto sono nate delle ideologie che sappiamo hanno portato poi a disastri importanti. L'incapacità a gestire il post trauma ha generato un esito disastroso. La Seconda Guerra Mondiale per tutta una serie di combinazioni ha prodotto un esito opposto, nel senso che si sono trovati degli equilibri internazionali, si sono attivate delle condizioni tali per cui gli anni 50 hanno segnato propriamente l'apertura di un ciclo, dove con tutte le difficoltà del caso si é riusciti a tenere insieme lo sviluppo delle comunità, delle persone, lo sviluppo sociale, il rafforzamento delle democrazie e la pace internazionale - almeno per quanto riguarda l'occidente.
Anche da questa crisi, da questo passaggio o ne usciremo migliori, riuscendo a far nascere un modello socio economico più capace di affrontare tutta una serie di questioni che ci portiamo dietro da molto tempo, ma che non avevamo la capacità di considerare, di risolvere, o noi prendiamo questa occasione per aprire un ciclo nuovo oppure, questa è la nostra tesi, se si pensa di ripartire e di dire adesso ci rimettiamo tutti a correre per salvare l’economia sarà un disastro. Questa è una strada suicida, intanto perché non è che il Covid salta fuori dal nulla, non è totalmente alieno dal modello di crescita che abbiamo costruito noi. Ora abbiamo davanti una sfida che ci riguarda come società e che vi riguarda come insegnanti e vi riguarda ancora di più come insegnanti di una scuola paritaria salesiana. Cioè o noi siamo capaci di stare dentro questo tempo, di svegliarci da questa apatia che ci prende tutti, per cui il massimo che riusciamo a pensare e mettere lì due procedure per stare nella sicurezza, o resteremo preda di quella che Freud chiama “la pulsione di morte”. Freud mette in relazione il principio di piacere con quello di morte: il principio di piacere è il tentativo disperato, l’aspirazione a raggiungere un livello di comfort dove ognuno fa le proprie cose senza stress e senza rischi. Per Freud il principio di piacere è a servizio della pulsione di morte, è la bara del nostro mondo sociale.
Allora solo se saremo capaci, pertinenti rispetto a questo tempo, di non accontentarci del nostro comfort, allora questa crisi del Covid può veramente essere una “catastrofe vitale”, con tutte le difficoltà, passo per passo, per far partire una stagione nuova. Io francamente del mondo che avevo le spalle non ho tanta nostalgia: tante cose belle ma anche tante cose da cambiare. Io credo che il Covid sia una bellissima occasione e mi auguro, anzi ne sono sicuro, che voi del triveneto lavorerete in questo senso.
Intervento Chiara Giaccardi
Grazie per questo invito, credo sia bello per noi che cominciamo di nuovo il cammino di un anno accademico, scolastico, professionale, familiare, iniziarlo con altri.
Volevo partire dal tema del sogno, che é un tema bellissimo e ricco di stimoli per iniziare senza ‘ripartire’, cominciando veramente un cammino nuovo. Il sogno è uno spazio di comunicazione in cui l’io è addormentato, silente, e c'è lo spazio per ricevere un messaggio che viene da altrove e che ci mette in cammino, in modo inedito, fuori dalle vostre coazioni a ripetere. Penso al sogno di Giuseppe che voleva ripudiare Maria in segreto, perché era un uomo buono, ma che poi in sogno riceve il mandato di accoglierla e di accompagnarla nell’avventura della salvezza.
Il sogno è da sempre questo spazio di una recezione che ci rende attivi, che ci rende audaci, che ci fa sfidare il “si è fatto sempre così”. Ed è anche il primo spazio di libertà, perché Don Bosco nel suo sogno di bambino immagina, riceve l'immagine, dì qualcosa che non c'è ancora e che lui è chiamato a realizzare: e questo è l'immaginario più bello della libertà. Non il fatto di poter scegliere qualunque cosa (che c'è già), ma di far esistere, di mettere al mondo qualcosa che non c'è ancora. È questo il sogno di libertà a cui siamo chiamati e a cui dobbiamo risvegliare i giovani, dando loro la speranza che questo è possibile, che questo è nelle loro mani. Ma non soltanto dare la speranza: fare anche un passo in più, ‘autorizzarli’, dare loro il mandato di attuare questo sogno.
È questa la dimensione educativa fondamentale, quella dell'autorizzazione. È una dimensione generativa dell'educazione, perché non è, come normalmente si pensa, ‘dare il permesso’ di fare qualcosa. Autorizzare viene da augere, cioè far crescere, e significa mettere nelle condizioni di prendere in mano la propria vita e di renderla capace di generare qualcosa di nuovo, di mettere al mondo qualcosa che ancora non c’è.
Un educatore, un genitore, un professore, è generativo se riesce a compiere questo movimento, e cioè a dare la fiducia, la speranza e le capacità (per quanto possibile) alle persone di cui si prende cura, di prendere in mano la propria vita, di diventare autori della propria vita, e autori generativi - capaci di far crescere altri a propria volta.
Quindi il sogno è un paradigma comunicativo fondamentale che ci dice che la comunicazione non è soltanto dire qualcosa qualcuno, trasmettere ciò che è nella mia testa alle vostre teste, non è un movimento puramente intellettualistico e di transizione di contenuti, ma è uno spazio di relazione, e uno spazio generativo: nella comunicazione si genera qualcosa che prima della comunicazione non c'era.
A me piace definire questo spazio comunicativo del sogno come uno spazio in cui si esprime una dimensione fondamentale delle nostre vite, che abbiamo dimenticato, e che nel libro Generativi di tutto il mondo unitevi con Mauro chiamiamo della “deponenza”. Noi siamo abituati a pensare solo in termini di attività o passività, ma le forme grammaticali antiche non conoscevano solamente i verbi attivi e passivi: c’erano anche i verbi deponenti, che sono quelli che hanno una forma passiva, ma un significato attivo.
Ed è questa la condizione esistenziale umana: noi non scegliamo le condizioni in cui operiamo, non possiamo che ‘ricevere’ in alcuni casi, ma non per questo non siamo chiamati a rispondere, a essere attivi. E non è un caso che i verbi deponenti siano i verbi che sono esistenzialmente più importanti: nascor, morior, experior, sequor, sono tutti verbi che scandiscono la nostra esistenza, in quanto esseri umani, e il cammino che in quanto esseri umani noi facciamo. Pensiamo al tema della sequela e di quanto c'è di impasto tra lasciarsi portare, ma attivamente essere presenti a questo movimento. Io credo che il sogno sia uno spazio di recettività attiva: un ricevere qualcosa che viene al di fuori di noi che però ci mette in movimento e ci fa essere generativi - nel senso di esercitare quella libertà di mettere al mondo ciò che ancora non esiste.
Faccio una piccola parentesi di quello che è un mio sogno rispetto al mondo delle religiose e dei religiosi. Conoscendo le Salesiane e conoscendo un po' i salesiani nell'ottica di quell' avanguardia generativa di cui il mondo ha bisogno, io penso che ne sareste capaci: è il sogno della desegregazione dei cammini di formazione. Io penso a quanto di anacronistico c'è nella formazione dei preti per esempio, quanto di astratto: prelevati dalla vita concreta, messi in queste capsule di formazione che sono i seminari in cui sono accuditi, circondati soltanto da uomini per poi venire rimessi in mondo per il quale non sono affatto preparati. Detto così è molto banalizzato e non coglie una serie di aspetti, però io credo che il tema reciprocità del maschile e del femminile, in un mondo in cui la tecnica va verso il neutro e verso la svalorizzazione sia del maschile che del femminile, tanto che si pensa di poter fabbricare anziché generare la vita a prescindere dalla donna e dall'unione tra una donna e un uomo, io penso che questa reciprocità e la fecondità di questa reciprocità vada testimoniata fin dai cammini di formazione. E questo credo che renderebbe ancora più bello il carisma. Don Bosco non è andato a sognare questo, ma penso che oggi possa essere sognato, in percorsi che senza fare confusione, senza pensare alla indifferenziazione, siano capaci di valorizzare la reciprocità, i momenti di co-formazione nella reciprocità.
Io questo è un mio sogno e ve lo consegno.
Che cosa vuol dire educare? A maggior ragione nel mondo segnato dal Covid, in questa catastrofe che può essere mortale, ma che può essere vitale.
Quando crolla una casa noi possiamo far finta che non sia crollata, possiamo ricostruirla tale e quale a com'era prima o possiamo cercare di farla meglio. Io credo che siamo in questo post terremoto in cui parlare di ripartenza è di una miopia veramente imbarazzante e irresponsabile.
Per tante ragioni. La prima è che tanto come prima non si può tornare, perché ci siamo impoveriti per tanti aspetti: l'economia già in crisi è ancora più in crisi, le prospettive per i giovani sono ancora più difficili ecc. Quindi come prima comunque non si torna e farsi questa illusione è irresponsabile.
Ma in secondo luogo, ancora più importante per me, sono solo le macchine che ripartono. Una macchina che si è ingolfata poi la ripariamo e riparte. Ma gli esseri umani e le società non sono macchine, non hanno la configurazione tale per cui il loro funzionamento è già iscritto nel modo in cui sono costruire. Gli esseri umani e le società sono degli organismi viventi dove la vita é in continua trasformazione, e dove appunto l'avvenire non è un divenire, per dirla con delle categorie che abbiamo approfondito in questo ultimo libro che abbiamo scritto durante il lockdown (Nella fine è l’inizio).
Il divenire è un futuro che è già tutto iscritto nelle sue premesse, nella concatenazione di cause e effetti: tutto è in qualche modo già scritto, è una catena consequenziale di effetti rispetto ai quali c'è pochissimo da fare.
L'avvenire, ad-venio, ha la stessa etimologia di avventura: l'avventura è ciò che viene di inaudito, di inaspettato. Il Vangelo è proprio il racconto di questo inaudito, di questa buona notizia che ci viene incontro per salvarci, totalmente inaspettata, non certo deducibile dalle premesse storiche. Noi siamo non deducibili, noi siamo liberi perché il nostro comportamento non può essere spiegato a partire da chi siamo, da dove veniamo, da chi sono i nostri genitori... Cioè noi siamo liberi proprio perché col nostro venire al mondo, come diceva Hannah Arendt, siamo nati come singolarità assoluta con il mandato di mettere a nostra volta al mondo qualcosa di inedito. Siamo nati per incominciare, per mettere al mondo, e ciascuno di noi è questa singolarità inaudita e irripetibile, e il nostro camminare insieme è generare un avvenire che non sia già scritto nelle premesse.
Riparare la macchina significa: data questa configurazione cerchiamo di mettere qualche abbellimento, qualche cosa per renderla più efficiente... ma è la configurazione che dobbiamo cambiare, che siamo chiamati a cambiare. Quindi non mettere delle pezze, mettere qualche valore dentro la scatola in cui ci siamo trovati a vivere; piuttosto, riconoscere che quella scatola con il Covid è venuta giù. Possiamo perciò ricostruire qualcosa con libertà, senza dover pensare a come ripristinare, ma tenendo conto di ciò che abbiamo vissuto, di ciò che ci sembra abbia valore, e liberandoci di tutte le inerzie, del ‘si è fatto sempre così’.
L’immaginario della ripartenza diventa veramente una gabbia che ci impedisce di sognare e di lasciarci fecondare dal sogno. Perché ciò che noi pensavamo come impossibile fino al 7 di marzo 2020, è diventato reale dall’8 marzo. Fermarci tutti, non andare più a lavorare, stare a casa con la nostra famiglia, non poter uscire, una cosa impensabile che però è diventata reale. Kant diceva che ciò che è reale è possibile, e noi abbiamo imparato che può essere possibile qualcosa che é totalmente fuori dalla nostra routine, dai nostri schemi, dalle nostre aspettative. Questa lezione non ce la possiamo dimenticare, perché è una lezione di coraggio, di audacia, di resilienza.
Vorrei a questo punto soffermarmi su una piccola premessa e 3 parole.
Qual è il compito? Dato che dobbiamo iniziare, noi abbiamo intitolato quest'ultimo libro "Nella fine è l'inizio", perché è un compito che in questo momento storicamente ci viene consegnato. Come educatori, perché lo siamo tutti, a che cosa dobbiamo educare ed educarci? Detto con una formula iper sintetica: dobbiamo educare ed educarci a essere vivi. Che cosa vuol dire? Vuol dire a generare e non soltanto a fabbricare.
Lo dice papa Francesco nel messaggio che è stato letto: siate artigiani e non automi.
In un mondo in cui tutto viene fabbricato anche la scuola rischia di diventare un luogo di fabbricazione, cioè di addestramento all'adattamento, invece che di educazione alla libertà generativa. Educare ed educarci, perché nessuno nasce ‘imparato’; ma soprattutto, anche una volta che hai imparato ti dimentichi quello che hai imparato. E la cosa bella dell'essere genitore, educatore è che i tuoi educandi continuamente ti rimettono in discussione e ti costringono a rigenerare le motivazioni delle tue scelte: senza questo movimento tutti noi cadremo in quella comfort zone che ci uccide.
Essere vivi significa appunto continuamente rimetterci dentro questo movimento generativo, che poi é il movimento della vita. Ciò che è vivo cambia, ciò che è vivo da frutto, ciò che è vivo non si fossilizza in procedure, in schemi, in forme che pretendono di esaurire ciò che c'è da dire. Quindi un primo aspetto di questo educare a essere vivi e generativi è proprio il tema della scuola.
Ivan Illich parlava di ‘descolarizzare la società’: descolarizzarla nel senso cui accennavo, cioè smontare una scuola fatta per addestrare persone che si adattano a un sistema rispetto al quale non hanno assolutamente alcun senso critico; vuol dire invece discernere, sviluppare la capacità continuamente di rimettere in movimento e di cambiare ciò che impedisce agli esseri umani di fiorire, ciò che esclude, ciò che produce umanità di scarto... Quindi descolarizzare la società vuol dire impedire che la scuola sìa un pezzo del sistema, e renderla invece lievito, sale, luogo di fioritura dei talenti che sono diversificati. Non può essere il luogo dove si ha un’asticella, e chi salta bene, gli altri peggio per loro. Ecco, la scuola nell’era della tecnocrazia rischia di diventare questo. E dall'altra parte McLuhan diceva che la scuola è una prigione senza sbarre, perché rischia di imporre dei format, a partire dalla prossemica delle aule, dove c'è una rigida distinzione tra chi parla e chi ascolta, uno scoraggiamento dell'interazione, una perdita di quella esperienza a partire dalla quale poter insieme attraversare il sapere e farsi fecondare da questo sapere. McLuhan parlava della ‘città come aula’ e sosteneva che invece che stare nella classe bisognerebbe uscire, perché ogni cosa che noi vediamo è lo spunto, è il pretesto, è la scintilla per interrogarsi sul senso, su come è stata costruita, su che cosa manca, su che cosa va fatto, sulla struttura, su ciò che della natura ha fatto l'uomo ecc.
Quindi la scuola può essere un grande laboratorio, soprattutto in questo momento in cui siamo costretti a ripensare la didattica in presenza e in remoto, anche avendo capito che il remoto non è qualcosa di negativo in sé, o solo un pallido surrogato, ma è qualche cosa che può essere fatto giocare in maniera sinergica con la presenza, per esplorare vie nuove di co-costruzione del sapere. Perché ormai tutto il sapere è già fuori, tutti gli articoli scritti (Io mi ricordo quando abbiamo fatto la tesi, tu dovevi andare nelle biblioteche, prenderti la schedina, trascriverti la frase che ti interessava, adesso tutto lo troviamo già in rete, c'è già tutto lì).
Il problema è come orientarsi, o come a partire da quello che c'è produrre dei percorsi di comprensione, di costruzione di sé, di intreccio tra le discipline: cioè come lavorare su questo materiale che già c'è. E quindi più che trasmettere conoscenza, trasmettere contenuti, cercare di creare relazioni, di creare connessioni e intuire percorsi che siano insieme critici e prospettici. C’è una fecondità a cui siamo chiamati innovando dove non ci sono già strade, non c'è già un Google Maps per i docenti che ti dice ‘questa è la strada giusta’, ma c'è lo spazio per un laboratorio in cui i docenti e gli studenti assieme, mettendo insieme le loro capacità, i loro desideri e le loro differenze, reinterroghino l'ambito del sapere e traccino dei percorsi nuovi insieme.
Una parola fondamentale per questo tempo é resilienza, una parola bistrattata, di quelle che diventano di moda, che poi alla fine vogliono dire tutto e niente, e diventano un guscio vuoto che in realtà nasconde, come scriveva De Certeau “il cadavere di ciò che designava prima”.
Ma prima che diventi il sudario del cadavere, resilienza è una parola che va ripensata perché è una di quelle che ci aiutano ad affrontare generativamente questo momento.
Resilienza è una parola che viene dal latino resalio, che è il movimento che fa la barca dopo che si è rovesciata, quando riesce a riprendere il mare. Quindi porta dentro di sé il tema della sopravvivenza (di fronte alla tempesta non siamo morti), ed è quello che ci è capitato per fortuna (alcuni sono morti, noi siamo qui, quindi la catastrofe non ci ha uccisi); ma questa sopravvivenza è soltanto il significato ‘zero’ di questa parola, il punto più basso, e l'obiettivo di questo futuro che ci aspetta non è la sopravvivenza.
Lo diceva prima Mauro, non sono le mascherine che ci salveranno: il grande tema della resilienza è il tema della sicurezza verso la salvezza.
C’è un'idea di vita come mia sopravvivenza personale e al diavolo tutto il resto, per cui le procedure da una parte e la tecnica dall'altra ci offrono "delle garanzie". Quindi se noi pensiamo che la vita sia la mia sopravvivenza fisica, biologica, individuale mi consegno automaticamente a un sistema che mi vende sicurezza con le tecnologie, con le procedure ecc. Ma è questo che ci interessa? È questa la vita di cui stiamo parlando?
Attestarsi su questa nuda vita, cioè sulla sopravvivenza biologica individuale, è come consegnarci con le mani già legate a tutti i sistemi di videosorveglianza e a un cybercapitalismo basato su una sorveglianza che non è più esterna con le telecamere, ma è sotto la nostra pelle, come dispositivo che volontariamente indosseremo e che ci renderà trasparenti. Si aprono scenari veramente distopici.
Quello che sicuramente Don Bosco sognava, e che vi ha motivato a fare la scelta di religiosi e di educatori, non è la sopravvivenza, ma è la vita piena, é il ‘più vita’. Il tema è quello della salvezza.
“Salvo” non vuol dire soltanto vivo, ma vuol dire “intero”. Infatti noi diciamo ‘sano e salvo’: non soltanto sono vivo, ma sono tutto intero, in tutte le mie dimensioni, che sono quella estetica, quella spirituale, quella artistica, quella emozionale, quella religiosa, quella sociale ecc.. L'essere umano è un essere complesso, cioè intessuto di tante dimensioni immanenti e trascendenti. La salvezza è quella che preserva questa integrità, interezza, questa complessità, questa ricchezza. E il compito dell'educazione è proprio questo: far fiorire questa ricchezza.
La resilienza non è semplicemente la catarsi, essendo sopravvissuti a una catastrofe. È vero anche che la parola viene dalla scienza dei materiali e indica ciò che avendo subito un trauma non si spezza ma si rimodella, si adatta. Però la resilienza umana è molto più di questo: è apprendere dal trauma, é far tesoro di ciò che, avendo guardato in faccia alla morte, abbiamo imparato sulla vita. E questo è un punto fondamentale, perché la morte è il grande rimosso della cultura contemporanea. Per cui o la rimuovo e faccio finta di essere immortale, oppure la vado a cercare per il brivido di sentirmi vivo (gli sport estremi, l’uso di sostanze...).
Poiché la morte è un grande rimosso, noi citiamo un verso di Umberto Saba che dice "è il pensiero della morte che, alla fine, aiuta a vivere".
In che cosa dunque ci aiutato questo periodo? Ci ha aiutato rendendo impossibile la rimozione del pensiero della morte, e questo, paradossalmente ci aiuta a vivere, a riprendere in mano la nostra vita e a chiederci cos'è che veramente vogliamo metterci adesso, che cosa veramente abbiamo scoperto che conta.
Quindi ‘ripartenza’ è veramente un termine ideologico per evitare che questo momento di crisi, che come ogni crisi ha la sua carica di potenzialità e di opportunità, diventi un'occasione di cambiamento. Ripartenza è già una di quelle parole che costruiscono un percorso per evitare di guardare altrove, di vedere altro.
La resilienza non è adattamento, ma è un avere guardato la morte che ci aiuta ri-immaginare in modo nuovo la vita: è una trasformazione, è la capacità di cogliere il seme di nuovo, di novità viva, che prima non vedevamo nemmeno più. Educare e educarsi alla resilienza, educare a vedere questo nesso tra la vita e la morte, che è un nesso imprescindibile, è prezioso. Ed è il nesso che ci caratterizza come esseri umani.
La seconda parola è rischio. Che cos'è il rischio? Il rischio è riconoscere che ogni azione di vita ha una parte di morte possibile; ma se noi non prendiamo il rischio, cioè non articoliamo questo nesso tra la vita e la morte scommettendo sulla vita, allora vedremo solo una società della sicurezza, delle procedure, del ‘rischio zero’ che è assenza di vita e ci consegneremo ai sistemi di videosorveglianza. Cogliere il rischio vuol dire riconoscere questo anello insolubile tra la vita e la morte e, senza rimuovere la morte, sapendo che la morte c'è e ci può toccare, scommettere per la vita.
Chi vuole trattenere la propria vita la perde, chi è disposto a lasciarla andare la riceve in sovrabbondanza, ci insegna il Vangelo. È quello che hanno fatto durante il lockdown le tante persone che hanno messo a rischio la propria vita per aiutare altri, mostrando che l'essere umano non è soltanto un essere autoreferenziale, ma è anche un essere che si trascende. Tutto questo ci consegna un compito: non soltanto rimettere sul mare la nave, ma anche cambiare rotta, imparando da ciò che abbiamo attraversato. Perché il marinaio che si è rovesciato e ha rischiato il naufragio, che si rimette in mare, lo fa con una consapevolezza nuova.
L'altra parola che secondo me è importante per questa rigenerazione che ci aspetta appunto, noi l'abbiamo chiamata “responsività”, che è una declinazione di un’altra parola, responsabilità, che è molto importante, molto bella anche, ma così usurata che rischia di diventare vuota.
Non solo: responsabilità ha un accento secondo noi troppo volontaristico e troppo individualistico. Anche qui risaliamo all'etimologia, che è un modo, secondo noi, per scrostare le parole da tutti i luoghi comuni che si sono sedimentati (è interessante vedere come il significato delle parole cambia nel tempo): risalire all'origine è un modo di liberare le parole da questa incrostazione che rischia di soffocarle e di banalizzare o impoverire il loro significato.
Responsabilità viene da respondere, cioè rispondere: rispondere di, cioè io rispondo delle mie azioni, e rispondere a, cioè rispondere alle sfide della realtà.
Però c'è una dimensione molto volontaristica in tutto ciò. Noi ci siamo domandati a che cosa rispondiamo veramente. A che cosa hanno risposto le persone che in questo tempo si sono "sacrificate", hanno messo a rischio la loro vita? Hanno risposto al legame che ci unisce, più che delle loro scelte. Hanno risposto con la loro vita a questo legame, all'idea che noi non siamo degli individui ciascuno dentro la sua bolla, ma siamo una famiglia, una rete. Siamo individui in quanto legame, e il legame ci precede, ci fonda, ci chiama.
Ecco, questa è una rivoluzione antropologica di cui io penso che dovremmo essere ambasciatori.
La cultura contemporanea si dice: Noi siamo individui, poi l'individuo costruisce le sue relazioni, però le relazioni poi sono anche dei vincoli, per cui é meglio che questi vincoli non siano troppo forti... Questa è una narrazione che si è dimostrata falsa, perché noi, durante il lockdown abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, qualcuno anche lasciandocela, che noi non siamo individui, che la relazione è l'aria che ci consente di essere vivi, che non è possibile isolarsi dagli altri, che siamo tutti non solo sulla stessa barca, ma tutti legati gli uni agli altri. E chi ha affrontato da solo questo periodo è stato infinitamente meno libero e meno felice.
Ho coniato per esprimere questa idea l’ espressione del ‘paradosso dell'ombelico’, che secondo me è l'immagine plastica che ci dice che noi non siamo individui che costruiscono relazioni, ma che siamo individui in quanto relazione. L'ombelico, che è il baricentro della persona, dell'essere umano, é il centro del nostro corpo, il punto di equilibrio, viene normalmente designato come luogo dell'autoreferenzialità: in realtà se noi veramente guardassimo l'ombelico, vedremmo un ‘buco’, una mancanza che ci ricorda che noi prima di essere individui siamo relazione, che ci dice che c'è un legame che ci ha accolto, aspettato, cullato, sognato, partorito, allattato, grazie al quale noi abbiamo potuto individuarci. E che questo cammino di individuazione, cioè il diventare individui che dura tutta la vita, è possibile grazie ad altri. Più noi siamo in relazione, più noi riconosciamo il nostro debito, il nostro impegno verso altri, più noi diventiamo individui, più noi ci individuiamo e diventiamo noi stessi.
È questo il paradosso: la relazione non soltanto non è un ostacolo al mio diventare me stesso in libertà, ma è la condizione perché questo accada. Più noi siamo in relazione con un sapere, con chi ci ha preceduto, con un’eredità, con un territorio, più noi abbiamo occasione di diventare noi stessi. Perché l'essere umano è paradossale ed è soltanto perdendosi in altro da sé che trova se stesso. E questo credo che dal punto di vista educativo sia proprio un pilastro fondamentale: sia perché decostruisce tante delle narrative ottuse della cultura contemporanea, sia soprattutto perché ci dà un orizzonte per rigenerare le nostre pratiche, i nostri mondi, a partire dalla concezione dell'essere umano dove la dimensione relazionale è costitutiva anziché prodotto della nostra volontà e intenzionalità.
Prendersi cura. La cura è una parola fondamentale per l'educatore, perché dopo aver messo al mondo qualcosa bisogna anche prendersene cura: se tu metti al mondo una cosa e poi la lasci lì poi questa cosa muore. E mentre il mettere al mondo è un atto entusiasmante, perché da inizio a qualcosa che non c'era, e c'è un senso di potenza creatrice che l'essere umano sente in quanto ‘fatto a immagine e somiglianza’, e un elemento diciamo euforico nel mettere al mondo, il prendersi cura è un atto più quotidiano, più ordinario, più umile, meno esaltante per tanti versi: ma è quel momento preziosissimo e fondamentale che tiene insieme ciò che altrimenti si disperde. E la cura, noi l’abbiamo imparato riflettendo anche sulla nostra esperienza, questa dimensione molto concreta, molto corporea, molto silenziosa, molto poco notiziabile é in realtà una dimensione che regala uno sguardo nuovo. E anche qui l'etimologia ci aiuta, perché cura viene da cor curat, che vuol dire ‘scalda il cuore’, e prendersi cura non è soltanto un atto di generosità in cui io che sono sano faccio del bene al malato, o io forte aiuto il debole. Non è un movimento unidirezionale.
Prendersi cura è sbilanciarsi verso l'altro, un movimento che mi restituisce una dimensione di me: mi prendo cura dell'altro e mi prendo cura di me allo stesso modo. Curo delle dimensioni che altrimenti si atrofizzerebbero, curo la mia umanità.
E poi cura ha anche una radice sanscrita “cau”, che significa sguardo. E soltanto da quella postura, accanto all'altro, sbilanciato verso l'altro, io riesco a vedere alcune cose, a conoscere ciò che altrimenti resterebbe invisibile.
Riccardo da San Vittore diceva Ubi amor ibi oculos, perché soltanto da quella prospettiva dell'amore, o detto con le parole di papa Francesco, della misericordia (che vuol dire miserere cordis, ovvero lasciarsi toccare il cuore) noi riusciamo a vedere, ad acquisire un sapere che altrimenti ci resta precluso.
Quindi nell'educazione non può mancare questa dimensione del prendersi cura gli uni degli altri: quelli che hanno certi doni, certe capacità, certe abilità, da chi ha diversi doni, diverse abilità, diverse capacità. Non può non essere una dimensione educativa costitutiva quella della cura, perché senza di essa noi siamo ciechi a degli aspetti dell'umano, dimenticandoci dei quali costruiamo un mondo disumano. E questo fa la differenza tra il divenire, il ripartire con i nostri schemi per arrivare a raggiungere i nostri target, e l'avvenire, come avventura non già scritta, ma alla quale partecipiamo insieme, in cui diventiamo chi siamo insieme, contribuendo, mettendoci ognuno il suo pezzo. Per dare vita a qualche cosa di comune e di buono per tutti, che ci apre un avvenire che non è già scritto, e che forse noi non scriveremo del tutto, ma certamente aiuteremo a scrivere. Senza il nostro aiuto non sarà scritto. E anche questo è un atteggiamento ‘deponente’: sappiamo che non abbiamo il potere di scrivere il futuro, ma sappiamo che senza il nostro contributo un futuro diverso non può essere scritto.
Questa è credo la postura con cui affrontare questo inizio, questo tempo di rigenerazione, nella gioiosa consapevolezza che non abbiamo il potere nelle mani, ma che senza le nostre mani l'avvenire non accade. E ritornando all'apertura di questa conversazione, il tema del sogno, lasciamoci fecondare dal sogno di chi è stato capace di ricevere questi segni di speranza e di trasmetterli; cerchiamo di sognare e che il sogno alimenti questo inizio nuovo e questa rigenerazione a cui siamo chiamati a contribuire.
DOMANDE
Chiedono un passaggio in più sulla parola responsività, cioè il poter approfondire un po' meglio questo termine perchè pare sia molto “concretO” anche per pensare poi al nostro dopo domani quando saremo in mezzo ai nostri ragazzi.
La responsività è la capacità di risposta che però non è strettamente individuale, anche se la dimensione personale è fondamentale: è un co-rispondere non solo alle sfide che abbiamo di fronte ma anche al legame che ci unisce. Quando Papa Francesco parla di ecologia integrale, per esempio, fa secondo noi appello alla nostra responsività, cioè non soltanto alla nostra responsabilità come individui ma alla nostra responsabilità di rispondere insieme a questo legame che ci unisce tra di noi e con tutto - con l'ambiente, con le altre persone, con le popolazioni di altri territori, con Dio per chi ci crede. Quindi l'idea di responsività ha come sottofondo un'idea di cosmo, in cui non siamo monadi dentro un sistema, ma siamo legati gli uni agli altri, legati con l'ambiente, legati con Dio che è nostro padre.
Possiamo dirla così: mentre la responsabilità è essere consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni, per cui se io sto senza mascherina posso essere un portatore sano e contagiare l'altro, quindi responsabilmente mettendo la mascherina, potremmo definire la responsività come una ‘corresponsabilità istituente’: non ci limitiamo ad adottare dei comportamenti che prevedono le conseguenze delle proprie azioni, ma mettiamo in atto dei comportamenti positivi che cambiano anche gli schemi e che inaugurano delle nuove pratiche in cui insieme ci prendiamo cura della nuova situazione che si è creata. In questo senso non è esclusivamente individuale, anche se la dimensione personale è fondamentale: è una corresponsabilità che istituisce dei nuovi modi di prendersi cura, che rispondono alla nuova situazione.
L’impressione è invece che si concepisca la scuola esattamente come era prima e che si cerchino delle procedure che tenendo fermo tutto quello che c'era cerchino semplicemente di contrastare la diffusione del virus. Questa è invece un'occasione per ripensare qualche cosa di nuovo. E la responsività sarebbe la capacità di rispondere a questa situazione insieme, prendendoci veramente cura dei soggetti più fragili, ma anche di un bisogno di nuovi modi di educare alla conoscenza e trasformare tutti questi limiti in un'occasione per istituire delle prassi nuove.
Rimaniamo su questa domanda e proviamo ad allargare un po’ la questione: come la “responsività” provoca il nostro modo di stare, la postura del nostro atto educativo, il nostro agire concreto? A partire dalle cose più ordinarie come l’orario scolastico, attraverso quello che noi proponiamo dalle materie. Come la scuola può ripensarsi, a partire da questa esperienza? Quali piste possiamo percorrere per riappropriarci dell’ambiente scolastico come luogo di introduzione al senso, dopo quello che abbiamo vissuto?
Come, noi non siamo in grado di dirlo e in un certo senso non lo sa nessuno. C’è un'altra parola che usiamo nel libro, che abbiamo imparato ad utilizzare prima noi e che vi proponiamo. Mettiamo per un po' tra parentesi la parola innovazione e usiamo la parola ‘trasduzione’. Gilbert Simondon, un filosofo francese, ha preso in prestito questo termine dalla biologia e lo ha esteso al comportamento umano. Perché suggeriamo di passare dal termine innovazione al termine trasduzione?
Il termine innovazione si collega alla nostra mente immediatamente al tema della tecnologia, dove pensiamo che l'innovazione sia l'innovazione tecnologica, nuovi strumenti, nuovi software... e questo è naturalmente importante, ma si porta dietro anche un’idea di essere umano che attraverso la tecnica cerca sempre più di dominare la natura, con il risultato di creare una società entropica.
Simondon usa il termine trasduzione, che non è semplicemente l’adattamento, ma è la capacità della cellula di dare una risposta non prevista di fronte a una perturbazione, una provocazione che viene dall'ambiente.
La parola trasduzione ha dunque in sé una logica relazionale, è una relazione.
Tra l'altro, ci aiuta a ripensare anche la sostenibilità, che potrebbe diventare la prossima parola di un bel regime: è molto probabile che tra 10 anni la Cina sia molto più sostenibile di noi occidentali. Perché la sostenibilità la puoi ottenere semplicemente aumentando la sorveglianza e amplificando ogni procedura.
Il problema invece, per quanto riguarda noi, l'occidente, i cristiani, i salesiani, Papa Francesco di certo, è chiarire che invece il contenuto che ci interessa della sostenibilità è riconoscere che noi siamo relazione e che tutti i danni che stiamo facendo nell'universo é perché invece ci siamo pensati come astratti dalla relazione, come individui separati, e come sovrani sulla natura. Questo è il tema: la sostenibilità può portare esattamente dalla parte opposta, per questo bisogna parlare di ‘sostenibilità integrale’ e chiarire bene che la sostenibilità significa riconoscere la costitutiva relazionalità dell'esistente. Perché tutto è in relazione con il tutto.
Anche rispetto alla questione della sostenibilità, dunque, trasduzione è un modo di pensare lo sviluppo dentro una logica relazionale, non dentro la logica impositiva dell'umanità che innova, che si mette il chip nel cervello per diventare ancora più intelligente. Perché il punto è che noi siamo palesemente, rispetto al livello di conoscenza di tecnologie che abbiamo raggiunto, inadeguati. La nostra macchina è obsoleta. E quindi bisogna intervenire su questa macchina. Questo è il punto.
Traduzione è anche una parola che ci aiuta a superare le false alternative, perché noi siamo abituati a ragionare in termini dicotomici. Per esempio a pensare di dover scegliere tra famiglia e lavoro, sostenibilità ambientale e profitto. Non che non esistano delle incompatibilità, delle tensioni, ma la trasduzione è proprio quel salto, non già iscritto nelle premesse, che ci fa trasformare un'apparente incompatibilità, data dentro una certa configurazione, in una configurazione nuova dove elementi apparentemente incompatibili sono entrambi incorporati in una forma nuova; una forma che non è un modello calato dall'esterno, ma che prende consistenza proprio a partire da ciò che c'è già.
Don Bosco, con il suo rifiuto di opporre santità e allegria, ha trasformato una apparente incompatibilità in un carisma. Che è quello che poi propone Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium.
Il cambiamento deve essere trasduttivo, cioè non deve sacrificare una parte del reale ma deve tenere questa complessità e questa paradossalità degli aspetti dell’umana esistenza e trasformarli nella ricerca di forme nuove, che non perdano niente di questa ricchezza. È chiaro che è una sfida difficilissima. Ogni forma che noi troveremo sarà sempre parzialmente inadeguata, e per fortuna, perchè così saremo sempre sollecitati a cercare forme nuove, a restare in cammino. Crediamo sia questa la strada: partire da ciò che c’è, non inventarsi dei modelli che non sono nostri o pensare che rispetto a ciò che c'è dobbiamo sacrificare alcuni aspetti in nome della sicurezza. Il tema della socialità, e di come re-immaginarla senza sacrificarla, dentro queste nuove condizioni, è una bellissima sfida.
Il rischio zero non esiste, perché la vita e la morte nell’essere umano sono sempre legate: quindi in qualunque cosa noi facciamo c'è un rischio, se noi agiamo. Il rischio zero non esiste perché chi non rischia è già morto, solo per chi è morto non c'è nessun rischio. Tutto questo a che fare con il re-immaginare, il ricominciare lasciandoci fecondare da ciò che c'è già e immaginando qualcosa che tenga insieme tutte le dimensioni dell’essere umano, senza sacrificarle in nome di una sicurezza che diventa un mito che ci consegna poi alla società della sorveglianza.
Qual è secondo voi la pista per riscoprire la potenza dell'affetto nostro nei confronti dei ragazzi, dei colleghi, delle persone con cui condividiamo le giornate nel compito educativo?
Perché al di là della didattica a distanza che tutti abbiamo vissuto e che stiamo continuando, c'è stato un lavoro fatto bene prima, che consiste nelle relazioni che si sono cucite insieme, che hanno poi permesso di vivere con fiducia tutto quello che c'è stato dopo. In classe si scopre che per quanto la cultura sia importante, per quanto le competenze facciano la differenza nelle proposte che facciamo, i ragazzi allo stesso tempo ci chiedono cose molto autentiche, e se per noi prima di tutto è vero il senso profondo di quello che gli stiamo dicendo, e cioè l'affetto con il quale abbiamo maturato le scelte della vita. Perché poi noi tutti, ai ragazzi vogliamo bene, ci sta a cuore il loro futuro. Qual è la strada per riscoprire questa intelligenza degli affetti? Una strada sulla quale parlare loro anche di Dio, di un Dio che non è giudice ma che li ama?
C’è bisogno di una rivoluzione epistemologica, perché noi siamo figli della cultura greca che é appunto una cultura dualista e separa ciò che è unito, mentre invece la sfida è tenere insieme ciò che è Unito. Questa separazione si è poi sviluppata con il pensiero scientifico nella conoscenza come distanza tra soggetto e oggetto: una separazione il più asettica possibile, dove la dimensione affettiva diventa un ostacolo alla vera conoscenza.
La rivoluzione epistemologica sta nel recuperare invece prima una dimensione dell'intero, perché non è soltanto l'intelletto fonte di conoscenza, e non è soltanto la distanza che tu metti tra te e l'oggetto, che ti consente una conoscenza vera, ma c'è una dimensione del riconoscimento e del coinvolgimento con l'oggetto senza la quale la conoscenza resta astratta e limitata. Serve anche la conoscenza dall'interno, la conoscenza da accanto, la conoscenza che muove tutte le dimensioni dell'essere umano, compresa quella emozionale, compresa quella affettiva; dove affetto viene da affectus, da afficere, da lasciarsi toccare, lasciarsi colpire, lasciarsi interpellare, lasciarsi anche modificare, mettere in movimento da ciò che si sta conoscendo.
Quindi la conoscenza non può essere qualcosa di asettico, qualcosa che lascia le cose uguali a com’erano prima, ma qualcosa che aprendo uno sguardo più profondo, ci mette in movimento. Tenendo conto che non passa nessuna transizione dei contenuti ormai fuori dalla relazione.
Il tema della fiducia è anche fondamentale, perché ha la stessa radice di fede e di legame (fides): tutto in qualche modo si tiene. E quando nella ‘scommessa cattolica’ parliamo della fede come affidamento, intendiamo esattamente questo movimento di scommettere sul legame che ci costituisce e che ci tiene. Quindi tutto questo apre veramente una prospettiva che non solo etica, ma anche epistemologica, che riflette su cosa vuol dire conoscere, quali dimensioni sono coinvolte nel nostro modo di costruire la conoscenza. Questo è un capitolo tutto da scrivere.
Abbiamo tutti un difetto di affezione, il problema c'è sempre stato in tutte le società e lo vediamo nel nostro tempo. Abbiamo tutti problemi di affezione.
L'essere umano è una separazione che tende verso l'altro: noi ci stacchiamo dal corpo della madre da cui veniamo e abbiamo come questa tensione per tornar verso l'altro. Questa è la dinamica costitutiva per come riusciamo a vederla oggi e in questa spinta il tema dell’affezione è fondamentale. Ma siamo tutti malati, facciamo una gran fatica a volere bene, pensateci.
Perché molte famiglie oggi sono luoghi di violenza? Tra confratelli, vi volete bene? Non solo il volere bene agli altri o vedere che qualcuno ti vuole bene. Non so se gli insegnanti qui hanno la percezione che qualcuno voglia loro bene. Pensate a tutto il tema della performance nella nostra società. I ragazzi lo sentono molto potentemente. Questa è una società che ti dice “devi essere all'altezza”. E se non sei all'altezza? Questo genera tutta una serie di meccanismi. All’interno dell'affezione c’è un tema centrale. Perchè è chiaro che in una società individualistica, siamo diventati consapevoli di ciascuno di noi, della nostra vita, della nostra realizzazione. Questo ci rende difficile voler bene, appassionarsi veramente. Ciascuno è troppo concentrati su di sé. Questo è un problema che abbiamo tutti, siamo come le foglie dei boschi che sono malate. Se viviamo in questa società facciamo fatica a voler bene. E dobbiamo pensare che le persone che abbiamo di fronte spesso sono portatrici di questa sofferenza, perché forse hanno fatto poca esperienza di voler bene.
Voler bene non vuol dire baci e abbracci: anche quello, ma soprattutto riuscire a prendere sul serio, per quel pezzo che si intreccia con noi, il destino di quella persona lì. Il destino della vita dell'altro, è il modo attraverso cui tu vivi la tua vita.
Noi che lavoriamo sul tema della generatività sociale, pensiamo al post covid. Pensiamo che sia venuto il momento nel 21 esimo secolo di dire, abbiamo fatto per un secolo e mezzo i produttori, siamo diventati bravissimi, produciamo delle cose fantastiche. Poi a partire dal dopoguerra abbiamo detto, dato che produciamo tutta questa marea di roba diventiamo consumatori, e abbiamo addirittura sviluppato delle nuove patologie psicologiche. Abbiamo creato questo mondo entropico e distopico. Io credo che il sogno che noi abbiamo è che è venuto il tempo di capire che l’azione più grande che gli uomini e le donne possano fare è amare mettendo al mondo altri. Il generare è molto più del produrre, è un orizzonte di senso e di futuro. Per questo noi parliamo di produzione e consumo, ma anche di generazione. Se mettessimo non retoricamente al centro il tema della generazione, come programma delle nostre scuole, delle nostre città, del nostro modo di vita, cambieremmo molte cose. Il voler bene passa dal gusto della generazione.
Versione app: 3.46.2 (85a32005)