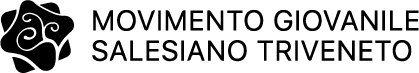Qual è la pietra angolare?
Oggi è spesso impossibile distinguere visualmente tra un cinema e una chiesa. Una delle ragioni per cui il pubblico reagisce contro l'architettura moderna è semplicemente che essa non offre un nuovo ordine visuale come sostituto agli stili 'svalutati' del passato. Ha creato certamente un nuovo 'vocabolario'...


Qual è la pietra angolare?
da Quaderni Cannibali
del 04 giugno 2009
Christian Norberg-Schulz, con molta schiettezza e una certa audacia – dato che si rivolgeva agli architetti –, scriveva agli inizi degli anni Sessanta: «Col passare del tempo risulta sempre più insoddisfacente che il linguaggio formale dell’architettura non sia differenziato in relazione ai diversi compiti edilizi. Oggi è spesso impossibile distinguere visualmente tra un cinema e una chiesa. Una delle ragioni per cui il pubblico reagisce contro l’architettura moderna è semplicemente che essa non offre un nuovo ordine visuale come sostituto agli stili 'svalutati' del passato. Ha creato certamente un nuovo 'vocabolario', ma per ora manca di una gerarchia di 'segni' significativi che possa servire ad esprimere la struttura sociale attuale». E aggiungeva: «Abbiamo bisogno anzitutto di una cosciente chiarificazione dei nostri problemi ossia della definizione dei nostri compiti edilizi e dei mezzi per risolverli ».
  Almeno per il bisogno di definire i suoi compiti edilizi, artigiano, tecnico o artista che egli pensi di essere, l’architetto, chiamato a progettare una chiesa, ha davanti a sé due precisi punti di riferimento: le intenzioni del committente e la tradizione. Anche se non di rado l’architetto li sente come elementi di disturbo, si tratta di due punti di riferimento che è impossibile raggirare, per delle ragioni piuttosto ovvie: è il committente che dovrà volere un complesso parrocchiale o una cattedrale o un monastero, un santuario o una cappella cimiteriale, la cappella di un ospedale o quella di un collegio, e così via. Sarà il committente che metterà a disposizione il denaro necessario, quello, non di più e non di meno. Sarà il committente che stabilirà la capienza e le funzioni in base alle quali lo spazio dovrà essere articolato. E via dicendo. La tradizione ugualmente si imporrà in maniera decisiva, non fosse altro perché i luogo sarà destinato alla conservazione e alla continua rivitalizzazione della memoria di fede dell’evento Gesù Cristo, di quello e non di altro.
  Per cui il progettista di una chiesa non potrà farsi determinare dalla sensibilità religiosa degli indù o dei musulmani, ma nemmeno da una certa sensibilità religiosa sua propria. Sarà inoltre la celebrazione dei sacramenti canonici della Chiesa cattolica (salvo che non si tratti di costruire per una comunità ortodossa o evangelica), e non un complesso di funzioni culturali generiche, e dover determinare la composizione dello spazio. Si tratta, come si vede, di fattori che, per quanto immersi nella fluidità della storia e dei suo continui cambiamenti, garantiscono alla comunità cristiana odierna la sua radicazione nell’evento originario, dal quale viene e dal quale è costantemente determinata la sua fede.
  Ambedue i punti di riferimento sono ineludibili, però non sono univoci e sono portatori al loro interno di una complessa problematica.
  La difficoltà del rapporto dell’architetto con il committente non è certamente una novità dell’oggi. Nel nostro caso, però, tutto si è enormemente complicato, perché il punto di riferimento della tradizione si è reso meno univoco che nel passato e l’architetto, oggi più che in altre epoche, è proteso ad affermare la sua autonomia e l’originalità della sua opera.
  L’autocoscienza della Chiesa e del suo rapporto con il mondo si è resa più dinamica, per non dire assai fluida, la sua prassi liturgica non più immobile, la sua soggettività meno concentrata nella persona del vescovo e del parroco e più inclusiva di tutti i membri della comunità. Ne deriva che quando la committenza, anche al suo livello più alto, avesse steso un prontuario delle norme regolanti l’articolazione degli spazi, in ordine alle celebrazioni liturgiche, come ha fatto la Conferenza Episcopale Italiana con una sua Nota del 1993, l’architetto non potrebbe fare a meno di mettersi ad auscultare lo stato d’animo, la sensibilità e le esigenze dei pastori e dei fedeli, per i quali egli deve approntare un luogo che essi abiteranno come la casa della loro fede. L’edificio della chiesa, inoltre, non ha solamente un potere significante per i fedeli, in ordine alla loro esperienza liturgica. Nel costruirlo, e poi nel fruirne, la comunità cristiana cerca e trova una sua autoidentificazione e vi si esprime in tutta la gamma delle manifestazioni della sua vita interiore e delle sue operosità e quindi lo riconosce e lo utilizza come un luogo e uno strumento del suo rapporto con la città in cui vive. Bisognerà quindi allargare l’auscultazione del committente a un’attenta analisi della società dentro la quale la comunità cristiana vive e opera. La tradizionale sapienza dell’architetto lo porterà con una certa ovvietà a misurare fin dall’inizio i volumi che egli intende realizzare in rapporto al contesto urbanistico in cui dovranno essere collocati e a calcolare con attenzione l’impatto che la sua opera eserciterà sul paesaggio. Ebbene, la stessa attenzione dovrà essere dedicata al problema del significato culturale e delle conseguenze spirituali e sociali dell’inserimento di una chiesa in un determinato contesto umano, perché il senso della chiesa non è un patrimonio riservato esclusivamente a coloro che ne fruiranno. Per avere un’idea dell’importanza di questo problema, basti pensare a quali dirompenti riflessi sulla società si ritrova ad avere la costruzione di una chiesa in una regione del pianeta non ancora raggiunta dalla predicazione del Vangelo e nella quale mai prima si sia registrata una presenza pubblica di una comunità cristiana.
  Nel costruire una chiesa e poi nell’abitarla si svolge un dialogo senza fine con chiunque vi entri e con chiunque vi passi davanti. È un continuo parlarsi tra di loro di tutti quelli che vi entrano: essi comunicano fra di loro, non solo quando vi si riuniscono per le loro svariate attività, ma anche quando vi celebrano la liturgia, vi ascoltano la parola di Dio, vi incedono in processione, vi sostano seduti, fanno il gesto corale di alzarsi insieme, rivolgono lo sguardo agli spazi, alle persone, alle cose, sono lambiti dalla luce o vengono nascosti nelle penombre, riempiono di canti lo spazio e ne colgono le sonorità.
 
Ma è anche un incessante dialogare fra coloro che vi entrano e quanti non intendono varcarne la soglia, fra quelli che ne escono e coloro che li osservano e fra tutti coloro che dal di fuori sentono come appartenente al loro tessuto sociale la comunità cristiana, alla quale però essi non intendono appartenere. Se tutto questo è vero, appare del tutto estravagante, anche se non di rado accade, che un architetto possa pensare di progettare una chiesa senza tenersi in stretto contatto con questo complesso, mobile e variegato committente, che è la comunità cristiana.
  È inevitabile che a questo punto si percepisca che in qualche modo viene messo in questione anche l’atteggiamento interiore dell’architetto stesso. A me sembra, a questo proposito, abbastanza obsoleta la querelle fra chi pretende che l’artista, il quale si accinga a progettare una chiesa o a dipingere un crocifisso, debba esser credente e coloro che non lo ritengono necessario. È vero però che costruttore del «proprio luogo» è fondamentalmente colui che intende abitarlo e disegnarvi la propria identità. In questo senso l’architetto primario della chiesa sembra non essere altri che la stessa comunità cristiana.
  Essa però chiama l’esperto, tecnico o artista che sia, a compiere l’opera, perché è simile a uno che deve scrivere una lettera d’amore ma non sa maneggiare la penna: lo scrivano sarà tanto bravo quanto risulterà capace di sentire con il vero autore della lettera, traducendo nei simboli linguistici e grafici i sentimenti e le intenzioni di lui, in ordine alla creazione di un determinato rapporto con il destinatario. Né l’architetto dovrebbe adombrarsi davanti a questa immagine: non è forse caratteristica di ogni artista proprio quell’abilità che risalta soprattutto nell’attore, il quale sa immedesimarsi talmente nel personaggio da esprimerne in maniera genuina la personalità, in tutti i suoi atteggiamenti, nelle parole e nei gesti, negli sguardi, nell’andamento del passo e in tutte le sue posture? Recitare la parte non è per lui una finzione, ma un vivere in quel momento con partecipazione interiore nella personalità di un altro, mantenendo viva la tensione fra la pura e semplice immedesimazione con il personaggio e il bisogno vitale di restare se stesso.
  L’architetto, il quale si accinga a progettare una chiesa, oltre che non avere più alle sue spalle un retroterra tradizionale delle forme spaziali, si ritrova, molto spesso, anche del tutto privo, nella sua formazione intellettuale, di una conoscenza adeguata della dottrina, della teologia e della spiritualità proprie del cristianesimo. È facile allora sentirlo affermare che la sua intenzione è quella di offrire all’uomo la sensazione di quel «sacro», fascinosum et tremendum, che gli studi di antropologia culturale e la psicologia del profondo ci hanno di delucidato, ma con il quale, in realtà, come vedremo meglio in seguito, il cristianesimo non ha molto a che fare e dal quale, anzi, Cristo ha inteso liberare l’uomo. Impostando su questa idea il suo lavoro, inoltre, l’architetto non sembra neppure sospettare di quel ben più ampio ed inventivo orizzonte egli stia privando il suo sguardo, qualora non estenda la sua ricerca ai grandi motivi ispiratori che gli vengono offerti dal contesto proprio della fede e della spiritualità cristiana. Anche Michelucci a San Marino non va esente da questa ricerca di un sacro precristiano, quando sembra volerci porre in attesa di una qualche teofania, propiziata dal carattere misterioso del luogo, o farci rientrare nell’utero materno, risultando così ancora catturato da suggestivi richiami alla psicologia del profondo, più che dal senso della fede in Cristo, morto e risorto.
  Le Corbusier per Ronchamp ha avuto un’attenzione scrupolosa ai grandi temi cristiani, che vedeva essere in gioco nella sua opera, eppure, reduce della curiosa esperienza di La Sainte Baume, in cui il progetto di una basilica sotterranea doveva essere ispirato dalla concezione orfica del committente e si intrecciava pericolosamente con il mondo esoterico legato alla leggenda di Maria Maddalena, non sembra essersene liberato del tutto. La figura della montagna sacra, l’oscurità della grotta, l’archetipo del grembo materno e altri fattori di questo genere sono in realtà molto lontani dal senso proprio della chiesa cristiana.
  Venticinque anni prima di costruire Notre Dame du Haut a Ronchamp, il 5 giugno 1929, Le Corbusier scrivendo a Madame De Salle, la quale avrebbe finanziato la costruzione di una chiesa affidandogliene la progettazione, esplicitava i motivi per i quali egli non si sentiva di accettare l’incarico: «Le nostre riflessioni ci hanno portato ad ammettere in tutta sincerità, che non possiamo costruire una chiesa cattolica: ciò per due ragioni. La prima è che, se vogliamo rispettare il culto cattolico e le sue tradizioni, possiamo solo «modernizzare» con il cemento una concezione preesistente. E questo ci risulta faticoso, poiché dovremmo creare organismi nuovi basati su nuovi problemi.
  La seconda è che, se seguiamo la via che ci è cara, pensiamo di creare un luogo di meditazione.
  Abbiamo condotto uno studio di principio su questo tema e abbiamo una soluzione che ci soddisfa. Ora, in un tale quadro, gli oggetti del culto cattolico appaiono paradossali. Ma più ancora, la concezione di un tale edificio. (...) Capirete che è la stessa essenza del grande interesse che abbiamo messo in tale questione che ci porta a un tale atteggiamento negativo».
  Egli percepiva con chiarezza che la sua concezione avrebbe provocato un conflitto «ancor più forte trattandosi di una religione in qualche modo canonica». Non si può che ammirare la lucida percezione del problema e la profonda onestà intellettuale di chi ha scritto queste righe.
 
In conclusione, se si intende veramente dare all’edificio della chiesa una forma che sia innovativa e contemporanea, ma che non rinunci a farne una viva espressione della grande tradizione della fede cristiana, bisognerà curare il superamento di due limiti che oggi sembrano compromettere, non di rado, la realizzazione dell’intento.
  Bisogna che risulti chiaro che la forma cristiana del rapporto con Dio è essenzialmente determinata dalla memoria di Cristo e non dagli archetipi del profondo della psiche, anche se questi esercitano pure un loro ruolo nella sua simbolica. In secondo luogo, se sarà la liturgia, con il suo patrimonio di idee e di forme, a comandare l’articolazione dei luoghi e l’atmosfera dello spazio, non potrà esserlo da sola. Da qui deriva un’esigenza metodologica importante: non si può progettare una chiesa andando solo alla ricerca delle emozioni del sacro, né esclusivamente studiando la sua funzionalità liturgica. Attraverso i suo manufatti architettonici la Chiesa parla agli uomini e questo suo particolare linguaggio risalta per il suo evidente carattere pubblico: costruire la propria casa, abitarla, entrarvi e uscirne significa collocarsi sulla piazza delle città e imporre alla società la propria presenza. Prima di collocare il proprio edificio nel quartiere o nel villaggio, la Chiesa deve quindi domandarsi come essa intenda presentarsi pubblicamente al mondo, quale sua identità voglia manifestare e quali relazioni intenda allacciare con tutte le diverse espressioni umane che occupano il territorio.
 
 
Severino Dianich
Versione app: 3.46.2 (85a32005)