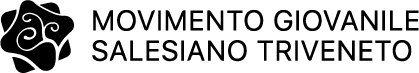8. “IO DEVO STUDIARE”

8. “IO DEVO STUDIARE”
Quando fa fagotto e saluta il signor Roberto, Giovanni non ritorna ai Becchi. Va al Sussambrino, una cascina che suo fratello Giuseppe, insieme a Giuseppe Febraro, ha preso a mezzadria. Anche Margherita ha lasciato i Becchi insieme al figlio.
Giovanni dedica quei mesi estivi a studiare con intensità. A Chieri non vuole trovarsi svantaggiato.
Ma non vuole nemmeno essere di peso eccessivo al fratello. Per questo lo aiuta nei lavori della campagna, su una forgia rudimentale ripara gli strumenti agricoli, porta al pascolo le mucche. Quest'ultimo lavoro gli permette di leggere e di studiare.
Rosa Febraro, figlia di Giuseppe, ricordava che Giovanni era sovente così preso dai suoi libri, che le mucche se ne andavano per conto loro. Era lei, ragazzetta di dieci anni, a corrergli dietro nei campi, tra i solchi di granturco, e a riportarle allo studente prima che i padroni protestassero.
- Le tue mucche stavano mangiando la meliga.
- Grazie, Rosa -. Lei lo guardava a lungo, poi:
- Ma perché le porti al pascolo se poi non le guardi?
- Devo studiare, Rosa, e ogni tanto la mente mi scappa.
- È vero che diventerai prete? - Sì.
- Allora, se vuoi, le mucche te le guardo io. Tanto devo già guardare le mie. Giovanni la ringraziava, e si rituffava nelle pagine.
Un sogno che ritorna
A Castelnuovo, Giovanni era diventato amico di un compagno di scuola, Giuseppe Turco. Il padre di Giuseppe era il padrone della Renenta, un podere che confinava con il Sussambrino. Brav'uomo e bravo cristiano, quel contadino qualche volta gli passava accanto mentre studiava:
- Forza Giovanni, che stavolta ce la fai.
- Grazie, signor Turco. Lo spero proprio. Ho solo paura che mia madre non ce la faccia a pagare la pensione a Chieri.
- Ma c'è il Signore, no? Se lui vuole, vedrai che ti spiana la strada.
- Speriamo. Però ho sempre paura.
Era un sorriso mesto, quello che portava sulla faccia. Difficile dargli torto, gliene erano andate male troppe.
Ma un giorno, il signor Turco e suo figlio lo videro correre eccitato e felice:
- Buone notizie - disse -. Stanotte ho fatto un sogno. Ho visto che diventerò prete e che mi occuperò di tanti ragazzi.
- È solo un sogno, però - osservò perplesso il signor Turco.
- Voi non potete capire. A me basta così. Stavolta ce la farò sul serio.
Nella notte gli si era spalancata ancora davanti la valle del sogno dei nove anni. Aveva rivisto il gregge, la Signora splendente che glielo voleva affidare. “Renditi umile, forte e robusto - gli aveva ripetuto - e a suo tempo tutto comprenderai”.
Durante l'estate, il paese di Montafia celebrava la sua festa patronale. Non era lontano. Giovanni seppe che c'era l'albero della cuccagna, e che tra i premi avevano messo una borsa con venti lire.
- Mi farebbero proprio comodo - pensò. E andò alla festa. Il palo era altissimo, liscio e unto con olio e grasso. I giovanotti del paese guardavano il cerchio di ferro lassù in alto, che lasciava ondeggiare pacchetti, salumi, bottiglie di vino, e la borsa. Ogni tanto qualcuno, tra le urla della gente, si sputava sulle mani e tentava la scalata. Partivano in quarta, ma a metà erano spompati, e scivolavano giù tra fischi e berci.
A un tratto, studiata bene la situazione, si fece sotto Giovanni. Si sputò anche lui sulle mani e si avvinghiò al palo. Cominciò a salire lento e calmo. Ogni tanto si sedeva sui calcagni a prendere fiato. La gente gridava impaziente, aspettava che anche lui si arrendesse. Ma a Giovanni premevano troppo quei soldi. A Moncucco lavorava un anno per quindici lire, e lì, a pochi metri dalla sua testa, ce n'erano venti. Era disposto a passare la giornata intera su quel palo, se occorreva.
Procedendo sempre con calma arrivò dove l'albero si faceva sottile. Prese ancora fiato, poi le ultime bracciate. La gente, ora, guardava su in silenzio. Giovanni allungò la mano, staccò dal cerchio la borsa con le venti lire, se la pose tra i denti. Poi staccò ancora un salame e un fazzoletto, e scivolò giù.
La ripugnanza di stendere la mano
Le venti lire dell'albero della cuccagna non potevano certo bastare per il trapianto a Chieri. Bisognava comprare abiti, scarpe, libri. Occorreva soprattutto pagare una pensione mensile. E la mezzadria del Sussambrino non era una miniera d'oro. In ottobre, Giovanni disse alla madre:
- Se siete contenta, prendo due sacchi e vado a fare una colletta tra le famiglie della borgata.
Era un sacrificio duro per il suo amor proprio. Don Bosco diventerà il più grande “mendicante” del diciannovesimo secolo, ma gli costerà sempre chiedere l'elemosina. In quell'ottobre vinse per la prima volta la ripugnanza a stendere la mano.
La frazione di Morialdo è la somma di piccole borgate e di casolari sparsi. Giovanni girò di casa in casa. Bussava alla porta. Diceva:
- Sono il figlio di Margherita Bosco. Vado a Chieri a studiare da prete. Mia madre è povera. Se potete, aiutatemi.
Lo conoscevano tutti. Avevano assistito ai suoi giochi, l'avevano sentito recitare la predica, gli volevano bene. Ma pochi erano benestanti. Gli diedero delle uova, del granoturco, qualche misura di frumento.
Una coraggiosa donna dei Becchi che si recò in quei giorni a Castelnuovo, andò dritta dal parroco don Dassano. Gli disse che era una vergogna non aiutare negli studi un così bravo ragazzo e lasciarlo andare a elemosinare di casa in casa.
Don Dassano non ne sapeva niente. Credeva che Giovanni in novembre avrebbe ripreso gli studi a Castelnuovo. Si informò, e conosciuta con esattezza la decisione, raccolse una piccola somma e la mandò a Margherita. Le fece anche dire di venire a parlare con Lucia Matta, una vedova che stava trasferendosi a Chieri per assistere suo figlio studente.
Fu un consiglio buono. Margherita parlò con questa donna, e si misero d'accordo che Giovanni, a Chieri, avrebbe abitato con lei e con suo figlio. La pensione doveva essere di ventun lire al mese.
Margherita non poteva pagarla tutta in denaro, ma si obbligò a fornire farina e vino, e Giovanni si impegnò a fare da servitore in casa: portare l'acqua, preparare la legna per il fuoco e la stufa, stendere la biancheria.
Negli ultimi giorni di ottobre, Giovanni si presentò al parroco di Castelnuovo per ottenere l'Admittatur. Per poter essere iscritto alle scuole pubbliche, ogni giovane doveva ottenere l'attestato di buona condotta dal parroco, che s'impegnava anche a vigilare sulle sue vacanze, e a segnalare la sua eventuale cattiva condotta.
Questa disposizione era stata emanata dal re Carlo Felice, che proprio in quell'anno era morto a Torino, dopo essere stato ribattezzato dai “liberali” Carlo Feroce.
La storia aveva camminato
Mentre Giovanni Bosco aveva vissuto la sua difficile fanciullezza tra le colline di Castelnuovo, la storia aveva camminato. Non intendiamo (come già nelle pagine precedenti) fare un quadro esauriente della storia italiana. Ma ci pare indispensabile tracciarne alcune linee essenziali, perché è su questo sfondo che si svolge la vicenda personalissima di Giovanni Bosco. È anche da questa storia che egli si nutre di impressioni, idee, sensibilità.
Contro la restaurazione rigida e codina dei principi, negli anni 1815-20 si erano diffuse in tutta l'Italia le società segrete che preparavano ribellioni e rivoluzioni.
Nel gennaio del 1820, una scintilla si era sprigionata in Spagna. A Cadice, una rivolta militare aveva costretto Ferdinando VII a mettere fine al suo assolutismo e a concedere una Costituzione: una legge cioè che garantiva a ogni persona le principali libertà e il diritto di voto. All'osservanza della Costituzione si obbligava anche il re mediante giuramento.
La scintilla fece scoppiare l'incendio in Italia sei mesi dopo. Un piccolo reparto di cavalleria, nel Regno delle due Sicilie, insorse al grido: “Viva la libertà e la Costituzione”. Entro otto giorni, per non perdere il regno, Ferdinando di Napoli concesse la Costituzione di Cadice, e giurò sul Vangelo di rispettarla.
Il 10 marzo 1821 (Giovanni Bosco aveva sei anni) la rivolta militare cominciò anche in Piemonte, agli ordini del conte Santorre di Santarosa. Alessandria ammainò la bandiera azzurra dei Savoia e issò sulla cittadella il tricolore (che ricordava la Rivoluzione Francese e i diritti dell'uomo da essa proclamati). Anche le guarnigioni di Pinerolo e Vercelli si sollevarono. Da Fossano un colonnello marciò su Torino alla testa di un reggimento.
Re Vittorio Emanuele si precipitò atterrito da Moncalieri a Torino, radunò il Consiglio della corona, e si sentì suggerire di concedere la Costituzione per non perdere tutto. Stava per farlo, quando giunse notizia che l'Austria aveva deciso di intervenire in Italia “per ristabilire l'ordine”.
Sopraffatto dagli avvenimenti, Vittorio Emanuele rinunciò al trono in favore del fratello Carlo Felice. E siccome in quel momento egli era a Modena da suo suocero, dichiarò “reggente” il giovane principe Carlo Alberto (ventitré anni).
“Riferite al Principe”
Carlo Alberto era stato parecchie volte in contatto con Santarosa, ne apprezzava le idee, ma non aveva mai saputo decidersi per l'assolutismo o per i “liberali”. Si manifestava già in lui il carattere incerto che gli avrebbe meritato il titolo di “Re Tentenna”. Una cosa voleva a tutti i costi: conservare il suo diritto al trono, difendendolo sia dagli Austriaci sia dai liberali.
Davanti a una grande folla che sotto le finestre di palazzo Carignano reclamava la Costituzione (ma chissà quanti sapevano cos'era), Carlo Alberto cedette. La sera del 13 marzo firmò la Costituzione di Cadice, e due giorni dopo giurò di rispettarla. Costituì un nuovo governo, in cui Santarosa era ministro della guerra.
Quando Carlo Felice ricevette a Modena una lettera di Carlo Alberto che gli riferiva ogni cosa, andò sulle furie. Gridò al cavaliere Costa, che gli aveva portato la lettera: «Riferite al Principe che, se nelle sue vene c'è ancora una goccia del nostro sangue reale, parta subito per Novara, e attenda là i miei ordini».
Carlo Alberto, in un primo tempo, sembrò deciso a resistere, ma da Napoli giunsero notizie catastrofiche: un esercito austriaco aveva sconfitto le truppe liberali, il Parlamento era sciolto, il regime costituzionale abbattuto. Il giovane principe si ritirò a Novara. Di lì emanò un proclama in cui rinunciava alla “reggenza” e invitava tutti a sottomettersi al Re. Subito dopo partì per Firenze in esilio.
Il ritorno di Carlo Felice in Piemonte fu preceduto da un esercito austriaco, che sbaragliò i volontari di Santarosa e “ristabilì l'ordine”. Settanta capi della rivolta furono condannati a morte (sessantotto però erano già fuggiti in Svizzera e in Francia), trecento ufficiali e trecento funzionari civili furono epurati, le Università di Torino e di Genova chiuse per un anno. “Tutti quelli che hanno studiato all'Università sono corrotti - scriveva Carlo Felice al fratello in esilio -. I cattivi sono tutte persone istruite, e i buoni sono tutti ignoranti”.
I “moti del 1821”, come vennero chiamati dai libri di storia, furono avvenimenti che coinvolsero unicamente la borghesia, i ceti medi della popolazione. Le masse dei contadini e gli operai rimasero del tutto indifferenti, qualche volta addirittura ostili. I ceti medi (commercianti, piccoli imprenditori, piccoli industriali, funzionari civili e militari) con la “rivoluzione liberale” miravano a trasformarsi in gruppo di potere al posto della vecchia aristocrazia. Le riforme invocate (e sancite dalla Costituzione di Cadice) non erano né popolari né democratiche. Il diritto di voto veniva concesso soltanto a quelli che avevano una certa fetta di ricchezza: essi soli potevano mandare i loro rappresentanti al Parlamento, a difendere, evidentemente, i loro interessi. Come già la rivoluzione francese, la rivoluzione liberale voleva abolire tutti i privilegi eccetto uno: la ricchezza.
“Re per grazia di Dio e di nessun altro”
Carlo Felice rientrò a Torino soltanto nell'ottobre del 1821. Ad accostarla oggi, questa figura è curiosa e singolare. Non aveva mai desiderato essere re. Amava la vita ritirata e modesta ed era religiosissimo. Accettò il trono unicamente come un “dovere di coscienza”.
Ma dal momento in cui l'accettò, fu conseguente fino in fondo alle sue idee di “rigido assolutismo”. Egli si sentiva re “per grazia di Dio e di nessun altro”, e intendeva governare il suo popolo come un padre severo deve governare una famiglia di figli scapestrati. Nessuna idea era più lontana dalla sua mentalità della “sovranità del popolo” (principio elaborato dagli illuministi del 1700 e proclamato dalla rivoluzione francese): il re era lui, non il popolo.
Affidò il monopolio della pubblica istruzione al clero. Alla curia di Torino e ai vescovi affidò la censura dei libri. Impose nelle scuole un regime severo, l'insegnamento quotidiano del catechismo, la preghiera prima e dopo le lezioni. Le scuole che Giovanni Bosco frequenterà a Chieri (quattro anni alla scuola pubblica, sei anni al seminario), i libri che leggerà, gli orari che gli saranno imposti, le istituzioni in cui dovrà vivere, porteranno tutte il “marchio di fabbrica” di Carlo Felice.
Il re ricacciò pure nel ghetto gli ebrei, togliendo loro i diritti riconosciuti dal Codice Napoleonico. Approvò regolamenti militari che stabilivano tra le altre cose: “Il soldato autore di grida o discorsi sediziosi andrà soggetto da cento sino a centoventi bastonate, in due volte con un giorno di riposo intermedio” (Regolamento dei Cacciatori Franchi). Volle che ogni condanna a morte fosse una “salutare ammonizione” a tutte le teste calde, e conseguentemente approvò “l'applicazione delle tenaglie infuocate” al condannato che veniva portato al supplizio. Per questo particolare fu bollato con il soprannome di “Carlo Feroce”.
Carlo Felice non capì mai quello che un anonimo manifesto (redatto da Brofferio e Durando) gli gridò dai muri di Torino: “Maestà, i vostri sudditi non sono più cose, ma persone”. Per lui erano sudditi e basta, cioè gente che doveva tenere sulla “retta via” con le maniere forti. Massimo D'Azeglio definì i suoi dieci anni di regno con otto parole: un dispotismo pieno di rette e oneste intenzioni.
Morì nell'aprile del 1831, lasciando il trono a quel Carlo Alberto che aveva continuato a chiamare “pollone degenere della nostra famiglia”. Aveva appena fatto in tempo a sentire le inquietanti notizie di Modena, Parma e Bologna: i liberali (come l'anno prima a Parigi) si erano nuovamente ribellati ai principi assoluti. L'Austria aveva dovuto mandare i suoi eserciti a schiacciare la rivolta comandata da un industriale, Ciro Menotti, e da un generale, Carlo Zucchi. Si temeva anche l'invasione della Savoia da parte di una legione di volontari raccolti a Lione, ma erano stati dispersi dalla polizia francese.
“Lungo e triste come una quaresima”
Sul trono di Torino gli succede Carlo Alberto, 33 anni. Si è rifatto un “nome pulito” davanti agli assolutisti e ai reazionari combattendo in Spagna contro i liberali, ed essi l'hanno ricambiato chiamandolo nei loro scritti “traditore” e “spergiuro”.
È un uomo pallido e altissimo (2 metri e 4 centimetri), e il popolino piemontese lo dice “lungo e triste come una quaresima”. Per dimostrare a tutti che non è più il principe che ha firmato la Costituzione, nel 1833 farà fucilare sette mazziniani ad Alessandria e dodici a Genova, e ne condannerà una settantina alla galera.
Ma il Piemonte e l'Italia, nonostante i tentativi di fermare la storia, sono cambiati. La borghesia è diventata una classe veramente importante, e se anche non capisce che cosa sia la « libertà democratica », ha bisogno della « libertà commerciale » per diffondere in tutta la penisola un maggior benessere.
In Piemonte si tracciano canali, si bonificano paludi, si disboscano le Langhe, si estende la coltura del gelso, della canapa, della vite. Si diffonde la coltivazione della patata, che finalmente metterà fine alle carestie ricorrenti e terribili negli anni di siccità. Si aprono una trentina di miniere di ferro, si sviluppa l'industria delle ceramiche. Bra diventa il centro della concia delle pelli, Cuneo è il primo mercato europeo del bozzolo da seta. Appena Carlo Alberto abbassa i dazi della lana, il Biellese diventa sede di una industria laniera fiorente: si sviluppano le filande, nella regione entrano le prime pecore « merinos ».
Presto si avverte l'urgenza di sviluppare la rete stradale, di dare inizio alla costruzione delle ferrovie.
Pure la mentalità politica tende inesorabilmente a modificarsi.
Negli ultimi mesi del 1831, a Marsiglia, Mazzini fonda la « Giovane Italia ». Si diffonde l'idea di un'Italia « stato nazionale », individualità storica dotata di sue tradizioni culturali e popolari, con diritto alla libertà e all'indipendenza. Gli italiani si rendono progressivamente conto che hanno un destino comune, e che devono diventare arbitri di questo destino, insieme o al posto dei re, che finora li hanno considerati un gregge di minorenni incapaci.
A Torino, nel 1832, Silvio Pellico pubblica Le mie prigioni, un libretto che scuote l'Italia e la fa ragionare in maniera diversa. L'Austria, che fino a quel tempo è sembrata la custode dell'ordine e del buon vivere sociale, perde la faccia. Nelle pagine miti e meste dello scrittore saluzzese, che ha passato dieci anni nelle galere imperiali, il governo austriaco mostra il volto feroce della dittatura che reprime e tortura.
Versione app: 3.46.2 (85a32005)