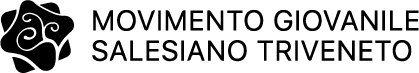News 5
Il cento e il cinque
Oltre la crisi, recuperando visione e capacità generativa. Anche dei capitali.
Il cento e il cinque
Le crisi, soprattutto quelle profonde e gravi, sono un segnale che una comunità civile o economica sta esaurendo la sua capacità generativa, e non è più capace di creare vero valore economico, civile, politico, culturale, scientifico, perché ha smarrito i suoi valori, non sa più ciò che vale. C’è una regola generale al cuore della legge di evoluzione delle civiltà e della loro economia: la forza generativa dell’uso civile delle ricchezze si spegne quando raggiunge il suo culmine, perché i successi e i frutti finiscono col tempo per spegnere quella fame di vita e quella speranza che li aveva generati. Ciò non è solo evidente dall’analisi storica: è sufficiente recarsi ogni tanto in Cina – dove mi trovo ora –, nelle Filippine, o in Brasile per vedere che la radice del loro (attuale) sviluppo economico e civile prende linfa vitale dall’entusiasmo civile e dalla volontà di riscatto individuale e sociale, che si esprimono anche in quella gioia di vivere che si respira nelle strade, soprattutto tra i poveri e i bambini.
Queste risorse morali e spirituali si consumano, ma non si rigenerano da sole, e così dopo periodi più o meno lunghi finiscono. È una legge spietata ma anche provvidenziale, perché è anche un grande meccanismo che fa sì che non siano sempre gli stessi a salire sulla giostra del benessere e della prosperità. Sul piano economico-civile tutto ciò fa sì che nelle fasi civilmente positive ed espansive i capitali (stock) siano al servizio dei redditi (flussi): sono i terreni, le case, gli immobili, i risparmi, i titoli azionari a essere in funzione dei redditi da lavoro (salari) e d’impresa (profitti). In queste fasi felici i capitali esistono e sono importanti, ma questi capitali sono messi a reddito, sono fatti girare e fruttare per lo sviluppo e per il bene comune.
La virtù dominante in questi periodi civilmente fecondi è la speranza, che porta a guardare i capitali (reali e finanziari) come strumenti da mettere in gioco, come talenti da trafficare perché portino frutto. Si guardano gli stock in vista dei flussi. Si vedono i 'cento' del valore del capitale di oggi, ma si vedono di più i 'cinque' che quei cento ben investiti potranno produrre, perché quel reddito/ flusso è un segnale della capacità generativa della mia azienda, della mia vita. Il primo senso del buon grano non è mai l’accumulazione nei granai. È anche questa la differenza tra contadino e mercenario, tra investimento e pura accumulazione, e tra l’imprenditore, il protagonista delle fasi espansive, e lo speculatore, protagonista di ogni declino.
La ricchezza generativa di redditi rende felici e fecondi, mentre la ricchezza accumulata per se stessa rende miseri e sterili. Quando la cultura latina voleva rappresentare la felicitas i suoi simboli e le sue immagini erano i raccolti fecondi (Campania felix), gli strumenti del lavoro, e i bambini, che ieri come oggi sono il primo segno della fecondità felice di famiglie e popoli. Tutto questo lo sa bene anche la grande cultura dei popoli con la sua arte: essi quando hanno voluto rappresentare l’icona dell’infelicità l’hanno individuata più nell’avaro che nel povero, perché l’avaro è un ricco misero che non conosce – lui con i suoi averi – la fioritura e la fecondità, come i capitali (de)portati oggi nei paradisi fiscali.
Un’impresa, un sistema economico, una civiltà iniziano allora la loro decadenza quando il nesso tra capitali e frutti si inverte, e lo scopo dei capitali diventano i capitali. Alla speranza subentra la paura, il senso del grano diventa il granaio e ci si dimentica di chi di quel grano ha bisogno per vivere, e per lavorare. Nel linguaggio dell’economia la grande crisi inizia quando i redditi (flussi) sono visti in funzione dei capitali (stock), i profitti e i salari in funzione delle rendite. Così gli imprenditori si trasformano in speculatori, le élite che avevano determinato la fase virtuosa del ciclo economicocivile diventano caste, che destinano le loro energie a conservare i privilegi acquisiti nei tempi passati. Nei periodi felici prevalgono la fiducia e la cooperazione, e si guarda agli altri come potenziali partner per nuove comuni intraprese. Nelle fasi di declino ci si guarda attorno con sospetto, e il vicino diventa un rivale, un nemico che può sottrarci una fetta di quelle rendite. I rapporti sociali si incattiviscono, gli altri (non noi) sono tutti evasori e disonesti, e il loro benessere diventa una minaccia per il nostro.
E invece, nei periodi migliori, proprio «il mercato ci insegna a vedere con benevolenza la ricchezza e il benessere degli altri» ( John Stuart Mill, 1848), perché contano le nuove torte, e non la dimensione delle fette di quelle che abbiamo creato in passato. In Italia oggi riusciamo a fare perfino di peggio: «Riusciamo a litigare per spartirci future torte che non creeremo mai», mi confidava un imprenditore siciliano.
La nostra crisi dice allora che stiamo dilapidando i capitali di valori civili e religiosi che avevano operato i miracoli economici e sociali dei decenni passati.
Serve un nuovo miracolo economico, civile, morale. Dopo la seconda guerra mondiale i nostri genitori e nonni presero le macerie prodotte da umanesimi fratricidi e, con i loro valori, le fecero diventare mattoni, pietre angolari delle loro nuove case e della casa europea. Se oggi vogliamo vedere un presente e un futuro possibili, e magari migliori, dobbiamo trovare le risorse per trasformare le nostre macerie in una nuova casa e in una nuova eco-nomia. Le nostre macerie non sono fatte di cemento e calce, ma anche questa crisi sta, a modo suo, distruggendo case, fabbriche, chiese, sta mietendo le sue vittime, ha i suoi eroi e la sua Resistenza.
Dobbiamo trovare le risorse per raccogliere le macerie e trasformarle in nuovi mattoni. E dobbiamo scavare molto, perché le pietre migliori non sono in superficie: sono ancora in parte sepolte, o ignorate, perché – come la nostra vocazione comunitaria – considerate pietre d’inciampo, e scartate. Occorre salvarle, facendone le pietre angolari della nuova casa, della nuova economia, del nuovo lavoro.
Luigino Bruni
Versione app: 3.13.5.6 (1e5e7c1)